di Claudio Vercelli
Dalla presa di Berlino – al seguito dell’Armata Rossa – fino alle battaglie più importanti della Seconda Guerra Mondiale, da Mosca a Stalingrado. I suoi occhi videro tutto, testimone oculare delle nefandezze del XX secolo. Le cronache di guerra e il dolore delle genti, l’anatomia della distruzione e la deriva sanguinaria dei totalitarismi. Esule “interiore” del bolscevismo sovietico, la sua parabola esistenziale ci parla dell’oggi e di cosa significhi la “lotta per la libertà”
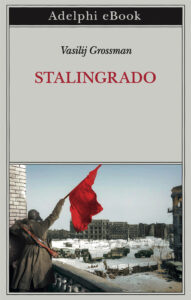 Beneficiato di una tardiva gratitudine, quindi molti anni dopo la sua morte, avvenuta nell’oramai lontano 1964, Vasilij Semënović Grossman è oggi invece un po’ ovunque riconosciuto come colui che meglio ha saputo offrire una prospettiva di interpretazione letteraria, ma anche cronachistica e quindi anatomica, del fenomeno dei totalitarismi del Novecento. A tale riguardo, si inserisce a pieno titolo in quel pantheon che già annovera autori diversi per ispirazione e ragioni e che tuttavia hanno lasciato un segno permanente nelle interpretazioni del secolo trascorso. Solo per fare qualche rimando, tra di essi si possono annoverare le figure di Hannah Arendt, di Leo Strauss, di Arthur Koestler, di George Orwell, di Albert Camus e così via. Basti poi pensare che una non piccola parte di questi, e tra di loro il medesimo Grossman, erano ebrei.
Beneficiato di una tardiva gratitudine, quindi molti anni dopo la sua morte, avvenuta nell’oramai lontano 1964, Vasilij Semënović Grossman è oggi invece un po’ ovunque riconosciuto come colui che meglio ha saputo offrire una prospettiva di interpretazione letteraria, ma anche cronachistica e quindi anatomica, del fenomeno dei totalitarismi del Novecento. A tale riguardo, si inserisce a pieno titolo in quel pantheon che già annovera autori diversi per ispirazione e ragioni e che tuttavia hanno lasciato un segno permanente nelle interpretazioni del secolo trascorso. Solo per fare qualche rimando, tra di essi si possono annoverare le figure di Hannah Arendt, di Leo Strauss, di Arthur Koestler, di George Orwell, di Albert Camus e così via. Basti poi pensare che una non piccola parte di questi, e tra di loro il medesimo Grossman, erano ebrei.
Di fatto, il più delle volte, nella loro traiettoria personale l’elemento di comunanza che spicca come fattore di inconsapevole saldatura è il rapporto tra fervente speranza, nutrita essenzialmente nei confronti del comunismo, e sopravvenuta disillusione nel corso del tempo.
Il legame tra utopia e distopia, tra attesa messianica e brutalità della rivelazione, è un tratto caratteristico di un tale milieu culturale. Molti di questi (ed altri) autori, spesso tra di loro non hanno intrattenuto alcuna relazione materiale o personale. Non si conoscevano né, tanto meno, si frequentavano, con l’eccezione di alcuni intellettuali tedeschi antinazisti, riparati negli Stati Uniti, quanto meno finché fu possibile, con l’inizio della guerra, nel 1939. Hanno quindi operato singolarmente, con la forza esclusiva delle loro parole. Alcuni hanno pagato molto caro un tale anelito di indipendenza e libertà.
Resta il fatto che rimangano tra i migliori testimoni del tempo in cui si è formata la visione del mondo alla quale, oggi, sia pure con assai minore ingenuità del passato (ma anche con un senso di maggiore deprivazione) interpretiamo il nostro presente.
La visione di un esule dell’utopia
Vasilij Grossman, per l’appunto, ci aiuta a interpretare non solo quello che fu, come tale quindi consegnato ai trascorsi, ma anche ciò che si accompagna ai giorni correnti. La sua parabola esistenziale è, in fondo, quella di molti “esuli interiori” dal bolscevismo sovietico. Ad un primo momento di adesione, peraltro durato fino alla fine della guerra nazifascista che sconvolse i territori dell’Est (1941-1944), seguì infatti un periodo di bonaccia, con il veloce riflusso del dopoguerra, e poi il riscontro che i deliri di Stalin non erano solo parte delle fantasie di un dittatore ma elemento costitutivo dei regimi a “socialismo reale”.
Un’amara scoperta, posto che tutto ciò doveva raccordasi, tanto più a quell’epoca, con la duplice consapevolezza della ferocia dei fascismi e della debolezze delle democrazie.
L’opera di Grossman nel suo contesto
Parlare quindi dell’opera di Grossman implica avere questo retroterra di consapevolezze storiche, civili e morali. Non si tratta di alzare con troppa facilità il dito accusatore ma di cogliere il tempo e il contesto. Quel comunismo, che per molti ebrei dell’Est era la promessa di una liberazione, si era in realtà trasformato nella concretezza di un’occupazione permanente: degli spiriti, delle speranze, dei corpi e, con essi, delle prospettive di vita.
Da qui, pertanto, bisogna partire. Vasilij Grossman era originario di Berdyčiv, una cittadina dell’Ucraina che costituiva uno dei fondamentali centri socioculturali dell’ebraismo ashkenazita. Nato nel 1905, anno della prima rivoluzione russa, di fatto crebbe alla luce (così come all’ombra) del bolscevismo. Ovvero, della sua presa su quei popoli che aspiravano invece ad un’emancipazione da ataviche servitù. La sua formazione, essendosi laureato come ingegnere chimico a Mosca (città alla quale era profondamente legato, insieme a Kyiv), era tipica di un tecnico consegnato all’ideologia produttivistica del regime. Da ciò, sia pure a modo suo, se ne discostò quando scoprì che la sua vera vocazione era la scrittura. Non quella intimista. Bensì popolare e, al medesimo tempo, riflessiva.
Anche per queste ragioni ben presto rivelò il suo talento di cronachista. Che non è solo quello di colui che racconta i fatti ma di chi sa come renderli, nello stesso momento, intellegibili e condivisibili per i tanti lettori che sfogliano le pagine del giornale sul quale scriveva i suoi articoli quotidiani. Grossman, divenuto corrispondente di guerra per la testata più importante delle forze armate sovietiche, il quotidiano Stella rossa, di fatto fu quindi tra le punte di lancia del giornalismo moscovita. Qualcuno al quale gli stessi poteri assisi al Cremlino guardavano con interesse, in quanto volano e moltiplicatore dei temi di quella che sarebbe poi stata conosciuta come “grande guerra patriottica”, ossia la resistenza delle collettività dell’Est, beninteso non solo di quelle militari, all’invasore nazista.
Seguì, in presa diretta, ossia al fronte, tutte le battaglie più importanti, da quella del tardo autunno del 1941 per la presa di Mosca (tradottasi nella prima, grande sconfitta dei nazisti) fino all’arrivo dei sovietici a Berlino, nella primavera del 1945. In tale ruolo, quello di esegeta, oltre che di cronista, di un conflitto apocalittico, nel quale circa venticinque milioni di cittadini sovietici persero la vita, venne pertanto a contatto con tutte le nefandezze della guerra: i campi di sterminio, la distruzione di intere comunità umane, la Shoah, il razzismo di Stato tedesco e tanto altro. Il suo sforzo rimase comunque quello di riuscire a tradurre in parole ciò che, di giorno in giorno, poteva vedere con i suoi stessi occhi. Che erano, per molti lettori del tempo, gli occhi di un’intera collettività. Quindi, non attraverso gli uffici stampa ma seguendo, passo dopo passo, la resistenza russa al fronte. Tra i molti militari, inquadrati nelle armate sovietiche, e gli innumerevoli civili.
 Tutta la scrittura di Grossman – peraltro – trasuda di sangue, carne, sudore, terra. Non concede nulla al clamore della circostanza. Semmai, descrive la caduta negli abissi delle popolazioni invase e assoggettate, il loro tedio, le angosce quotidiane, il senso della morte così come della residua speranza di vita.
Tutta la scrittura di Grossman – peraltro – trasuda di sangue, carne, sudore, terra. Non concede nulla al clamore della circostanza. Semmai, descrive la caduta negli abissi delle popolazioni invase e assoggettate, il loro tedio, le angosce quotidiane, il senso della morte così come della residua speranza di vita.
La sua adesione alla causa degli oppressi, in questo caso gli ebrei e i popoli slavi, sottoposti al rullo compressore e distruttore dell’ideologia criminale nazifascista, non sarebbe peraltro mai venuta meno nel corso del tempo. Anche in tali vesti, quindi, redasse, insieme Il’ja Grigor’evič Ėrenburg (autore, all’epoca, non meno gradito al regime di Stalin), Il libro nero. Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945, quasi immediatamente censurato nell’Unione Sovietica non per i suoi tragici rendiconti ma per la puntualità con la quale denunciava le inenarrabili violenze e poi lo sterminio di una grande parte della popolazione sulla base di un’appartenenza “razziale”, ovvero quella ebraica (il volume è stato tradotto da noi solo nel 1999). A tale riguardo, basti aggiungere opere come Tutto scorre (uscito in Italia nel 2010) e L’inferno di Treblinka (scritto nel 1944 e poi pubblicato nel 2010).
L’avventura editoriale
Nel nostro Paese, Grossman è tuttavia conosciuto soprattutto per due opere, che hanno ottenuto una tardiva ma diffusa considerazione. Si tratta, non a caso, di una dilogia, redatta a partire dal 1943, e che comprende una prima parte, Per una giusta causa (pervenutaci recentemente con il titolo di Stalingrado, uscito solo nel 2022) e una seconda, Vita e destino, del 1952, pubblicata nella nostra lingua nei primi anni Ottanta e poi, molto più recentemente, rivista e rieditata da Adelphi sulla scorta dei manoscritti originali dell’autore, nel mentre finalmente acquisiti.
 Le intemperie editoriali fanno, per più aspetti, il paio con quelle dell’attenzione pubblica. Vasilij Semënović Grossman, fino agli anni di Gorbaciov, tempo in cui invece la sua scrittura venne liberalizzata nella declinante Unione Sovietica, sarebbe infatti risultato indigesto anche per un pubblico occidentale, ancora ancorato alla vecchia divisione bipolare, tra Occidente capitalista e Oriente comunista. Nella sua esistenza, anche tra non poche ingenuità (come quella di rivolgersi direttamente, con una lettera, a Nikita Sergeevič Chruščëv, cercando di ottenere in tale modo un’impossibile attenzione, che il potere sovietico mai avrebbe concesso), non raccolse alcuna udienza da parte di quelle stesse autorità nelle quali, fino alla conclusione della guerra, nel 1945, aveva riposto una qualche fiducia. La sua figura non può essere annoverata nella stagione del dissenso che, invece, negli anni Settanta, quando oramai lo scenario era già completamente mutato, iniziava lo sgretolamento del “sovietismo”.
Le intemperie editoriali fanno, per più aspetti, il paio con quelle dell’attenzione pubblica. Vasilij Semënović Grossman, fino agli anni di Gorbaciov, tempo in cui invece la sua scrittura venne liberalizzata nella declinante Unione Sovietica, sarebbe infatti risultato indigesto anche per un pubblico occidentale, ancora ancorato alla vecchia divisione bipolare, tra Occidente capitalista e Oriente comunista. Nella sua esistenza, anche tra non poche ingenuità (come quella di rivolgersi direttamente, con una lettera, a Nikita Sergeevič Chruščëv, cercando di ottenere in tale modo un’impossibile attenzione, che il potere sovietico mai avrebbe concesso), non raccolse alcuna udienza da parte di quelle stesse autorità nelle quali, fino alla conclusione della guerra, nel 1945, aveva riposto una qualche fiducia. La sua figura non può essere annoverata nella stagione del dissenso che, invece, negli anni Settanta, quando oramai lo scenario era già completamente mutato, iniziava lo sgretolamento del “sovietismo”.
Tuttavia, quel che il talento letterario di Grossman consegna al presente è qualcosa che va ben oltre i suoi tempi. Poiché la sua visuale supera gli spazi angusti della polemica di circostanza, per trasformarsi invece in una compiuta visione della lotta tra libertà (degli individui così come delle collettività), coercizione (dei regimi illiberali) e distruzione (delle ideologie totalitarie).
In fondo è questo il suo autentico insegnamento, non essendo ascrivibile a nessun campo politico che non sia quello del significato intrinseco e profondo della vita. Che non è parte di un disegno preordinato bensì dell’ordito che le comunità umane sanno tessere per se stesse.



