di Roberta Ascarelli
Nell’edizione originale, il libro di von Trotha si intitolava Il braccio di Pollak per ricordare ai lettori tedeschi la statua del Laocoonte che aveva accompagnato al di là delle Alpi, da Lessing a Goethe, riflessioni e passioni. L’edizione italiana tradotta con perizia quasi cinematografica da Matteo Galli ha un titolo che, invece, cita direttamente La morte di Virgilio di Broch e il suo stile sospeso tra romanzo di un’anima e documento storico: Le ultime ore di Ludwig Pollak. Un paragone ambizioso quanto fragile, come del resto le lievi suggestioni kafkiane su processi/allontanamenti che attraversano il racconto in un dialogo immaginario e non privo di incongrua flânerie su vita, arte e salvezza che la data (15 ottobre 1943) e la prossimità della deportazione rendono drammatico e toccante. Coinvolgente, ricco di notizie, spunti e imprecisioni, problematico proprio per la sua natura di romanzo storico composto su un vuoto di documentazione (soprattutto per quelle ultime ore così centrali), questo romanzo ha il pregio di far conoscere una figura poco nota nella migrazione intellettuale degli ebrei tedeschi che giungono in Italia nel mito di Goethe o, in tempi bui, nella fuga dagli aguzzini, trovando da noi un “asilo precario”, secondo la bella definizione di Klaus Voigt. Per alcuni l’Italia – da Karl Wofskehl a Rudolf Arnheim – è luogo di transito, ma per altri rappresenta un progetto di vita. Accanto a Pollak, altre figure testimoniano la ricchezza di questo incontro tra ebrei di lingua tedesca e il bel Paese: lo psicoanalista Ernst Bernhard, che iniziamo a conoscere attraverso Federico Fellini (fu il suo psicoanalista), o Rudolf Borchardt, raffinato e aristocratico scrittore, l’“ebreo diverso” che riesce a sfuggire, ma solo fino al 1945, alle persecuzioni.

Tra loro Pollak è forse il più emblematico: a Roma, nel 2019, oggetto di una grande mostra curata da Orietta Rossini in collaborazione con il Museo ebraico, L’ossessione dell’antico. Sigmund Freud e Ludwig Pollak tra ebraismo, archeologia e memoria e un convegno hanno messo in luce tratti della sua vita, interrogando la sua integrazione, il ruolo avuto nella cultura del tempo e il legame con altri intellettuali che si illudevano esistesse una simbiosi ebraico-tedesca. Archeologo e collezionista, Pollak è un uomo di ieri che, tra Illuminismo e Decadenza, interpreta l’assimilazione degli ebrei come crescita culturale, individuando però nell’arte il terreno di mediazione tra epoche, classi sociali e culture; un ebreo di quelli che – scrive Zweig in Il mondo di ieri – “Giunti a Vienna, si adattavano con sorprendente rapidità a quell’ambiente culturalmente superiore e la loro ascesa intellettuale era l’immagine perfetta dello sviluppo generale dell’epoca”.
Pio senza entusiasmi e senza tentennamenti, è affascinato soprattutto da Goethe e dall’archeologia, lì dove le tradizioni si confondono e si celebra un contatto materico e identitario tra passato e presente: “Oggi sono stato immatricolato come studente ordinario alla imperialregia università tedesca Karl-Ferdinand”, scrive nel suo diario con la fierezza di un giovane ebreo che sceglie per il futuro una professione liberale convinto di lasciarsi alle spalle una lunga vicenda di esclusione e povertà. C’è una poesia giovanile di Goethe che illumina la predilezione di quel giovane colto e intraprendente per una materia che difficilmente avrebbe aperto a lui, israelita senza grandi mezzi, le porte della accademia o le campagne di scavo dell’Impero. È il dialogo tra un Wanderer, pellegrino sentimentale in cerca di pura bellezza, e una giovane popolana italiana che, sulle rovine di un tempietto classico, allatta il suo bambino, spezzando a livello simbolico, nella centralità della “vita”, la contrapposizione tra arte e natura, così lasciando che l’antico incontri il mondo contemporaneo come segno, occasione e testimonianza. Sul Wanderer, Goethe insegna a Pollak come anche a Freud o a Lewy che i reperti archeologici non sono pezzi per musei, ma accompagnano la vita, le danno un significato e la arricchiscono: sono strumenti di interpretazione e di conoscenza, ma anche una parte necessaria della identità dei moderni.
Negli anni trascorsi a Vienna, dove conclude i suoi studi, e nei viaggi in Italia, è attratto soprattutto dalla giovane capitale: “Roma, che vuol dire Italia, la mia alfa ed omega”, esercita lo sguardo del conoscitore ed entra in contatto con l’aristocrazia del buon gusto su un piano di accettabile parità. Saggi, cataloghi, valutazioni e ritrovamenti accrescono la sua fama di esperto e la sua credibilità come mercante d’arte, al centro di una rete sempre più ampia di amatori che certifica la sua competenza e la sua crescita sociale: Barracco (di cui dirige il museo romano), Warren, Jacobsen e Nelidow, Simon, Stroganoff, Hertz, Mond, Oppenheim, Pierpont Morgan, Albrecht von Mecklenburg-Schwerin, Johann Liechtenstein.
Nel 1903 con il ritrovamento del frammento di una delle statue più note dell’antichità, Pollak realizza un sogno “tedesco”: il nipote di umili ebrei del ghetto di Praga è colui che ricompone il gruppo scultoreo del Laocoonte, la scultura ellenistica della scuola rodia conservata ai Musei vaticani che era stata in Germania il fulcro della riflessione settecentesca sul classico (e sul rapporto tra poesia e arte figurativa). L’identificazione del braccio del sacerdote troiano gli vale una definitiva e duplice cittadinanza con la nomina a membro ordinario dell’Istituto Archeologico Germanico e, unico ebreo, la “Croce alla Cultura” di papa Pio X. Seguono sorprendenti scoperte, ancora cataloghi e contatti finché la guerra lo costringe a tornare in Austria con una crescente nostalgia dell’Italia e il desiderio di non abbandonarla mai più, fino a quel 16 ottobre 1943 in cui un raffinato cultore d’arte, ridiventa per i nazisti semplicemente un ebreo come tutti gli altri.
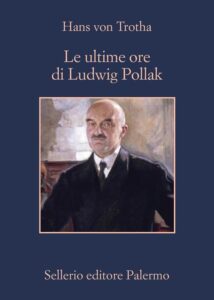
Hans von Trotha, Le ultime ore di Ludwig Pollak, trad. Matteo Galli, Sellerio Editore, pp. 188, euro 14,00
Dal braccio del Laocoonte alla deportazione
di Fiona Diwan
Nel cuore della simbiosi ebraico-tedesca. Combattuto fra lo sgomento
e il senso della fatalità davanti alla barbarie, Pollak rinunciò a vivere
in un mondo che non riconosceva più come suo
Per sopravvivere basterebbe dire un “sì”, ma Ludwig Pollak non lo vuol dire. Siamo a Roma, il 15 ottobre 1943, alla vigilia della deportazione degli ebrei dal ghetto, che avverrà il giorno dopo. Un amico è venuto a prelevarlo per portarlo in Vaticano. L’auto che li porterà in salvo è giù che aspetta, con i motori accesi, deve sbrigarsi. Ma Pollak non si decide. Anzi, in verità ha già deciso: non vuole partire, non vuole salvarsi né tantomeno sfuggire a un destino tanto abissale quanto incomprensibile. Di lì a poco sarà lui stesso, cortese e rigido, a ringraziare l’amico rimandando indietro l’auto vuota.
Il giorno dopo, Pollak e i suoi sono tra i mille ebrei romani caricati sui camion dai nazisti, deportati nei lager e uccisi. Questo il quadro storico del volumetto de Le ultime ore di Ludwig Pollak, Sellerio, scritto dal giornalista Hans Von Trotha, opera romanzesca e di fantasia ispirata alla figura del leggendario antiquario. Combattuto fra lo sgomento, il senso della fatalità del destino davanti alla barbarie onnipresente, Pollak – come Stefan Zweig – rinuncerà a vivere in un mondo che non riconosce più come suo: verrà assassinato a Auschwitz quattro giorni dopo, a 75 anni.
Nato nel cuore della Mitteleuropa, a Praga, nel 1868, archeologo, collezionista e consigliere di collezionisti, ma anche mercante e raffinato conoscitore di letteratura e d’arte, aiuta vari magnati a catalogare le loro collezioni d’arte. Nel romanzo, Pollak è un torrente in piena, sa che quella è la sua ultima occasione per raccontare: incontri e onorificenze del Papa, del Kaiser, del Re d’Italia, dello Zar, conversazioni con sovrani e onori accademici («a un ebreo, se lo immagina!»). Pollak diventerà beneamato in Vaticano per un’incredibile scoperta archeologica: il ritrovamento del braccio destro mancante della leggendaria statua del Laocoonte, all’epoca esposto nei Musei Vaticani, che Pollak donerà al Papa.

L’avventura di questa statua e del suo braccio destro ebbe un ruolo chiave nella vita di Pollak, e la vicenda prende coloriture fortemente simboliche diventando una metafora del cuore umano e della stessa parabola esistenziale di Pollak. L’opera che ritrae il pater doloroso con i due figli che si contorcono tra i serpenti fu ritrovata nel 1506: gli mancava il braccio destro. Ma nel 1903 Pollak lo riconosce nella bottega di un rigattiere, un arto ripiegato e dolente. Da eroe a vinto: un uomo sconfitto, questo è il Laocoonte dopo il ritrovamento del braccio. Come Pollak con i nazisti.
Una metafora etica: l’impossibilità di salvarsi, di sfuggire al proprio destino: «… il mio braccio, il braccio di un uomo perduto, è quello giusto (…). I serpenti sono oggi diffusi in tutta Roma, stritolano e mordono assaporando la rovina delle vittime… Il serpente vince comunque, questo ci insegna il Laocoonte. Contro i serpenti inviati dagli dèi l’uomo non vince mai, non in questo mondo almeno».



