di Fiona Diwan
Anniversari: a trent’anni dalla morte di Isaac Bashevis Singer
«Il pessimismo della persona creativa non è decadenza, bensì una potente passione per la redenzione dell’uomo. Come il poeta, anche lo scrittore cerca verità eterne, l’essenza della vita. Tenta a suo modo di risolvere l’enigma del tempo e del mutamento, di trovare una risposta al perché della sofferenza, di rivelare l’amore nell’abisso stesso della crudeltà e dell’ingiustizia». Così parlava Isaac Bashevis Singer nel celebre Discorso per il Nobel pronunciato nel 1978 davanti all’Accademia svedese. Davanti a un pubblico sbalordito, Singer non si faceva nessuno scrupolo nel passare, con repentina disinvoltura, dall’inglese allo yiddish, incurante del fatto che nessuno lo capisse: quello non era forse un premio dato anche alla letteratura yiddish? Perché quindi non parlare proprio in quella che per lui era la lingua più ricca ed espressiva del mondo? «Una mameloshn, una madrelingua che diviene meno vitale e autentica se messa a contatto con la modernità; ma ecco che autentiche perle fuoriescono dalle sue labbra appena inizia a parlare del passato», aveva scritto nel 1943, in una sorta di manifesto sul futuro dello yiddish, Problems of Yiddish Prose in America.
 Per tutto il corso della sua vita, da Varsavia a New York, Singer ha instancabilmente ragionato, polemizzato, dibattuto, scritto sullo yiddish, sul suo destino, sulla sua storia, sulla sua essenza. Lo yiddish era per lui la perfetta metafora della condizione ebraica. Vernacolo quotidiano, lingua delle passioni e dei drammi umani, ma pieno di tensione nel rapporto con il sacro (nell’uso delle stesse lettere ebraiche), lo yiddish assume per Singer, specie dopo la Shoah, il sapore di una lingua di fantasmi, di ombre, di angeli: un linguaggio dell’esilio già sul suolo europeo, ora doppiamente in esilio nell’emigrazione americana.
Per tutto il corso della sua vita, da Varsavia a New York, Singer ha instancabilmente ragionato, polemizzato, dibattuto, scritto sullo yiddish, sul suo destino, sulla sua storia, sulla sua essenza. Lo yiddish era per lui la perfetta metafora della condizione ebraica. Vernacolo quotidiano, lingua delle passioni e dei drammi umani, ma pieno di tensione nel rapporto con il sacro (nell’uso delle stesse lettere ebraiche), lo yiddish assume per Singer, specie dopo la Shoah, il sapore di una lingua di fantasmi, di ombre, di angeli: un linguaggio dell’esilio già sul suolo europeo, ora doppiamente in esilio nell’emigrazione americana.
Lingua delle anime nude, che vagano qabbalisticamente da un luogo all’altro senza trovare un corpo adatto dentro cui insediarsi, questa era per Singer la sua mameloshn. Un idioma dello smarrimento, capace di esprimere la condizione che è dell’ebreo ma anche di tutti gli uomini nel loro essere “fuori luogo”, in un altrove straniante, tutti “displaced person”. Una lingua-paradosso, fatta apposta per esprimere allo stesso tempo commedia e tragedia; ma anche la lacerante precarietà del destino ebraico e umano in generale, esito di una funambolica condizione dell’ebraismo diasporico in bilico tra un confine e l’altro, tra dubbio e fede, in una situazione di totale entropia psicologica. Non a caso, la parola chiave della narrativa americana di Singer è Lost, perduto («I am lost in America, lost for ever», scriveva).
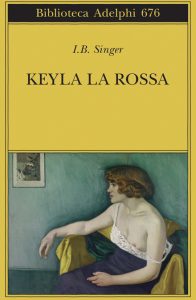 A trent’anni dalla morte, i riflettori tornano oggi a riaccendersi sull’ultimo grande scrittore della letteratura yiddish non solo grazie alla nuova e più aggiornata traduzione di alcuni capolavori (usciti per Adelphi) ma anche per la pubblicazione di romanzi inediti, mai usciti prima d’ora (Keyla la Rossa e Il Ciarlatano, Adelphi), una stagione di sorprese letterarie giunta a deliziare tutti i vecchi e nuovi appassionati di Singer.
A trent’anni dalla morte, i riflettori tornano oggi a riaccendersi sull’ultimo grande scrittore della letteratura yiddish non solo grazie alla nuova e più aggiornata traduzione di alcuni capolavori (usciti per Adelphi) ma anche per la pubblicazione di romanzi inediti, mai usciti prima d’ora (Keyla la Rossa e Il Ciarlatano, Adelphi), una stagione di sorprese letterarie giunta a deliziare tutti i vecchi e nuovi appassionati di Singer.
Leggere Bashevis vuol dire lasciarsi sorprendere da storie che si srotolano al galoppo, scritte con la fulminea capacità di arrivare in poche frasi al cuore della narrazione. Con ironia ineguagliata, egli stesso stigmatizzava che «non c’è nessun paradiso per il lettore annoiato e nessuna giustificazione per una letteratura che non interessi il lettore, non sollevi il suo spirito, non gli dia la gioia e l’oblio che la vera arte ci dà».
Tra i più prolifici autori del XX secolo, Singer è una sorta di continente letterario: si è cimentato con successo con i più svariati generi letterari, dal romanzo realista alla saga famigliare, dai racconti demoniaci al memoir, dal romanzo filosofico all’autobiografia, dal giornalismo al racconto breve al réportage, dal melò alla poesia alla gangster-novel, senza trascurare i racconti per bambini: perché i bambini, sosteneva Singer, non fanno critica letteraria, ma si lasciano facilmente traghettare verso mondi fantastici, non leggono per cercare un’identità, né per liberarsi da sensi di colpa, non sanno che farsene della psicologia, «credono ancora in Dio, nella famiglia, negli angeli, diavoli, folletti, nella chiarezza, nella logica, nella punteggiatura e altri simili vecchiumi», e soprattutto non sono così infantili da pensare che i libri possano redimere l’umanità.
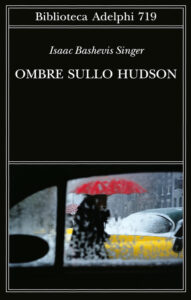 Singer muore il 24 luglio 1991, a 87 anni. Il morbo di Alzheimer ne ha oscurato la mente e i ricordi. L’uomo che aveva voluto ricordare tutto non ricordava più nulla. Ci piace immaginarlo seduto sulle rive dell’oceano Atlantico, egli stesso fantasma mentre insegue le ombre del mondo di ieri che animano le sue opere. «Mi è sempre piaciuto scrivere storie di fantasmi… I fantasmi amano lo yiddish, lassù tutti lo parlano». «Io credo nella reincarnazione, sono certo che presto Mashiach verrà e migliaia di cadaveri yiddish si alzeranno dalle loro tombe, avidi di storie e di mameloshn, di lingua madre. La prima cosa che chiederanno sarà: “C’è qualche nuovo libro che valga la pena leggere?”».
Singer muore il 24 luglio 1991, a 87 anni. Il morbo di Alzheimer ne ha oscurato la mente e i ricordi. L’uomo che aveva voluto ricordare tutto non ricordava più nulla. Ci piace immaginarlo seduto sulle rive dell’oceano Atlantico, egli stesso fantasma mentre insegue le ombre del mondo di ieri che animano le sue opere. «Mi è sempre piaciuto scrivere storie di fantasmi… I fantasmi amano lo yiddish, lassù tutti lo parlano». «Io credo nella reincarnazione, sono certo che presto Mashiach verrà e migliaia di cadaveri yiddish si alzeranno dalle loro tombe, avidi di storie e di mameloshn, di lingua madre. La prima cosa che chiederanno sarà: “C’è qualche nuovo libro che valga la pena leggere?”».



