di Ilaria Ester Ramazzotti e Marina Gersony
Esilio? Straniamento? Dualismo interiore? Che senso dare alla parola Diaspora nel terzo millennio? Come si sostanzia oggi l’identità diasporica e quali sono le forme e sensibilità che coinvolge? Rispondono voci plurime del mondo ebraico italiano, da Milano a Livorno, a Firenze a…
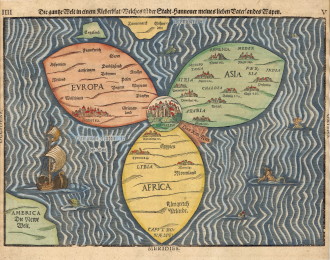
Diaspora, parola che deriva dal greco, in ebraico Golah, Galut, dispersione ma anche esilio, condizione esistenziale ancor più che storica. Generazioni di ‘ivrim nomadi e sedentari, antiche erranze di guerrieri, pastori, schiavi e ribelli, giusti e truffatori, che prima di costituire un popolo libero e indipendente, con le sue terre e le sue istituzioni, hanno saputo perseverare la propria identità non solo religiosa ma anche etica, umana, storica, in ogni angolo del mondo nell’osservanza della legge e nel sogno del ritorno. Oggi, con l’assimilazione e lo Stato d’Israele, la definizione identitaria è divenuta più complessa. La stessa nascita dello Stato d’Israele ha messo la parola fine alla precarietà dell’esistenza ebraica ma ha anche generato nuove riflessioni e una dialettica vivace fra centro e periferia non priva di “affettuosi” o a volte violenti contrasti.
Ma come si sostanzia oggi l’identità diasporica? Quali forme e sensibilità coinvolge? Che senso dare alla parola Diaspora nel Terzo Millennio? In occasione della Giornata della cultura ebraica del 10 settembre, dedicata propio al tema “Diaspora, identità e dialogo“, lo abbiamo chiesto ad alcune figure in qualche modo sfaccettate e multi-identitarie dell’ebraismo italiano, personaggi con un pedigree diasporico di tutto rispetto, che hanno cercato di capire e spiegare che cosa sia per loro risolvere (se mai fosse possibile), il paradosso ebraico, il rebus delle tante identità possibili.
Madelyn Renée, cantante lirica, nata a Boston, figlia di Jacqueline Friedman e Lawrence Levy, vive a Milano da 36 anni. «Sono americana di terza generazione – racconta -. I miei genitori sono nati a New York con radici alsaziane e ungheresi da parte materna; russe e inglesi da parte paterna. Siamo tutti askenaziti. Sono cresciuta nella tradizione e possiedo una forte identità ebraica. L’America è l’unico posto al mondo dove si sono consolidate delle importanti variazioni rispetto alla Halachà, penso soltanto alle distinzioni “conservative” e “reform”. La maggior parte degli ebrei nati in Usa dopo la Seconda guerra mondiale è molto assimilata, ma tutti hanno due terre promesse nel cuore: Israele e gli States. Tuttavia l’identità ebraica nella Diaspora Usa ha subito dei cambiamenti. Una volta si fondava su quattro pilastri: religione, lingua, patria e memoria, oggi si identifica soprattutto con la Shoah. Prima della Seconda guerra mondiale gli ebrei americani erano impegnati a solidificare il loro status economico, politico, sociale e ad adattarsi alla vita americana. Dopo l’Olocausto il mondo è cambiato e ha conferito una nuova identità all’ebraismo e a Israele. Un altro evento che ha cambiato l’identità diasporica americana è stata la Guerra dei sei giorni: la possibilità che Israele potesse essere distrutto ha rafforzato enormemente l’identità ebraica americana dando maggiore importanza alla sopravvivenza dello Stato Ebraico e all’importanza di preservare l’aspetto religoso dell’ebraismo. Io mi sono stabilita a Milano nel 1982. Mi considero ebrea, americana, italiana. O meglio milanese… Amo Milano, una città che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha dato tanto. Ma con il cuore che batte per Israele».
Miro Silvera, scrittore, è nato in Siria e vive a Milano. L’erranza, la persecuzione, ma anche il viaggio interiore nel proprio essere ebrei, sono i temi forti della sua narrativa. «Non amo la parola Diaspora che richiama l’idea dell’esilio – spiega -, bisogna vivere nel mondo che ci appartiene nella sua interezza. Siamo il grano salis e dobbiamo spargerci per dare lievito al mondo che ci circonda. Gli ebrei sono stati il primo popolo a darsi delle leggi, leggi venute da D-o, i primi a pensare a un giorno di riposo, il primo popolo a far fiorire la terra. C’è un bel romanzo tedesco degli anni Venti, La città senza ebrei di Hugo Bettauer, in cui si parla di una città dove gli ebrei non ci sono più e la gente che prima li ha cacciati, finisce per rimpiangerli. Quando gli ebrei giunsero nei Paesi arabi, come la mia famiglia che è di origine livornese, questi si sono aperti al mondo, nonostante abbiano poi pensato di buttare fuori tutti gli ebrei e appropriarsi dei loro beni. Mio nonno costruì tre sinagoghe in Siria, che sono state bruciate. Sono nato ad Aleppo, ma il mondo è la mia patria. Un vecchio detto dice che la casa è dove si appende il cappello. Il nostro compito è abitare ovunque. Israele per fortuna esiste, ma non possiamo andarci tutti. L’identità ebraica è quella che si è costruita nei secoli. E dove non ci sono ebrei, i Paesi vanno in malora, come sta succedendo ai Paesi arabi che finiranno per implodere perché chiusi e ripiegati su se stessi. Le lingue fanno la cultura. Io sono un privilegiato: la prima lingua che ho sentito è stata il francese, la seconda l’arabo, la terza l’italiano e poi ho studiato l’ebraico a scuola. Questo è ebraismo: parlare, seminare, scrivere, raccontare. Un patrimoni che non va perduto. Né dobbiamo farci intristire dalle cose che accadono, come il terrorismo. Ciò che ci manda avanti è la spinta alla vita, non alla morte».
Rivki Hazan è la direttrice della scuola ebraica del Merkos. Nata a Milano, figlia di un’americana di origine russa e di un russo immigrato in America, la sua famiglia è approdata in città inviata dal Rebbe Schneerson, nel 1958. «Mio padre, Rav Gershon Mendel Garelik, è stato il rabbino della sinagoga di via Cellini – racconta -. La nostra famiglia appartiene alla dinastia dei Chabad Lubavitch che a metà del ‘700 aveva il suo centro nella cittadina bielorussa di Lubavitch, dove hanno studiato entrambi i miei nonni. Dal 1941 si è spostata a Brooklyn. Siamo sparsi in ogni angolo, abbiamo parenti ovunque, in Usa, Israele, Sudamerica, Sudafrica, Cina e perfino in Alaska. Ho avuto la benedizione di nascere in Italia in un buon periodo, in altre parti del mondo sarebbe potuto essere più complicato. Certo, il mio sogno è vivere in Israele, amo e apprezzo tutto ciò che ne fa parte. Ma sono stata inviata dal Rebbe in Italia per dare il mio contributo alla comunità ebraica, motivo per cui cerco di comportarmi da perfetta cittadina. Voto sempre, rispetto le leggi e come direttrice di scuola insegno ai miei studenti, così come a tutti i miei 11 figli, a fare altrettanto. Amo questo Paese le cui leggi non sono in contrasto con la legge della Torà e ci permette di vivere pienamente il nostro ebraismo. Sto scrivendo una biografia sollecitata dai miei famigliari. Inizia così: “Mi chiamo Rivki, sono una donna, sono un’ebrea, sono una lubavitcher, sono un’inviata del Rebbe e sono italiana”. Per il resto, rimaniamo ebrei erranti…».
Hulda Brawer Liberanome vive a Firenze, è israeliana e proviene da una famiglia di studiosi e sionisti. È stata giornalista corrispondente per Haa’retz e attualmente è direttore di Toscana Ebraica. «La mia formazione è israeliana, dall’asilo alla scuola, alla resistenza, al servizio militare di leva. Ho lavorato per 35 anni in un ente pubblico italiano ma confesso che 51 anni da corrispondente in Italia del quotidiano Haa’retz e di Globs, il maggior quotidiano economico israeliano, sono stati per me più coinvolgenti. Una famiglia di origine, la mia, con una profonda fede e fiducia nel sionismo. Mio padre era membro negli anni Venti del comitato scientifico dell’Accademia della lingua ebraica e della Commissione (creata nel 1923 dal governatore britannico) che dava nomi agli insediamenti e alle città ebraiche; mia mamma fu tra le fondatrici dell’Associazione per i diritti della donna. Parlare solo ebraico era, a casa nostra, un dovere ineluttabile. Erano osservanti (mio padre si era laureato alla scuola rabbinica di Vienna) e insieme attivamente sionisti. Partecipando a dibattiti politici, negli ultimi due decenni, ho riscontrato ostilità, specie in ambienti di una certa sinistra. Ciò nonostante penso che sia nostro dovere di ebrei affrontare le critiche ostili anche perché a volte sono basate su informazioni parziali o preconcetti. Ho spesso percepito un atteggiamento di distacco e di critica aprioristica verso Israele senza voler esaminare i diversi aspetti della sua realtà: e questo non solo da parte di alcuni gruppi di ebrei ma anche e soprattutto da parte di un certo ambiente intellettuale italiano, compreso quello che anni fa mi aveva accolto, come giornalista. Sento con dispiacere in ambienti non ebraici e talvolta in certi nostri ambienti la volontà di separare l’“ebreo” dall’“israeliano” facendo gran complimenti agli uni e addossando agli israeliani, tutti senza distinzione, la responsabilità per ciò che accade attualmente in Israele e nei territori dell’Autonomia palestinese. Sia chiaro: resto contraria all’atteggiamento di certi ebrei che difendono Israele a spada tratta; ma allo stesso tempo non accetto l’atteggiamento di ebrei che fanno finta di niente, come se di Israele a loro non importasse nulla e che si considerano solo “italiani di origine ebraica”».
David Piazza, grafico editoriale ed editore (Morashà) «Provengo da una famiglia romana da generazioni. Mia moglie è una libanese di Milano, due dei nostri figli pregano con il rito sefardita, il terzo con rito italiano. Ho fatto l’aliyah nel 1979, ho studiato e prestato il servizio militare in Israele e credo nelle diversità piuttosto che nell’uguaglianza. Per una minoranza questo comporta naturalmente delle difficoltà e un compromesso costante con il mondo esterno. Se vogliamo capire l’identità ebraica nella Diaspora italiana dovremmo fare un passo indietro e smetterla di guardare solo agli ultimi 150 anni. Ci sono state epoche in cui eravamo perfettamente integrati, ma con una forte identità di minoranza e abbiamo dato un enorme contributo a questo Paese. Non si contano per esempio i rabbini, che erano anche eruditi, poeti, medici e scienziati e che sono riusciti a fondere le due identità di ebrei e di italiani. La Shoah è stata l’elemento di frattura che ha cambiato e destabilizzato il modo in cui siamo percepiti all’esterno e in cui noi stessi ci percepiamo. Mi viene in mente un grandissimo rabbino italiano, Samuel David Luzzatto (Shadal), ebraista, poeta, storico ed esegeta biblico, uno dei fondatori della Scienza del Giudaismo. Luzzatto si mantenne in contatto con la maggior parte degli ebraisti in tutto il mondo diventando punto di riferimento. In Israele è stato riscoperto con passione di recente e il suo commentario (in ebraico) alla Torà è nelle librerie non specializzate. Peccato che proprio in Italia invece, non solo sia sconosciuto ai più, ma non viene nemmeno insegnato nelle scuole ebraiche».
Rachele Enriquez, giornalista, è stata direttrice di Vogue Spagna, vicedirettrice del mensile Carnet e consulente editoriale di Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Nata a Milano, da madre turca di Ankara, padre italiano di Smirne. «Non mi ero mai posta la questione di essere figlia di ebrei diasporici. Durante la guerra ero piccolissima, le Leggi razziali infuriavano e dovevamo nasconderci. Eravamo sfollati a Casalpusterlengo e siamo stati accolti e protetti dalla Suore del Sacro Cuore. Vivevamo in una cascina e siamo sopravvissuti. In seguito ho frequentato la Scuola Ebraica come hanno fatto i miei figli e stanno facendo i miei nipoti. Mi sono sempre sentita profondamente ebrea, laica ma tradizionalista. Seguo le festività, dal seder di Pesach a Kippur a Rosh haShana. Ma mi fermo lì. La mia appartenenza al popolo ebraico è profondamente radicata in me fin da quando ero ragazza.
Nel 1953 ho partecipato alle Maccabiadi in Israele, facevo atletica leggera, la mia squadra era composta da ragazzi tutti italiani. Andavamo in via Unione, allora sede provvisoria della Comunità Ebraica di Milano, per gli allenamenti. Come mi sento? Italiana in tutto e per tutto così come mi sento parte di Israele. Una doppia identità».
Bruno Piperno Beer, ebreo italiano, chimico. «L’esistenza dello Stato di Israele è fondamentale, ma lo è altrettanto il senso della Diaspora. Abitare la condizione della Diaspora vuol dire vivere nell’attaccamento alle tradizioni e alle strutture comunitarie, con sforzi di diverso tipo indirizzati alla sopravvivenza di queste realtà. Ognuno dovrebbe cercare di farlo e anche collettivamente bisognerebbe rinvigorire gli aspetti culturali e sociali della vita comunitaria. Se la nostra struttura fosse più forte anche dal lato economico, si potrebbero dedicare maggiori risorse al mondo dei giovani, oggetto di continuo svuotamento visto che il 50 per cento di loro prende strade alternative. Io ho educato i miei figli in famiglia. Ai tempi, c’erano le alternative della scuola pubblica e della scuola ebraica, ma avevo delle riserve non tanto per la questione religiosa o laica, piuttosto per via delle abitudini degli studenti e delle famiglie alle loro spalle che non erano improntate alla zniut, alla “modestia”. Siamo ebrei italiani, nati ed educati in Italia, che è il nostro Paese: abbiamo tutte le preoccupazioni e tutte le speranze per una scuola che ci è cara. Bisogna poi riconoscere che dal dopoguerra le istituzioni governative italiane sono state generalmente molto attente nei confronti della minoranza ebraica, anche se non dobbiamo dimenticare bruttissimi episodi come quello del cosiddetto “Lodo Moro” che ha causato la colpevole arrendevolezza dello Stato nei confronti del terrorismo palestinese».
Colette Shammah, psicopedagoga e mediatrice familiare, è nata Milano da padre e madre di Aleppo, da molte generazioni. Uscirà tra breve il suo romanzo In compagnia della tua assenza (La Nave di Teseo), una saga diasporica raccontata attraverso la voce di Sophie, giovane ebrea costretta a fuggire ripetutamente da realtà ostili e minacciose. La sua è la storia di un inizio perenne, un eterno ricominciamento, con la stessa vitalità e determinazione. «Spostamenti e movimento – spiega Shammah -. Per me la Diaspora è il luogo dove la mia protagonista vive e agisce, una dimensione senza tempo e senza spazio, con la condanna di trovarsi sempre in un Altrove Perenne. È di fatto la condizione permanente di chi non ha la possibilità di vivere in Israele. Oggi la mia Diaspora equivale a far parte di un luogo che, in termini pratici, mi respinge. La mia Diaspora è un Nowhere Land, un luogo dove vivo la mia vita con i miei affetti ma che non è il luogo di origine a cui appartengo e che mi rappresenta in quanto ebrea. Sono sempre in sospeso fra due realtà. Ho fatto molti tentativi per stabilirmi in Israele. Sono tutti falliti. Così vivo in un Paese che non fa parte della mia storia».
Guido Guastalla, ebreo italiano, è nato a Livorno. Editore, gallerista e mercante d’arte, con i figli ha rilevato anche la Libreria Editrice Salomone Belforte proseguendo l’antica attività editoriale familiare. «L’identità cambia nel corso del tempo, con le circostanze esterne e personali, che si influenzano reciprocamente. Negli anni Sessanta molti giovani guardavano a Sinistra e verso un accentuato laicismo, per cui l’ebraismo finiva per rappresentare una forma residuale e non più centrale nella propria vita, almeno dal lato religioso. Dal lato politico e civile, ci sentivamo degli italiani appartenenti a famiglie ebraiche. Siamo vissuti a Livorno lavorando alla casa editrice Belforte. La mia famiglia materna era numerosa, laica e molto italiana, con tradizioni tali per cui i miei zii avevano partecipato alla Prima guerra mondiale: erano ebrei italiani, con un aspetto religioso ebraico, cosa che non è tutto parlando di identità. Il sionismo, per esempio, può essere declinato in senso puramente laico. Molti sionisti non sono religiosi e molti religiosi non sono sionisti.
La svolta arrivò con la Guerra dei sei giorni, che fu l’elemento discriminante che spinse molti giovani ebrei come me a abbandonare il PCI.
Mi sembrava un po’ ridicolo lasciare oltre 2000 anni di storia ebraica per una storia comunista di soli 70. Nel ’67 mi sono sposato laicamente con una donna che non era ebrea, ma decidemmo di mandare i figli alla scuola ebraica di Livorno e poi di convertirli all’ebraismo.
Cominciò così un percorso di cambiamento progressivo, anche attraverso la frequentazione della Comunità, di cui sono stato vicepresidente. In seguito anche mia moglie si è convertita. Siamo così diventati ebrei italiani anziché italiani di religione ebraica. Amiamo l’Italia, abbiamo studiato qui e nessuno ci tolga mai Dante!
Tuttavia siamo cittadini del mondo. Mia figlia sta preparando il mio nipotino affinché sia in grado di vivere ovunque. I nostri nonni si ritenevano italiani riconoscenti a uno Stato nazionale che diede loro i diritti per vivere la vita pubblica, culturale, politica. Oggi ciò non è venuto meno, ma si percepisce una piccola incrinatura, che modifica queste nostre identità liquide: ognuno ha “identità multiple” all’interno di una più specifica. Ed è stata proprio la capacità di adattarsi ai tempi e ai luoghi che ha permesso al popolo ebraico di sopravvivere».
Paola Jarach Bedarida, vive a Livorno, nata a Torino, è un’ebrea italiana «… fiera di esserlo. Pur rispettando la fede degli altri, non ho mai avuto alcun dubbio sulla mia identità religiosa. Sono stata Presidente della Comunità Ebraica di Livorno dal 1983 al 1999 e vicesindaco del Comune di Livorno dal 1995 al 2004. La città in cui vivo, il mio lavoro nella scuola pubblica e nell’amministrazione cittadina non mi hanno creato problemi, semmai ho visto rispetto e interesse per la cultura ebraica e le sue tradizioni, le regole religiose conosciute da tutti, come lo Shabbat e la Kasherut. Ritengo che il ruolo degli ebrei nella Diaspora sia fondamentale per il bagaglio di valori etici e civili che la nostra cultura religiosa ci ha trasmesso nei secoli».



