Foto in alto: una Haggadah del 1700, con i tre canti, in giudeo veneziano, ladino e yiddish
di Michael Soncin
Un pastiche linguistico unico. Dal giudeo-romanesco al giudeo-mantovano con i prestiti dallo yiddish, fino al bagitto livornese contaminato col “sefardì” degli ebrei cacciati dalla Spagna… “Dialetti” e lingue vernacolari anche del nostro Sud. Un prezioso testo riunisce oggi gli Idiomi degli Ebrei d’Italia. Ne parliamo con l’autrice Maria Mayer Modena, intervistando esperti e “parlanti” che ancora si esprimono in quell’italiano misto a ebraico i cui esiti comici sono a volte irresistibili.
Uffa, che meghillà! Che barba, che noia, che meghillà, appunto! A molti di noi può essere capitato di imbattersi nella lettura di una meghillà. Ma prima che qualcuno possa fraintendere, qui non stiamo affatto parlando del rotolo di pergamena contenente la storia di Ester. Sebbene il prestito derivi proprio dalla festività di Purim, in verità ci si riferisce ad un testo, saggio, romanzo, discorso, troppo “lungo e noioso”; mentre rivolgersi ad una persona dicendole che è bella come li 14 di Adar, non è certo farle un complimento, anzi.
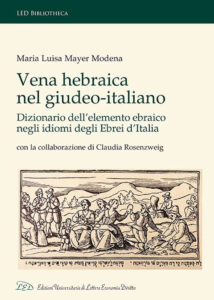
Queste sono solo alcune delle espressioni presenti nelle parlate degli ebrei italiani alla base di una ricerca pionieristica, uno studio senza precedenti condotto dalla professoressa Maria Luisa Mayer Modena, confluito nella recente pubblicazione di Vena hebraica nel giudeo-italiano – Dizionario dell’elemento ebraico negli idiomi degli Ebrei d’Italia.
«Prima d’allora erano stati fatti degli studi per regione, ma non c’era un unico studio che le raggruppasse. L’aspetto interessante di questo lavoro è stato quello di riunire i risultati delle varie zone italiane in un dizionario scientifico», racconta Mayer Modena a Mosaico. Come spiega la studiosa, questi sono i risultati di una lunga ricerca sulle tradizioni linguistiche delle comunità ebraiche, che parte da un progetto in origine creato da Shlomo Morag, all’Università Ebraica di Gerusalemme, continuato poi da Aharon Maman.
«Lo scopo era quello di raccogliere e studiare le testimonianze allora ancora reperibili degli idiomi ebraici, con particolare riguardo all’ambito mediterraneo e orientale, presentando i lessemi derivati dalla componente ebraico-aramaica in una prospettiva comparata». Le ricerche delle varie aree sono state poi raccolte in un dizionario curato da Maman, in cui sono stati inseriti la maggior parte dei lemmi che ora compaiono in Vena Hebraica.
«A Gerusalemme si stava facendo una raccolta di tutte le lingue ebraiche e a me hanno affidato l’Italia. Ho trascorso un anno in Israele, era il mio anno di congedo – prosegue Mayer Modena -. L’ambito italiano ha presentato fin da subito delle problematiche molto particolari, dovute anche alla ricchezza e alla complessità della storia linguistica d’Italia. Perciò, il lavoro di raccolta di questo materiale è cominciato creando un database pensato appositamente per rispondere ad una realtà così specifica. È stata un’esperienza indimenticabile. Vicino a me sedeva uno studioso dello Yemen, uno di Algeri, e tanti altri. C’è stata una continua collaborazione tra le varie tradizioni. È da lì che è cominciato tutto quanto».
UNA MOLTEPLICITÀ DI FONTI,
TRA CUI IL TEATRO RINASCIMENTALE, PREZIOSA TESTIMONIANZA
Una pluralità di fonti. Una ricerca perseguita tenendo in considerazione testi letterari e semiletterari giudeo-italiani delle varie epoche storiche; lo studio delle testimonianze scritte sul parlato, come i verbali dell’Inquisizione o il teatro rinascimentale italiano; le interviste dirette e indirette a parlanti e informatori delle varie regioni. «Una testimonianza preziosissima per l’età del Rinascimento ci viene dal teatro, che si serviva spesso del plurilinguismo per ottenere effetti comici. Il fatto che in quel quadro gli ebrei compaiano con questa funzione, ci dimostra ovviamente che la loro parlata veniva percepita come ben distinta dall’ambiente linguistico circostante. Si pensi ad Orazio Vecchi, con l’opera L’Amfiparnaso del 1597, o più avanti nel tempo a Carlo Goldoni». Chiaramente questi testi possono presentare un problema di attendibilità, motivo per il quale hanno richiesto opportune indagini di ricerca. «Si tratta di testimonianze preziose perché, quasi tutte, si riferiscono alla vigilia della chiusura nei ghetti che viene considerata il momento in cui si “fissano” le parlate moderne. Da allora, infatti, il giudeo-italiano parlato o meglio, a questo punto, ‘le parlate’, saranno da una parte sempre più legate alla loro sede specifica, perché diminuisce la mobilità dei nuclei ebraici, ma dall’altra contemporaneamente differenziate, in senso arcaistico e con la conservazione di cospicue tracce delle sedi precedenti, dalla parlata non-ebraica locale, data appunto la concreta chiusura dell’ambiente».
LA COMPONENTE “EBRAICA” DELLE “PARLATE”
Vi sono l’area piemontese, l’emiliano-veneta, l’area toscana e umbro-marchigiana, con l’inconfondibile bagitto, originario di Livorno, chiamato per l’appunto anche giudeo-livornese, e poi il colorito giudeo-romanesco, che tutt’ora passeggiando per il ghetto di Roma si può ascoltare nella sua vitalità. Sono lingue diverse tra loro ma tutte accomunate dalla presenza della componente ebraica. Pertanto, che cosa intendiamo quando parliamo di componente ebraica nelle varie parlate? «Per elemento ebraico in questo caso intendiamo anche quello ebraico-aramaico perché la lingua sacra comprende, oltre a quella della Bibbia, anche quella del Talmud, che sappiamo essere scritto in buona parte in aramaico. Le parole scelte derivano quindi dell’ebraico biblico, dall’ebraico mishnaico, dall’aramaico biblico e talmudico, e anche dell’ebraico medievale, attraverso le preghiere composte in quel periodo. Sono estremamente rari i casi di fonti più moderne. Il corpus cui si attinge è sostanzialmente lo stesso per le varie aree italiane, così come per le varie aree della Diaspora».
C’è poi il problema della scelta dei termini della “lingua sacra”, per cercare di distinguere quando fanno parte della parlata e quando invece sono solo dei prestiti, un aspetto che viene chiaramente sottolineato e affrontato nel capitolo introduttivo al dizionario Vena hebraica nel giudeo-italiano.
AL SUONARE DELLO SHOFAR METTETEVI IL PALTÒ
Da questo variegato sostrato culturale pieno di contaminazioni sono nati dei termini e modi di dire davvero curiosi. «È interessante per esempio la parola Scimur, che significa ‘azzima rituale di pasta dura’, che in giudeo-italiano si può usare per indicare una persona testarda, mentre in Oriente si riferisce ad una ragazza che è stata custodita. Ci sono inoltre dei proverbi giudeo-italiani che tendono a filtrare ebraicamente dei fatti, come il detto Pessah non è, mazzà non c’è, che vuol dire che è inutile preoccuparsi in anticipo per problemi ancora lontani. Attraverso questi gerghi si può anche studiare in un qualche modo l’evoluzione del clima. Sciofar – Tabar! Questo perché le prime festività di Rosh HaShanah e Kippur, in occasione delle quali si suona lo Shofar, segnano l’inizio della stagione fredda nella quale ci si mette il cappotto (o il tabarro, un pesante mantello). Un altro è Nacamù Nacamù, dell’estate non ce n’è più, dove il termine ha valore consolatorio (da lenachem, “consolare”).
NON È FINITA QUI: FATEVI AVANTI
Dalla conversazione con l’autrice di Vena hebraica nel giudeo-italiano – Dizionario dell’elemento ebraico negli idiomi degli Ebrei d’Italia non si è potuto che soffermarsi su alcuni dei tanti aspetti, anche di analisi e metodologia, affrontati nella stesura del volume, che presenta una densa e dettagliata esposizione della materia, con precisi riferimenti e annotazioni bibliografiche. E che dire delle voci riportate nel dizionario? Una risposta la fornisce il professore Aharon Maman: «Leggete questo dizionario come se fosse un romanzo».
Ed effettivamente basta leggere anche solo un paio dei lemmi, per compiere un viaggio sorprendente pieno di storia e di emozioni. Chiunque sia interessato al mondo ebraico non può stare a digiuno di questa lettura. È stata proprio Maria Luisa Mayer Modena ad inaugurare l’insegnamento dell’ebraico all’Università degli Studi di Milano.
Durante la sua attività di ricerca si è occupata soprattutto di ebraico, sostrato mediterraneo e giudeo-italiano. Ricordiamo, tra le sue pubblicazioni, l’edizione critica del manoscritto Il Sefer mitzwòt della Biblioteca di Casale Monferrato.
La professoressa conclude l’intervista lanciando un appello: «Questo lavoro è un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza, perché speriamo che altre persone mettano a disposizione dei testi, le loro conoscenze, e che i parlanti stessi raccontino la propria testimonianza». Perciò fatevi avanti!

Parla Claudia Rosenzweig, docente di letteratura yiddish all’Università Bar-Ilan
Ogni idioma ha un’anima.
Dall’Italia a Israele, per conoscere il patrimonio delle nostre parlate ebraiche
 «Tolto l’ebraico, in Israele, quando si menzionano le lingue ebraiche, tutti pensano allo yiddish o al ladino. Il giudeo-italiano non è noto. Basti pensare che non appare nemmeno nella catalogazione dei manoscritti dei libri antichi presso la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme, che per noi è un punto di riferimento. Ecco perché questo libro di Maria Luisa Mayer Modena Vena hebraica nel giudeo-italiano – Dizionario dell’elemento ebraico negli idiomi degli Ebrei d’Italia è così importante e stiamo infatti pensando di presentarlo anche qui in Israele, affinché si aumenti la consapevolezza di questo campo di studi. Per dargli appunto un’accessibilità di respiro internazionale, la professoressa ha molto voluto che inserissimo anche le traduzioni in inglese dei lemmi. Il mancato interesse per gli aspetti linguistici della storia ebraica italiana si collega con il fatto che, da un punto di vista generale, l’ebraismo italiano stesso, che è così importante, e non solo per motivi geografici, è purtroppo poco studiato». A parlarne con noi è Claudia Rosenzweig, docente di letteratura yiddish antica all’Università Bar-Ilan, che ha collaborato al dizionario di giudeo-italiano. «Questo è il lavoro della professoressa Mayer, il suo progetto, il suo sogno. Il mio contributo è stato puramente tecnico e consisteva nel trasformare il database, in un dizionario, grazie anche alla collaborazione di alcuni lessicografici e in fase finale di Valeria Passerini, della casa editrice LED». Rosenzweig spiega che questo progetto è la conclusione di un lavoro di ricerca durato decenni, ma al contempo è anche un’occasione per iniziare nuove ricerche. «Dal punto di vista tecnico è stato molto impegnativo, ed abbiamo quindi deciso di mettere un ‘punto e virgola’ e pubblicare le ricerche svolte. Sicuramente in futuro ci potrà essere la possibilità di una seconda o terza edizione, perché abbiamo ancora tantissimo materiale. C’è ancora molto lavoro da fare in questo campo».
«Tolto l’ebraico, in Israele, quando si menzionano le lingue ebraiche, tutti pensano allo yiddish o al ladino. Il giudeo-italiano non è noto. Basti pensare che non appare nemmeno nella catalogazione dei manoscritti dei libri antichi presso la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme, che per noi è un punto di riferimento. Ecco perché questo libro di Maria Luisa Mayer Modena Vena hebraica nel giudeo-italiano – Dizionario dell’elemento ebraico negli idiomi degli Ebrei d’Italia è così importante e stiamo infatti pensando di presentarlo anche qui in Israele, affinché si aumenti la consapevolezza di questo campo di studi. Per dargli appunto un’accessibilità di respiro internazionale, la professoressa ha molto voluto che inserissimo anche le traduzioni in inglese dei lemmi. Il mancato interesse per gli aspetti linguistici della storia ebraica italiana si collega con il fatto che, da un punto di vista generale, l’ebraismo italiano stesso, che è così importante, e non solo per motivi geografici, è purtroppo poco studiato». A parlarne con noi è Claudia Rosenzweig, docente di letteratura yiddish antica all’Università Bar-Ilan, che ha collaborato al dizionario di giudeo-italiano. «Questo è il lavoro della professoressa Mayer, il suo progetto, il suo sogno. Il mio contributo è stato puramente tecnico e consisteva nel trasformare il database, in un dizionario, grazie anche alla collaborazione di alcuni lessicografici e in fase finale di Valeria Passerini, della casa editrice LED». Rosenzweig spiega che questo progetto è la conclusione di un lavoro di ricerca durato decenni, ma al contempo è anche un’occasione per iniziare nuove ricerche. «Dal punto di vista tecnico è stato molto impegnativo, ed abbiamo quindi deciso di mettere un ‘punto e virgola’ e pubblicare le ricerche svolte. Sicuramente in futuro ci potrà essere la possibilità di una seconda o terza edizione, perché abbiamo ancora tantissimo materiale. C’è ancora molto lavoro da fare in questo campo».
Leggendolo qua e là, ciò che colpisce, è anche il significato complessivo delle parole riportate. «Non è solo un dizionario in senso linguistico. Ci sono termini molto ‘pieni’, per dirla in un altro modo, carichi, saturi di paura, odio, derisione e dolore. Possiamo quindi intuire, che non incontriamo solo termini neutri, ma anche molte parolacce, maledizioni e proverbi salaci. È una storia culturale». Uno dei contributi che ha apportato Rosenzweig è stato quello di segnalare le corrispondenze – che ci sono – con lo yiddish in Italia. «Il giudeo italiano ha delle caratteristiche secondo me un po’ speciali, perché viene in contatto con le altre lingue ebraiche, in particolare con il ladino e con lo yiddish, ed è interessante vedere come giudeo italiano, ladino e yiddish interagiscono tra loro». Se da una parte lo yiddish può sembrare abbastanza autonomo, dall’altra, il ladino viene sicuramente in contatto con il giudeo-greco e il giudeo-arabo. Nel ‘500 nelle comunità italiane si sono trovati ebrei cacciati dalla Spagna ed ebrei espulsi da varie città tedesche. «Esempio di questa testimonianza, tra le documentazioni che abbiamo consultato, è una bellissima Haggadah del 1700, con i tre canti, in giudeo veneziano, ladino e yiddish, tutti rigorosamente scritti in caratteri ebraici». E a proposito di yiddish nel giudeo italiano si verificano chiaramente, vista la realtà del tempo, dei passaggi di termini. «Uno di questi è il termine yortsayt che in yiddish vuol dire ‘anniversario di morte’, che entra probabilmente già nel 1500, e si diffonde in tutte le parlate d’Italia, nelle forme di jorzai, orsai, ursai o orzai, a seconda della zona».
Alberto Cavaglion: «Vi racconto l’ebraico-piemontese “rivissuto” nei ricordi di mio padre»
«C’è un ricordo molto personale che si lega alla figura di mio padre; fino a quando ne ha avuto le forze ha tenuto un fondaco di tessuti a Cuneo: è stato uno degli interlocutori di Primo Levi al momento della stesura del racconto Argon, il primo che compare nel libro Il sistema periodico. Levi prima della stesura ha fatto una ricognizione presso gli esercizi commerciali che conosceva per raccogliere i lemmi di varia natura, attingendo ad una serie di vocaboli dal negozio di famiglia, in cui hanno lavorato i miei nonni, bisnonni e trisnonni».
 A raccontare questa storia affascinante che ci riporta indietro nel tempo è lo storico Alberto Cavaglion. «Il negozio situato nel basso Piemonte ha cominciato a vivere con l’apertura dei ghetti a metà ‘800. Questo ricordo è testimoniato dalla figura di Giovanna Massariello Merzagora, grande linguista, figlia di un deportato, una delle animatrici dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Nel corso della sua vita ha insegnato Storia della lingua nella città di Verona, ed è stata una pioniera negli studi sulle parlate giudaico-italiane. Scrisse un saggio molto bello attingendo alle fonti di Primo Levi. Devo dire che fu per me ragione di commozione vedere che molti di quei vocaboli che mio padre aveva suggerito sono finiti in questo piccolo dizionario che Levi ha poi sviluppato in quel bellissimo racconto». Proprio su Argon il professor Cavaglion, nel saggio pubblicato nel 2006, Notizie su Argon. Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso, racconta il dietro le quinte, lo sfondo di questo racconto, portando alla luce una realtà nascosta. È interessante sapere che «queste parlate venivano trasmesse nei piccoli esercizi commerciali ed entravano spesso a far parte anche del linguaggio dei commessi non ebrei che imparavano a usare questi vocaboli».
A raccontare questa storia affascinante che ci riporta indietro nel tempo è lo storico Alberto Cavaglion. «Il negozio situato nel basso Piemonte ha cominciato a vivere con l’apertura dei ghetti a metà ‘800. Questo ricordo è testimoniato dalla figura di Giovanna Massariello Merzagora, grande linguista, figlia di un deportato, una delle animatrici dell’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Nel corso della sua vita ha insegnato Storia della lingua nella città di Verona, ed è stata una pioniera negli studi sulle parlate giudaico-italiane. Scrisse un saggio molto bello attingendo alle fonti di Primo Levi. Devo dire che fu per me ragione di commozione vedere che molti di quei vocaboli che mio padre aveva suggerito sono finiti in questo piccolo dizionario che Levi ha poi sviluppato in quel bellissimo racconto». Proprio su Argon il professor Cavaglion, nel saggio pubblicato nel 2006, Notizie su Argon. Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso, racconta il dietro le quinte, lo sfondo di questo racconto, portando alla luce una realtà nascosta. È interessante sapere che «queste parlate venivano trasmesse nei piccoli esercizi commerciali ed entravano spesso a far parte anche del linguaggio dei commessi non ebrei che imparavano a usare questi vocaboli».
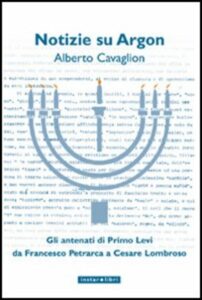
C’è un termine del giudeo-piemontese al quale Cavaglion è particolarmente affezionato ed è bahalom, presente anche nelle varianti di bachalòm o bahhalom: in ebraico Halom vuol dire ‘sogno’. «È la parola che mi sta più a cuore e che io stesso utilizzo. Come dice Levi in Argon, veniva usato come un intercalare per negare l’affermazione precedente che qualcuno aveva fatto. Per dirla in altre parole è una piccola miccia che fa cadere le certezze di chi si vanta, di chi è pieno di retorica. Se io dovessi dire: ‘Che bella intervista che abbiamo fatto’ e poi dico ‘Bahalom!’, metto in dubbio in un certo senso quanto ho affermato». Recentemente, Cavaglion ha curato il volume di Cesare Lombroso, edito da Einaudi, L’amore nei pazzi e altri scritti, in cui emergono aspetti inediti di colui che è considerato il fondatore dell’antropologia criminale. Tutti lo conoscono per i suoi controversi saggi accademici, ma quello che molti non sanno è che Lombroso «è stato il primo che ha studiato il gergo dei commessi nei negozi commerciali degli ebrei in Piemonte. È il padre nobile delle parlate ebraiche piemontesi. Una paternità che arriva fino al padre di Primo Levi che era un lombrosiano di stretta osservanza».
Proprio in questa raccolta sono contenuti questi scritti. E sul valore di queste parlate Cavaglion sottolinea: «Sono un veicolo di conoscenza che attutisce tanti fenomeni di pregiudizio. I gerghi sono stati un ponte di conoscenza, di consuetudini, tra le minoranze e le maggioranze. La lingua affratella, non divide, è questo il punto cruciale».
Il Giudeo-Mantovano: “alcune espressioni le utilizzava la nostra domestica cristiana”
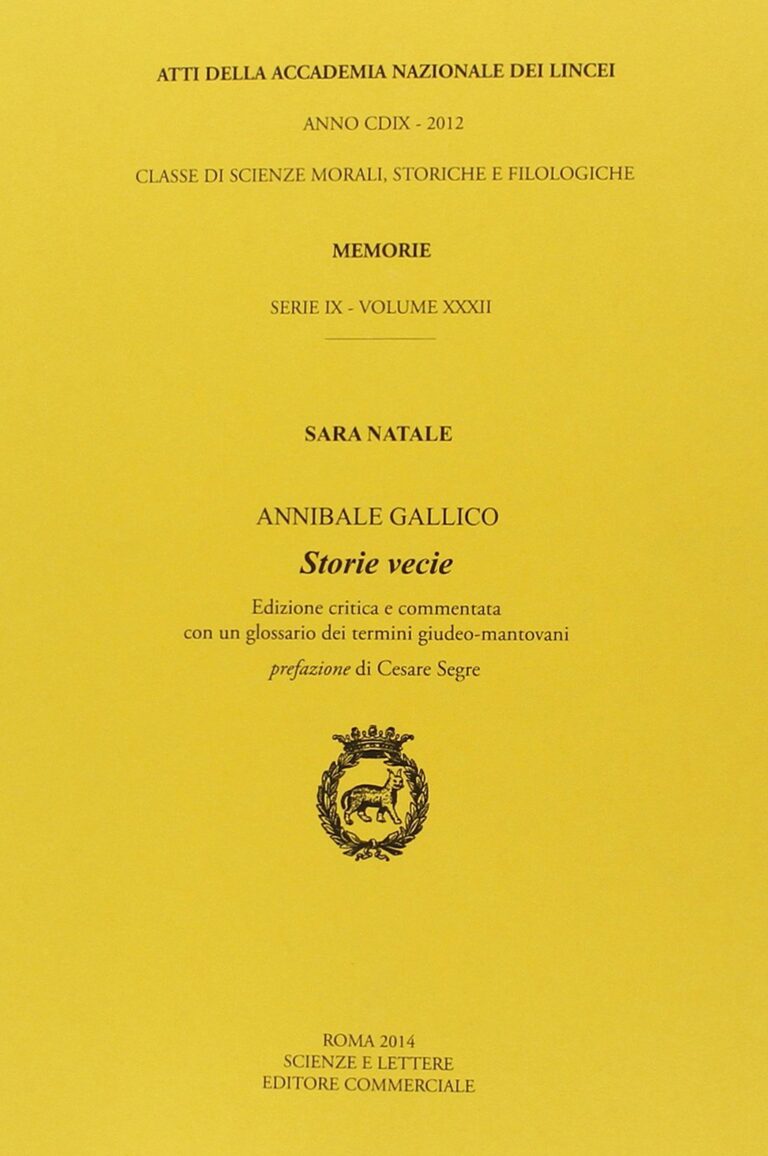 «Nella nostra famiglia ormai non lo si parlava più, ma ricordo, quand’ero da bambino, che alcune espressioni, che rimandavano al dialetto giudaico-mantovano erano usate dalla nostra domestica cristiana che è stata da noi per oltre 40 anni. Non vivevamo nel ghetto, e non saprei spiegare come una persona che non aveva nulla a che fare con l’ebraismo potesse utilizzare certe parole, ma questo senz’altro testimonia che lo voci del giudaico-mantovano hanno influenzato la parlata locale. Questo dialetto era parlato in particolare, dalle persone che abitavano nel ghetto, e le ultime che vi hanno vissuto risalgono al 1950-55 circa. Poi è andato in disuso, e da allora nessuno più ha avuto modo di sentire qualche frase, se non forse oggi, in qualche anziano della comunità, ma solo sotto forma di un ricordo molto lontano». Così Emanuele Colorni, Presidente della Comunità Ebraica di Mantova, racconta le ultime reminiscenze di questa parlata.
«Nella nostra famiglia ormai non lo si parlava più, ma ricordo, quand’ero da bambino, che alcune espressioni, che rimandavano al dialetto giudaico-mantovano erano usate dalla nostra domestica cristiana che è stata da noi per oltre 40 anni. Non vivevamo nel ghetto, e non saprei spiegare come una persona che non aveva nulla a che fare con l’ebraismo potesse utilizzare certe parole, ma questo senz’altro testimonia che lo voci del giudaico-mantovano hanno influenzato la parlata locale. Questo dialetto era parlato in particolare, dalle persone che abitavano nel ghetto, e le ultime che vi hanno vissuto risalgono al 1950-55 circa. Poi è andato in disuso, e da allora nessuno più ha avuto modo di sentire qualche frase, se non forse oggi, in qualche anziano della comunità, ma solo sotto forma di un ricordo molto lontano». Così Emanuele Colorni, Presidente della Comunità Ebraica di Mantova, racconta le ultime reminiscenze di questa parlata.
Il giudeo-mantovano è un patrimonio che oggi si conserva, come ci spiega, in saggi e raccolte di testi, ad opera di studiosi come la professoressa Sara Natale, che ha curato il volume di poesie, dal titolo Storie vecie, di un suo lontano parente, il medico mantovano Annibale Gallico (1876-1935). «A Mantova – racconta Colorni – questo idioma si è mantenuto più a lungo rispetto ad altre aree del mantovano, perché il ghetto, non essendoci stati rapporti con l’esterno, ha funzionato da scatola chiusa. È curioso sapere poi che il dialetto del giudeo-mantovano è il vecchio mantovano che si parlava anche fuori dall’area ebraica nel 1500. Il ghetto per le ragioni che ben conosciamo l’ha cristallizzato. Ci sono tante piccole indicazioni che dimostrano appunto che il giudaico-mantovano sia in effetti il dialetto mantovano che si parlava prima che sorgesse il ghetto. Poi chiaramente il dialetto mantovano si è evoluto e ha ‘vissuto’ come tutti i dialetti, trasformandosi in quello che conosciamo oggi».
Il giudeo-veneziano raccontato da Umberto Fortis
Il custode del linguasso
 «Ho vissuto la mia infanzia frequentando il ghetto veneziano quando ancora le persone più anziane usavano l’antica parlata, che sentivo spesso anche in famiglia. Personalmente non l’ho mai usata, ma ho sempre provato vivo interesse per il fenomeno linguistico. L’incontro con un collega, docente di dialettologia, mi ha spinto a iniziare un’inchiesta tra gli ultimi parlanti, per raccogliere e salvare i residui del singolare “linguasso” (come lo definivano i veneziani): ne è nato un primo volume, in collaborazione, più tardi da me ripreso e ampliato in un più vasto repertorio nel 2006 (La parlata del ghetto di Venezia e le parlate giudeo italiane, Giuntina)».
«Ho vissuto la mia infanzia frequentando il ghetto veneziano quando ancora le persone più anziane usavano l’antica parlata, che sentivo spesso anche in famiglia. Personalmente non l’ho mai usata, ma ho sempre provato vivo interesse per il fenomeno linguistico. L’incontro con un collega, docente di dialettologia, mi ha spinto a iniziare un’inchiesta tra gli ultimi parlanti, per raccogliere e salvare i residui del singolare “linguasso” (come lo definivano i veneziani): ne è nato un primo volume, in collaborazione, più tardi da me ripreso e ampliato in un più vasto repertorio nel 2006 (La parlata del ghetto di Venezia e le parlate giudeo italiane, Giuntina)».
Se c’è un custode della parlata ebraica veneziana, quel custode è il professor Umberto Fortis. A Bet Magazine Mosaico spiega che non è legato a qualche espressione in particolare. «Direi che mi sento legato allo spirito ironico, scherzoso, spesso allusivo, talora in ‘sovratono’, che distingue la parlata da tante altre: ricorrono, ad esempio, interi sintagmi di origine biblica, usati in senso peggiorativo e lontano dal loro vero significato, come: tov sem misémen tov (Eccl., VII,1), inizio dell’ashcavà per i defunti, usato come formula di maledizione!». Sappiamo che rispetto a realtà come Roma, il dialetto ebraico veneziano non è più utilizzato. «Ne rimane soltanto qualche fragile ricordo nella memoria di alcune persone più anziane e più legate alle tradizioni del ghetto. Resta un fenomeno linguistico, oggetto di studio per gli appassionati di dialettologia, che lavorano sui resti di quanto emerge da documenti o da alcune ricostruzioni fatte in piccole scenette dagli ultimi parlanti che hanno voluto lasciare una testimonianza, attraverso la parlata, della passata vita del hatzèr, il ghetto veneziano. Tale, ad esempio, la commediola Quarant’anni fa del rabbino Bruno Polacco z. l.».
Il Bagitto: “Fate onore al bel Purim”
 Attualmente sembra effettivamente esserci un risveglio, da un punto di vista culturale degli idiomi degli ebrei d’Italia. Lo testimoniano eventi, come il ciclo di conferenze tenuto dal circolo ebraico di cultura milanese il Nuovo Convegno, che tra i diversi ‘gerghi’ ha affrontato anche il bagitto. Detto anche giudeo-livornese, il bagitto «non è solo un modo di esprimersi, il vernacolo degli ebrei di Livorno, ma anche un modo di essere, di presentarsi, di agire, una mentalità popolare generata e plasmata dalle vicende secolari di coloro che furono espulsi dalla Penisola iberica, e del loro modo di vivere nei Paesi, nelle città in cui, talora precariamente, tentavano di fissare e di iniziare una nuova vita». Lo scrive Gabriele Bedarida, nell’introduzione al libro di Paolo Fornaciari, Fate onore al bel Purim. Il Bagitto, vernacolo degli ebrei livornesi (Edizioni Erasmo). Fornaciari – uno dei conferenzieri del Nuovo Convegno – studioso del bagitto, nel suo libro, che si può definire saggio e antologia al contempo, si ritrovano regole di pronunzia, modi di dire, storielle locali, ma anche la storia dell’insediamento ebraico nella città toscana, oltre a testi e musiche, come la festosa canzoncina che si canta a Livorno per Purim, il cui primo verso è appunto il titolo del libro: “Fate onore al bel Purim”. Tra i diversi termini menzionati da Fornaciari, interessante è il vocabolo smengoi, ancora oggi in uso dai venditori di frutta in piazza Cavallotti, nella forma di ’un c’è mangoi, per dire “non ci son soldi, è meglio perciò non avere voglie, né desideri”. La parola significa “denari” e deriva dal termine ebraico ma’ot, finendo poi col subire tutta una serie di mutamenti.
Attualmente sembra effettivamente esserci un risveglio, da un punto di vista culturale degli idiomi degli ebrei d’Italia. Lo testimoniano eventi, come il ciclo di conferenze tenuto dal circolo ebraico di cultura milanese il Nuovo Convegno, che tra i diversi ‘gerghi’ ha affrontato anche il bagitto. Detto anche giudeo-livornese, il bagitto «non è solo un modo di esprimersi, il vernacolo degli ebrei di Livorno, ma anche un modo di essere, di presentarsi, di agire, una mentalità popolare generata e plasmata dalle vicende secolari di coloro che furono espulsi dalla Penisola iberica, e del loro modo di vivere nei Paesi, nelle città in cui, talora precariamente, tentavano di fissare e di iniziare una nuova vita». Lo scrive Gabriele Bedarida, nell’introduzione al libro di Paolo Fornaciari, Fate onore al bel Purim. Il Bagitto, vernacolo degli ebrei livornesi (Edizioni Erasmo). Fornaciari – uno dei conferenzieri del Nuovo Convegno – studioso del bagitto, nel suo libro, che si può definire saggio e antologia al contempo, si ritrovano regole di pronunzia, modi di dire, storielle locali, ma anche la storia dell’insediamento ebraico nella città toscana, oltre a testi e musiche, come la festosa canzoncina che si canta a Livorno per Purim, il cui primo verso è appunto il titolo del libro: “Fate onore al bel Purim”. Tra i diversi termini menzionati da Fornaciari, interessante è il vocabolo smengoi, ancora oggi in uso dai venditori di frutta in piazza Cavallotti, nella forma di ’un c’è mangoi, per dire “non ci son soldi, è meglio perciò non avere voglie, né desideri”. La parola significa “denari” e deriva dal termine ebraico ma’ot, finendo poi col subire tutta una serie di mutamenti.
È risaputo che la Comunità Ebraica di Livorno in origine era formata da ebrei sefarditi, provenienti da paesi di origine portoghese e spagnola. Altro elemento da ricordare, come sottolinea anche Mayer Modena nel suo dizionario, è l’importanza dei fittissimi scambi e contatti, continuati nei secoli successivi, tra Livorno e tutte le comunità sefardite del Mediterraneo”. Per tale motivo, «si può sostenere che il giudeo-livornese appartiene, oltre che all’insieme delle parlate giudeo-italiane, anche alla koinè sefardita: espressioni caratteristiche, metafore, proverbi rimbalzano da Salonicco a Livorno, da Livorno al Marocco o alla Turchia, ponendo complicati e a volte irrisolvibili problemi etimologici: si tratta di creazioni livornesi, di prestiti dall’esterno, o di preziosi resti dell’antico comune fondo giudeo-spagnolo?».
Giudeo-romanesco: la lingua degli ebrei de Roma, che ancora vive e si evolve
 «Dire che nella mia famiglia si parlasse il giudaico-romanesco in maniera stretta sarebbe una falsità. Facevamo parte di una famiglia, come tante all’inizio del dopoguerra, che riteneva che questo idioma fosse un retaggio delle classi meno acculturate, dal quale bisognava prendere delle distanze. Rimanevano solo degli usi caratteristici, delle espressioni molto colorite, a volte utilizzate per non farsi comprendere all’esterno, ma nulla di più. Detto ciò, dopo una certa fase della mia vita ho poi maturato una forte volontà di recuperare la ricchezza del lessico del giudaico-romanesco». Rav Amedeo Spagnoletto, il sofèr, lo scriba dei Sifrei Torà (i Rotoli della Torà), ma anche l’artista delle ketubot, i contratti di nozze, che si usa decorare con preziose miniature, nonché direttore del MEIS, Museo ebraico di Ferrara, parla di una riscoperta culturale, di una riappropriazione di un patrimonio, che volge lo sguardo al futuro. «Sono così andato a studiare queste espressioni, facendole mie e cominciando a utilizzarle in maniera regolare, cercando di riportarle ‘dentro’, nella famiglia che ho costituito, assieme a mia moglie e ai miei figli. Citando un’espressione, ce n’è una del dialetto ebraico romanesco che secondo me non ha equivalenti in altri giudeo-italiani, ed è una sola parola: bagnavonòd, che letteralmente è ‘a causa dei peccati’, e si pronuncia nella condivisione di un po’ di biasimo, di rassegnazione. Contiene insieme una sorta di autocritica a se stessi o alle situazioni in cui ci si trova di fronte. Rimanda ad una constatazione di delusione, alla causa di questo stato di fatto, e quindi forse anche ad una celata necessità di fare di più, di migliorare, di mettere a posto, un po’ di quel Tikkun (rimedio, riparazione) che è necessario».
«Dire che nella mia famiglia si parlasse il giudaico-romanesco in maniera stretta sarebbe una falsità. Facevamo parte di una famiglia, come tante all’inizio del dopoguerra, che riteneva che questo idioma fosse un retaggio delle classi meno acculturate, dal quale bisognava prendere delle distanze. Rimanevano solo degli usi caratteristici, delle espressioni molto colorite, a volte utilizzate per non farsi comprendere all’esterno, ma nulla di più. Detto ciò, dopo una certa fase della mia vita ho poi maturato una forte volontà di recuperare la ricchezza del lessico del giudaico-romanesco». Rav Amedeo Spagnoletto, il sofèr, lo scriba dei Sifrei Torà (i Rotoli della Torà), ma anche l’artista delle ketubot, i contratti di nozze, che si usa decorare con preziose miniature, nonché direttore del MEIS, Museo ebraico di Ferrara, parla di una riscoperta culturale, di una riappropriazione di un patrimonio, che volge lo sguardo al futuro. «Sono così andato a studiare queste espressioni, facendole mie e cominciando a utilizzarle in maniera regolare, cercando di riportarle ‘dentro’, nella famiglia che ho costituito, assieme a mia moglie e ai miei figli. Citando un’espressione, ce n’è una del dialetto ebraico romanesco che secondo me non ha equivalenti in altri giudeo-italiani, ed è una sola parola: bagnavonòd, che letteralmente è ‘a causa dei peccati’, e si pronuncia nella condivisione di un po’ di biasimo, di rassegnazione. Contiene insieme una sorta di autocritica a se stessi o alle situazioni in cui ci si trova di fronte. Rimanda ad una constatazione di delusione, alla causa di questo stato di fatto, e quindi forse anche ad una celata necessità di fare di più, di migliorare, di mettere a posto, un po’ di quel Tikkun (rimedio, riparazione) che è necessario».
Parlando del recupero dei termini antichi e anche dell’inclusione di nuovi, Spagnoletto chiarisce che «questo è possibile solo quando c’è una forte identità ebraica, se si è appassionati, se proviene dal cuore. Altrimenti di che cosa stiamo parlando?». Questo laboratorio vivente del linguaggio, per funzionare, deve avere i giusti strumenti, come leggere una pagina del Talmud o la Torà a Shabbat. «Se il mondo della letteratura, del Talmud e del Tanakh fa parte della tua vita, tu per forza di cose dici ‘la pazienza di Giobbe’, ma se non sai chi è Giobbe non ti verrà mai in mente di dirlo!».
Il teatro in giudaico-romanesco: come mantenere la lingua viva
A Roma, un modo per tenere viva la “lingua del ghetto” è recitare e assistere agli spettacoli teatrali. Sono varie le compagnie amatoriali con ormai una consolidata esperienza e tanti successi all’attivo, come la Compagnia “Quasi Stabile” di Alberto Pavoncello e “La Compagnia del giudaico-romanesco”, di Mirella Calò e Giordana Sermoneta. Su YouTube è possibile trovare diverse commedie, come Sex and the Ghetto, Tripolini e Trivolati, Starghette, un fantasy, Pur’io riderio (si o matto non fosse lo mio), O fijo de nisciuno.
 Racconta Giordana Sermoneta: «Per me il giudaico-romanesco ha un valore enorme, perché non è solo un dialetto. È l’immagine di quella che è stata la storia degli ebrei di Roma. Quando si leggono i sonetti di Crescenzo Del Monte, non senti solo una lingua: è come se tu potessi vedere le immagini. Tolto Del Monte, non abbiamo testimonianze scritte di giudaico-romanesco; perciò, il lavoro di produzione di testi in questo idioma è un compito che ci siamo assunti molto volentieri. È chiaro che il giudaico-romanesco dipende dal periodo storico che stiamo affrontando. Se la commedia è ambientata nel ghetto, sarà un linguaggio molto stretto, reale. Nei momenti in cui noi ci portiamo avanti nel tempo, il giudaico-romanesco subisce delle modifiche, nell’uso, e anche nel modo di parlarlo, perché all’epoca del ghetto era molto più forte, molto più duro, in quanto esprimeva quella violenza, quel disagio che sappiamo. Adesso è diventato quasi giocoso, anche i suoni sono più morbidi. Tutto questo fa parte di noi, e il teatro è un mezzo importantissimo per mantenere in vita questa parlata». Giordana Sermoneta ha creato un laboratorio teatrale a Roma e, nei sette anni in cui ha vissuto in Israele, anche lì si è dedicata al teatro. Tra le commedie che ha scritto e diretto «la prima è stata Sex and the Ghetto, il sesso dal punto di vista dell’Halachà, ma in chiave comica, era uno spettacolo di cabaret. Poi Tripolini e Trivolati, che raccontava l’arrivo dei tripolini negli anni ’70 e l’integrazione nella comunità di Roma, così diversa». Il teatro, dunque, come un modo divertente per scoprire (e – da non romani – cercare di capire) le coloriture di un dialetto giudaico-italiano con una storia bimillenaria.
Racconta Giordana Sermoneta: «Per me il giudaico-romanesco ha un valore enorme, perché non è solo un dialetto. È l’immagine di quella che è stata la storia degli ebrei di Roma. Quando si leggono i sonetti di Crescenzo Del Monte, non senti solo una lingua: è come se tu potessi vedere le immagini. Tolto Del Monte, non abbiamo testimonianze scritte di giudaico-romanesco; perciò, il lavoro di produzione di testi in questo idioma è un compito che ci siamo assunti molto volentieri. È chiaro che il giudaico-romanesco dipende dal periodo storico che stiamo affrontando. Se la commedia è ambientata nel ghetto, sarà un linguaggio molto stretto, reale. Nei momenti in cui noi ci portiamo avanti nel tempo, il giudaico-romanesco subisce delle modifiche, nell’uso, e anche nel modo di parlarlo, perché all’epoca del ghetto era molto più forte, molto più duro, in quanto esprimeva quella violenza, quel disagio che sappiamo. Adesso è diventato quasi giocoso, anche i suoni sono più morbidi. Tutto questo fa parte di noi, e il teatro è un mezzo importantissimo per mantenere in vita questa parlata». Giordana Sermoneta ha creato un laboratorio teatrale a Roma e, nei sette anni in cui ha vissuto in Israele, anche lì si è dedicata al teatro. Tra le commedie che ha scritto e diretto «la prima è stata Sex and the Ghetto, il sesso dal punto di vista dell’Halachà, ma in chiave comica, era uno spettacolo di cabaret. Poi Tripolini e Trivolati, che raccontava l’arrivo dei tripolini negli anni ’70 e l’integrazione nella comunità di Roma, così diversa». Il teatro, dunque, come un modo divertente per scoprire (e – da non romani – cercare di capire) le coloriture di un dialetto giudaico-italiano con una storia bimillenaria.
Teatro in giudaico-romanesco: la compagnia “Quasi stabile” di Alberto Pavoncello
 Dal 16 febbraio, chi si trovasse a passare per Roma avrà l’opportunità di ridere e commuoversi con la nuova commedia, in giudaico-romanesco, di Alberto Pavoncello dal titolo “Ma tu… a chi si’ fijo?”, che narra le vicende tragicomiche di un improbabile gruppo di “vitelloni”, in una girandola di scherzi organizzati per dare un senso alle proprie giornate. Il personaggio del protagonista è liberamente (“e indegnamente”, come scherza l’autore) ispirato ad Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo. Iniziata negli anni ‘80, la “carriera” teatrale di Pavoncello, che è anche docente di matematica (ma «le mie due anime coabitavano perfettamente, facevo contemporaneamente ricerca matematica e laboratori teatrali») nasce a scuola, quando alcuni studenti gli proposero di inscenare un’opera teatrale in giudaico romanesco; così nacque “Biancarella”. «Ho considerato sempre il teatro come uno strumento per affrontare tematiche che coinvolgessero tutti e mi permettesse di meglio arrivare nell’intimo di ognuno – ha detto Pavoncello in una intervista a Riflessi – . Volevo far ragionare lo spettatore e portarlo a teatro. I temi, ancora attuali, sono stati l’omosessualità, il bullismo, la violenza sui social, i matrimoni misti, l’Aliyà e gli anziani. Ricordo due riconoscimenti che mi hanno fatto molto piacere: quello del Consiglio della Comunità di Roma, per il mio impegno a mantenere vivo il dialetto giudaico romanesco, nel 2018, e il Premio Fiuggi per lo spettacolo, ricevuto lo stesso anno sempre per il ‘meritorio lavoro nel recupero e valorizzazione del giudaico-romanesco’».
Dal 16 febbraio, chi si trovasse a passare per Roma avrà l’opportunità di ridere e commuoversi con la nuova commedia, in giudaico-romanesco, di Alberto Pavoncello dal titolo “Ma tu… a chi si’ fijo?”, che narra le vicende tragicomiche di un improbabile gruppo di “vitelloni”, in una girandola di scherzi organizzati per dare un senso alle proprie giornate. Il personaggio del protagonista è liberamente (“e indegnamente”, come scherza l’autore) ispirato ad Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo. Iniziata negli anni ‘80, la “carriera” teatrale di Pavoncello, che è anche docente di matematica (ma «le mie due anime coabitavano perfettamente, facevo contemporaneamente ricerca matematica e laboratori teatrali») nasce a scuola, quando alcuni studenti gli proposero di inscenare un’opera teatrale in giudaico romanesco; così nacque “Biancarella”. «Ho considerato sempre il teatro come uno strumento per affrontare tematiche che coinvolgessero tutti e mi permettesse di meglio arrivare nell’intimo di ognuno – ha detto Pavoncello in una intervista a Riflessi – . Volevo far ragionare lo spettatore e portarlo a teatro. I temi, ancora attuali, sono stati l’omosessualità, il bullismo, la violenza sui social, i matrimoni misti, l’Aliyà e gli anziani. Ricordo due riconoscimenti che mi hanno fatto molto piacere: quello del Consiglio della Comunità di Roma, per il mio impegno a mantenere vivo il dialetto giudaico romanesco, nel 2018, e il Premio Fiuggi per lo spettacolo, ricevuto lo stesso anno sempre per il ‘meritorio lavoro nel recupero e valorizzazione del giudaico-romanesco’».
“Ma tu… a chi si’ fijo?”, commedia in due atti in giudaico-romanesco, va in scena al Teatro Marconi di Roma dal 16 febbraio con repliche fino al 5 marzo.
Info e prenotazioni: 06 5897589-06 6877594-338 9835684.
Il “Pugghisi”: un dialetto antico degli ebrei del Sud
Tra le parlate giudeo-romanze, ce n’è una la cui storia è durata all’incirca quattro secoli, una lingua che ha interessato vari protagonisti, compresi gli ebrei dell’Italia Meridionale ed un piccolo gruppi di ebrei sefarditi. Si tratta di una lingua pugliese chiamata: il “pugghisi”. Come riporta il sito Bari e…, al British Museum di Londra è conservato un testo antico di un dialetto pugliese. “Si tratta di una raccolta di traduzioni del XIII secolo scritte in ambiente ebraico”.
È risaputo che i primi insediamenti nel Sud Italia risalgono al 70 E.V., periodo storico in cui gli ebrei formarono le prime comunità, comprese diverse zone della Puglia. I successivi eventi della storia portarono ad una fusione dei vari dialetti che includevano vocaboli calabresi, salentini e spagnoli oltre all’apporto di altri dialetti pugliesi. “Questo dialetto – scrive Francesco Loseto – è formato dalle parole prese in prestito dai vari luoghi di provenienza, ma il suo vocabolario originale è stato irrimediabilmente impoverito e privato dei suoi elementi migliori. Un ebreo corfiota in visita in qualsiasi parte della Puglia avrebbe avuto difficoltà a capire la parlata vernacolare sebbene la struttura grammaticale fosse esattamente la stessa di quel dialetto”.



