di Michael Soncin
Una mappatura complessiva, mai realizzata prima, dell’internamento degli ebrei sul territorio italiano durante la Repubblica di Salò, in cui vengono messe in luce le connessioni con la deportazione dall’Italia, guidata dai tedeschi occupanti. È il lavoro compiuto da Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di Storia Contemporanea dell’Università della Calabria e consigliere scientifico del CDEC di Milano.
Dopo un primo capitolo dove racconta a grandi linee le vicende antisemite che hanno interessato gli ebrei con le leggi razziste del 1938, privandoli dei diritti civili, lo studioso arriva al 1943, anno in cui ne era stata messa in discussione l’esistenza stessa. L’obiettivo del fascismo, rinato a Salò in vesti repubblicane, assieme alla collaborazione delle autorità di occupazione tedesca, era la «soluzione finale del problema ebraico». Nel novembre di quell’anno, una semplice ordinanza di polizia della RSI aveva previsto l’arresto di tutti gli ebrei, il sequestro dei loro beni e l’internamento in campi “provinciali”, per poi essere trasferiti in altri più grandi, nazionali, conosciuti con il nome di “campi speciali”.

Il libro, in occasione della prima presentazione nazionale, a cura di AnpiLibri, alla Casa delle Memoria di Milano l’8 aprile, ha visto la partecipazione, assieme all’autore, degli storici Marco Cavallarin, Liliana Picciotto e Marcello Flores. Come ha detto Picciotto, nessuno di chi era internato aveva premonizione di ciò che sarebbe accaduto in seguito. I campi provinciali erano sostanzialmente campi interinali, provvisori, in edifici senza arredi. Puntualizzando che l’Italia dall’8 settembre del 1943 era sotto la dominazione della Germania, la storica ha ricordato che gli ebrei abitavano generalmente nei grandi centri urbani. Per evitare i rastrellamenti c’è chi era in dubbio se rimanere in città o nascondersi in periferia nelle campagne. Sappiamo, visti poi i fatti, che era più facile essere colti nei piccoli centri, complice una fitta rete di cercatori di ebrei, che venne attivata. Flores ha puntualizzato che la novità storiografica e documentaria della ricerca di Capogreco, non risiede solamente nella mappatura integrale dei campi all’epoca di Salò, ma anche nei racconti per mezzo di documenti e testimonianze sul loro funzionamento, dagli arresti da parte degli italiani alla deportazione tedesca: «Non lo dice per la prima volta, ma rafforza quello che i fascisti italiani hanno fatto assieme ai tedeschi. Ci rendiamo conto che la scelta di istituire i campi provinciali, che sono una galassia a quello centrale di Fossoli, fa parte di un disegno che la Repubblica Sociale di Salò vuole portare avanti fino in fondo».
Capogreco spiegando quella che è stata l’irruzione della Shoah nella penisola fa un censimento completo dei campi messi in piedi nelle zone centro-settentrionali, con una ricognizione per province: dal campo provinciale di Aosta istituito in un ex caserma, a quello di Mantova allestito nei locali del Ricovero israelitico; da quello di Tonezza nei locali della colonia alpina di Umberto I, a quello sorto nella villa di Vo’; proseguendo troviamo poi il campo provinciale di Forlì nato all’interno dell’ex albergo Commercio e quello di Roccatederighi situato nella villa di proprietà della Curia vescovile di Grosseto, utilizzato come residenza e seminario dal Vescovo. Infine, l’ultimo dell’elenco è il campo di concentramento di Civitella del Tronto nella provincia di Teramo. Questi sono solo alcuni di quelli menzionati dallo studioso.

L’autore definisce l’Italia quel paese particolare che nel settembre del 1943 passa repentinamente “dallo schieramento nazifascista a quello alleato”, dando poi vita nei territori centro-settentrionali alla Repubblica di Salò: “Uno Stato collaborazionista sul quale – in merito alla persecuzione degli ebrei – ricadono responsabilità pesantissime e i cui protagonisti, solo in pochi casi sono stati sottoposti a procedimenti giudiziari”. I campi in Italia erano molti e stupisce sapere che è un fatto ai più quasi sconosciuto. Del resto, ci sono voluti decenni affinché emergesse nella coscienza collettiva la centralità della Shoah, oltre a mettere in chiaro quella che è stata la responsabilità degli italiani.
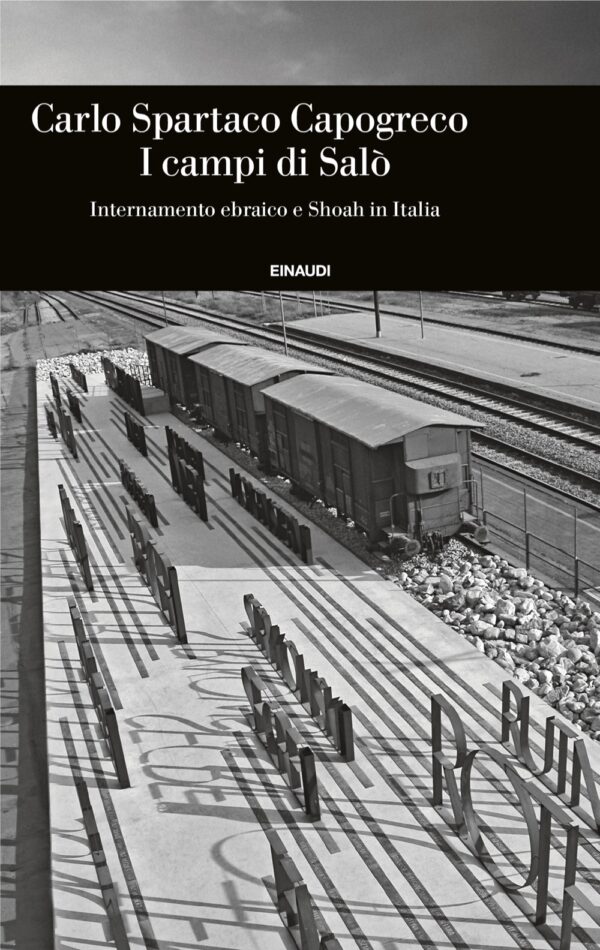
Una ricerca che dopo i quattro capitoli, trova riscontro nelle oltre cento pagine fitte di note, da un’appendice con documenti e testimonianze e una folta bibliografia. “Dei sette, lunghi anni della persecuzione antiebraica fascista, il periodo che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 fu indubbiamente quello più tragico, perché vide la Shoah irrompere nella Penisola e l’Italia di Salò supportare direttamente il genocidio”.
Un periodo, come dice Capogreco, che (nonostante il grande lavoro storiografico) rimane ancora oggi in alcune parti “poco conosciuto a quanti non siano degli addetti ai lavori”. Un periodo buio della storia italiana del secolo scorso, la cui conoscenza è senza dubbio un imperativo categorico.
Carlo Spartaco Capogreco, I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia, Einaudi, pp. XVI – 448, 30,00 euro



