di Fiona Diwan
Esce per Adelphi una nuova traduzione di Ombre sull’Hudson. Per gli ebrei che arrivano a New York dopo la guerra, le ombre della Shoah si allungano fino alle sponde del fiume Hudson. Unico possibile esorcismo è l’eros, che diventa consolazione e balsamo contro il dolore di vivere
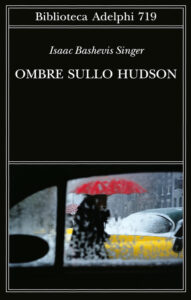 Siamo nel 1947. La guerra è appena finita ma non per il gruppo di ebrei polacchi rotolati a New York appena prima dell’ecatombe nazista. Per loro, le ombre della guerra si allungano fino alle sponde del fiume Hudson, abitano le loro anime, alimentano discorsi e incubi, affliggono i loro spiriti con la colpa dei sopravvissuti e con il senso della vita strappata a stento. Persi tra i grattacieli di Manhattan, litigano, si amano, si tradiscono, si ritrovano, in un vorticoso girotondo pieno di humour, misticismo, desiderio, rimpianto. Hertz, Boris, Solomon, Stanislaw, Anna, Leah, Esther: a New York hanno creato una piccola Varsavia ma il loro yiddish si è imbastardito, è già un potato-yiddish pieno di americanismi, i ricordi iniziano a sbiadire ma la volontà di trattenerli strazia le loro anime. Al centro della vicenda c’è l’allampanato e non più giovane Hertz Dov Grein, seduttore sgualcito ma ancora piacente, attratto dalle donne come un magnete col ferro e impegnato in un perenne corpo a corpo con se stesso e con l’Onnipotente: nel suo cuore affamato albergano passioni che non controlla, ama una donna ma viene calamitato da un’altra, è sposato, ha un’amante ma finisce per attorcigliarsi in una terza relazione. Le domande sul senso della vita e l’identità ebraica lo perseguitano: come si può vivere senza fare il Male? Che cos’è l’amore se non idolatria? Come può Dio permettere che accada agli ebrei tutto questo orrore? Dove possiamo trovare rifugio dagli abissi della nostra anima? Come fuggire dalla noia?
Siamo nel 1947. La guerra è appena finita ma non per il gruppo di ebrei polacchi rotolati a New York appena prima dell’ecatombe nazista. Per loro, le ombre della guerra si allungano fino alle sponde del fiume Hudson, abitano le loro anime, alimentano discorsi e incubi, affliggono i loro spiriti con la colpa dei sopravvissuti e con il senso della vita strappata a stento. Persi tra i grattacieli di Manhattan, litigano, si amano, si tradiscono, si ritrovano, in un vorticoso girotondo pieno di humour, misticismo, desiderio, rimpianto. Hertz, Boris, Solomon, Stanislaw, Anna, Leah, Esther: a New York hanno creato una piccola Varsavia ma il loro yiddish si è imbastardito, è già un potato-yiddish pieno di americanismi, i ricordi iniziano a sbiadire ma la volontà di trattenerli strazia le loro anime. Al centro della vicenda c’è l’allampanato e non più giovane Hertz Dov Grein, seduttore sgualcito ma ancora piacente, attratto dalle donne come un magnete col ferro e impegnato in un perenne corpo a corpo con se stesso e con l’Onnipotente: nel suo cuore affamato albergano passioni che non controlla, ama una donna ma viene calamitato da un’altra, è sposato, ha un’amante ma finisce per attorcigliarsi in una terza relazione. Le domande sul senso della vita e l’identità ebraica lo perseguitano: come si può vivere senza fare il Male? Che cos’è l’amore se non idolatria? Come può Dio permettere che accada agli ebrei tutto questo orrore? Dove possiamo trovare rifugio dagli abissi della nostra anima? Come fuggire dalla noia?
Romanzo filosofico e insieme corale, apparso sul Forwerts a puntate in yiddish nel 1957-1958, esce oggi in nuova traduzione Ombre sullo Hudson di Isaac Bashevis Singer (Adelphi, pp. 633, 24 euro), seguito con certosina e appassionata curatela da Elisabetta Zevi, con l’ottima traduzione di Valentina Parisi. Ritroviamo qui, intatto, il vasto respiro del miglior Singer, in un capolavoro che è anche il primo tra i grandi romanzi americani dello scrittore polacco, quello che inaugura la cosiddetta “trilogia newyorkese”, e a cui seguiranno Nemici. Una storia d’amore (uscito sul Forwerts nel 1966) e Il Ciarlatano (1967). Romanzi costruiti intorno ai suoi tre temi chiave, l’amore, Dio, l’ebraismo. E le donne.
L’uscita di un libro di Isaac Bashevis Singer è sempre un evento, e stupisce che neppure dopo il premio Nobel, ricevuto nell’ottobre del 1978, Singer non abbia voluto tradurre in inglese né pubblicare Ombre sull’Hudson, che uscirà postumo nel 1998, sette anni dopo la sua morte avvenuta nel 1991, a 87 anni.
Pieno di colpi di scena, amori, tradimenti e malinconie, la vicenda ruota intorno a Hertz Grein, tormentato da un’inestinguibile fame carnale, inchiodato in un triangolo amoroso che lo tortura con sensi di colpa che tuttavia non gli impediscono di consumare ogni passione fino all’ultima goccia. L’esistenza di Hertz è perennemente lacerata, scissa, duale (come per Singer). «Non era capace di vivere con Dio ma non aveva idea di come si potesse vivere senza di Lui». A un certo punto, non sa nemmeno più che cosa desiderare o volere, quale donna, quale luogo, quale scelta esistenziale. «Ciò che lui cercava non esisteva e non poteva esistere. Voleva il timore del cielo senza dogmi, la religione senza rivelazione, la disciplina senza divieti. Voleva che la Torà, la preghiera e la solitudine si fondassero su un’esperienza religiosa pura e incorrotta… Combatteva una guerra persa in partenza. Doveva stare attento a non cadere in una perversione o in una malattia mentale».
Un perenne piano inclinato minaccia gli eroi di questa narrazione fluviale, tutta ambientata in una New York limacciosa e angusta, racchiusa tra Broadway e il West Side. Non c’è speranza per gli eroi di questo romanzo dal cupo splendore, implacabile cronaca di una deriva esistenziale che è forse la sola condizione possibile per coloro che si sono arresi all’esilio. Eppure, un pessimismo allegro aleggia in quasi tutte le pagine, dense di una sconsolata e irresistibile ironia. Con uno sguardo carico di compassione, Singer narra la giostra di queste anime salve ma dalla psiche violentata e dal passato ridotto in cenere. Ombre e fantasmi a cui non resta che la vitalità dell’eros, anime nude che qabbalisticamente vagano tra il vecchio corpo, l’Europa, e la ricerca di un nuovo corpo in cui trovare alloggio, ossia questa America opulenta e sgargiante che li respinge e che loro non capiscono.
Avendo raggiunto il fratello maggiore Israel Joshua negli Stati Uniti fin dal 1935, Singer non poteva raccontare la Shoah come testimone diretto. Raccontò invece l’esperienza dei sopravvissuti arrivati in America dopo l’uragano, gli effetti psichici collaterali della tragedia: del resto era e si sentiva anch’egli un sopravvissuto, scampato all’abisso della cancellazione del suo mondo, in equilibrio instabile tra due dimensioni, né di qua né di là, sospeso tra lo shtetl e la metropoli, tra Varsavia e New York. Ecco perché in Singer tutto è duale, ambivalente: crimini del cuore e riscatto dell’anima, verità mendaci e bugie veritiere, malinconia ed euforia, impulsi e pentimenti, scrupoli e cedimenti. C’è sempre qualcosa di passionale e di vietato, di ardente e di proibito, tutto è tanto più infuocato quanto più inibito in questi sopravvissuti che si avvitano in storie d’amore multiple, riflesso di una carica libidica che la tragedia europea non è riuscita a spegnere. Perché, per questi profughi, in definitiva, l’eros diventa l’unico lenimento possibile al dolore di vivere.
Molto è stato scritto sull’estremo autobiografismo di Singer, sulle sue pulsioni autodistruttive e narcisistiche, sul suo interesse per l’aspetto mistico dell’esperienza. Non a caso, lo stesso narcisismo premuroso e svagato di Bashevis abita i suoi personaggi più riusciti, un’indole incapace di tenere a freno l’impulso scatenato dall’attrazione, incontinente in amore, come i suoi eroi, tormentato dalla dolorosa consapevolezza del male che infligge alle donne che lo amano e che lui ama («L’amore non è un gioco. L’amore può uccidere», scrive in Ricerca e Perdizione). Eppure, a ben vedere, per Singer, non si trattò mai di mera concupiscenza.
L’amore, per lui, aveva a che fare con la forza dello spirito, non del corpo. Singer sottolinea di continuo la differenza tra amore sessuale e lussuria; nella sua opera, l’amore sessuale è segno di pienezza e benessere, di una integrazione psichica realizzata. Per Singer, è grazie all’amore sessuale che un individuo riesce a evitare le pulsioni autodistruttive, le forme di alienazione anima-corpo o, in alcuni casi, la scissione mente-corpo. Non a caso, i suoi eroi sono uomini e donne a cui è stato strappato tutto meno una cosa, la vitalità dell’eros. Eros e sopravvivenza riuniti in un abbraccio indissolubile ma non salvifico. Da molti è stato notato che il talento particolare di Singer sta nella capacità di sviluppare narrativamente l’archetipo della battaglia tra Bene e Male che abita in ciascuno di noi, che è anche tra le fondamentali opzioni esistenziali degli ebrei moderni. «Singer, come molti altri scrittori yiddish – Chaim Grade e Aaron Zeitlin – patisce oltremodo il senso di colpa per essere sopravvissuto, per non aver avuto “il privilegio di attraversare l’Olocausto hitleriano”, come dice egli stesso. Una prospettiva che ha influenzato il suo lavoro e ha animato una forma estrema di disperato nichilismo con le sue inevitabili tendenze autodistruttive», ha notato lo studioso Jan Schwarz.
Infine, una notazione importante. Pubblicato postumo, uscito per la prima volta nel 1998, questo romanzo “tentacolare” e maestoso non ha subito il rifacimento-adattamento a cui Singer di solito sottoponeva la traduzione dei suoi romanzi; per Ombre sull’Hudson non è mai esistito un “secondo originale”, come Singer chiamava le sue auto traduzioni (“I am a bilingual writer, this is my second original”). Pertanto la traduzione in inglese ad opera dello yiddishista Joseph Sherman avvenne direttamente dall’originale yiddish integrale del 1958, senza che ci sia stato il lavoro di riscrittura e rielaborazione a cui Singer sottoponeva la versione inglese, riadattandola per un pubblico goy e non ebraico, e espungendo tutto ciò che poteva risultare urticante, le battute poco cristiane, le criptocitazioni bibliche, i riferimenti talmudici o qabbalistici… Ecco perché il romanzo risulta così ampio (600 pagine) e pieno di particolari: conserva l’impianto, i dettagli e la struttura della primigenia versione yiddish. Un capolavoro che ci permette così di assaggiare a crudo la scrittura di Bashevis, prima che venga cucinata nell’inglese. Una prelibata rarità.



