di Marina Gersony
Fortunose, casuali, rocambolesche, inverosimili eppure reali… Quante salvezze possibili ci sono? Quanti modi per farcela,
in condizioni estreme? perché ci si salva? Ingegno, resilienza, solidarietà, caso… I salvati ricordano: ecco alcune delle loro incredibili peripezie e storie, anche inedite
«In quanto figlio della Shoah e cittadino europeo mi è caro il Giorno della Memoria, che è però anch’essa arrivata a una crisi di senso e di comunicazione. Le attuali stantie forme celebrative sono in consunzione ed è necessario ripensarla quanto prima, specie in relazione all’attualità dell’antisemitismo contemporaneo, che è fenomeno vasto e complesso, con fila eterogenee e inquietanti». Così scriveva tre mesi fa, nel suo testamento spirituale, Rav Giuseppe Laras z’z”l. Una Memoria come anticorpo contro l’oblio, la negazione e le falsificazioni del passato sempre più in atto: da un lato con l’obbligo di dare massima diffusione di quello che è stata la Shoah, elemento costitutivo dell’identità ebraica contemporanea; dall’altro una Memoria che non sia esclusivamente ripiegata su se stessa, bensì dinamica e progettuale. La domanda è dunque sempre la stessa: come mantenere viva una Memoria sempre più in bilico tra disincanto e ipertrofia del ricordo? Come conservarla senza che essa appaia dogmatica, ripetitiva e apologetica o, peggio ancora, una sorta di contemplazione istituzionalizzata e “doloristica” del passato? L’esortazione di Laras coincide non a caso con l’uscita del libro Salvarsi di Liliana Picciotto, realizzato dal CDEC, un volume prezioso, frutto di nove anni di ricerche, in cui i protagonisti non sono solo gli ebrei italiani, vittime dell’Olocausto, bensì coloro i quali, per varie circostanze, sono riusciti a salvarsi facendo fallire il progetto criminale di chi aspirava all’annientamento di un popolo intero.
Sono numerosi gli episodi di salvezza, per lo più sconosciuti e straordinari, in Italia e in Europa, dovuti a caso, fortuna, contesto sociale, amicizie, ingegno, preveggenza, legami professionali, conoscenze nel mondo ecclesiastico o diponibilità di denaro; vicende commoventi e sorprendenti che oggi risuonano come un inno alla vita e alla speranza. Storie paradigmatiche che per ragioni imperscrutabili sono emerse molti anni dopo, fino ad oggi, quando ormai i sopravvissuti sono quasi tutti scomparsi e magari le testimonianze sono consegnate ai ricordi di seconda mano.
Storie note o anche sconosciute. C’è quella incredibile e spaventosa di 38 ebrei tra i 2 ed i 76 anni che per ben 511 giorni sono sopravvissuti ai nazisti in un reticolo di grotte buie, sotto terra, nell’Ucraina dell’Ovest, raccontata nel documentario No place on Earth di Janet Tobias che lascia increduli davanti al lieto fine del “tutti salvi” (https://www.youtube.com/watch?v=q0vuJRFn1q4).
E c’è la storia di un anello “magico”, oggi conservato in un armadietto a temperatura controllata presso l’United States Holocaust Memorial Museum, anello che ha salvato diverse vite: il “signore dell’anello” si chiamava Abramo “Bumek” Gruber, titolare della macelleria kasher di Drohobycz. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale riuscì a nascondersi nella foresta e ci restò anche quando arrivarono i nazisti, i quali confinarono in un ghetto i circa 14.000 ebrei della cittadina oggi ucraina ma ai tempi polacca. Tra una fuga e l’altra, Bumek raccolse alcuni pezzi di un lampadario di vetro, mandato in frantumi dalle SS, e chiese a un amico gioielliere di farne un anello. Un giorno, disse, avrebbe potuto essergli utile. Così è stato. In una situazione di sommo pericolo riuscì a spacciarlo per un anello di diamanti assicurando la propria sopravvivenza e quella di una madre e di sua figlia, scappate dal ghetto. (www.youtube.com/watch? v=O6VcYZVCUic).
Ci sono poi le storie di quelle migliaia di ebrei italiani, europei e apolidi, costretti ad abbandonare le proprie case per evitare la deportazione e i loro tentativi di attraversare clandestinamente il confine italo-svizzero per trovare rifugio in territorio elvetico, (ricordiamo il libro La Frontiera della Speranza, di Renata Broggini, Mondadori, 1998). Non tutti riuscirono a farcela, traditi dai passatori al confine, arrestati dalle milizie repubblichine o respinti dalle guardie di frontiera svizzere. Ma circa 6000 ebrei riuscirono a passare. Tra loro, Adriana Luzzati, vedova Bassani, classe 1928, che insieme alla sua famiglia è riuscita a sopravvivere e che oggi racconta, in un libro dedicato ai figli e nipoti: «L’8 settembre, quando fu dichiarato dal Maresciallo Badoglio l’armistizio con gli Alleati e i tedeschi divennero nemici dell’Italia, la posizione degli ebrei divenne estremamente pericolosa. Come ogni estate avevamo trascorso le vacanze ad Andora, sulla riviera ligure. Con mia mamma, Michelina Momigliano vedova Luzzati e me, c’erano mia sorella Bianca Luzzati, suo marito Vittorio Tedeschi, suo suocero Ettore Tedeschi, la piccola Delia di 3 anni e la mamma di mia mamma, Sofia». La famiglia iniziò la sua fuga verso la salvezza passando per Asti dove risiedeva abitualmente, nascondendosi in seguito in una località chiamata Calosso e poi in una cascina a Cessole, nelle Langhe, protetta per otto mesi da brava gente in cambio di una piccola cifra che non ripagava certamente l’enorme rischio che correva. Infine la fuga definitiva nel ’44 in Svizzera: «Noi siamo stati bene in terra elvetica – scrive Adriana Luzzati – e io ringrazio chi ha accolto la mia famiglia e deploro che molti, pur essendo stati salvati, anche con difficoltà e peripezie, accusino gli svizzeri per il loro comportamento».
 In Svizzera approdò anche Harry Gersony (il nonno della giornalista che qui scrive), insieme alla sua famiglia, dopo una fuga a dir poco rocambolesca. Figlio di una ricca famiglia sefardita che commerciava in granaglie, vissuta tra la Lettonia e la Romania, il giovane Harry, apolide, studiò a Istanbul e venne in Italia per continuare l’attività famigliare. Fece fortuna, sposò Helena Fraenkel, una giovane askenazita austro-polacca, nacquero Guido e Daisy registrati come cittadini russi, poi apolidi e infine italiani dopo la guerra. Con l’emanazione delle Leggi razziali del 1938, circa 5.000 ebrei stranieri furono costretti a lasciare il Paese. In quelle circostanze, Harry fu prelevato e deportato nel campo di internamento di Ferramonti, nel comune di Tarsia in provincia di Cosenza, destinato ad ebrei, apolidi, stranieri nemici e slavi. Il campo era stato aperto dal regime fascista tra il giugno e il settembre 1940, all’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia. Harry era un bell’uomo alto e imponente con due occhi azzurrissimi dal taglio orientale, e avrebbe potuto facilmente farsi passare per un soldato tedesco. E così fece. Parlava nove lingue, tra cui un perfetto Hochdeutsch: a quei tempi, gli ebrei poliglotti non erano certo una rarità. Riuscì a rubare la divisa di un soldato tedesco dopo aver studiato le abitudini dei militari del campo e l’indomani si arrampicò su un camion delle SS che faceva la spola con l’Italia del Nord. Il giovanotto aveva del fegato. Per tutto il tragitto riuscì a simulare la sua vera identità e nessuno si accorse dell’imbroglio. «Era il 1943, mio padre ci raggiunse e tutti insieme siamo tornati nella nostra villa di Desenzano del Garda. Ma dopo l’8 settembre – racconta la figlia, Daisy, oggi 86 anni – ci avvisarono che stavano venendo i nazisti a prelevarci. Così abbiamo raccolto quello che potevamo. Mia madre nascose i gioielli dentro la pelliccia, ci sarebbero potuti servire. A bordo di un calesse, con il nome falsificato in Geroni, siamo andati nel mantovano, dove il Professor Migliorini ci ha nascosti nella soffitta di una cascina dell’Oltrepò Pavese. Non potevamo uscire, ma un giorno mio fratello Guido prese la bicicletta di nascosto per scorrazzare, in una illusoria ebrezza di libertà, nella campagna circostante. Il fatto ci costò caro. Guido non aveva l’aria di un contadino, così hanno cominciato a indagare e siamo dovuti scappare anche da lì. Mio padre Harry si era messo d’accordo con dei contrabbandieri, i passeur, per scappare in Svizzera. Bisognava oltrepassare un filo spinato, correre attraverso una no man’s land, e poi ancora dopo un altro filo spinato, fino al confine svizzero. Non fu facile. Tentammo due volte e fallimmo, ma la terza siamo finalmente riusciti a passare. Ricordo mio padre che mi teneva per mano urlando a me e a mio fratello “correte, correte”… La prima cosa che notai, oltre il confine, furono le luci. In Italia c’era l’oscuramento, quello scintillio di luci improvviso era stupefacente. Ci accolsero e ci rifocillarono. Mio padre aveva un contatto in Svizzera, un avvocato che era stato allertato di un nostro possibile arrivo. Mi hanno dato una banana, e io ricordo la felicità. Ci hanno portati in un campo per rifugiati dove ci hanno messi in quarantena per circa tre settimane. Ricordo le condizioni di vita precarie, stanze prive di riscaldamento, il cibo scarso. In seguito siamo andati a Les Avants-Montreux, sopra il Lemano, nel Canton di Vaud, un campo di internamento ricavato da un ex albergo, sotto stretta sorveglianza militare. Ospitava fino a 600 profughi di varie nazionalità. C’erano ebrei, militari, politici e antifascisti e poi Dino Segre, il celebre scrittore noto con lo pseudonimo di Pitigrilli… Ho raccontato quell’esperienza in un quaderno destinato ai miei figli e ai miei nipoti. Finita la guerra siamo tornati a Desenzano. La nostra villa, prima occupata dai nazisti, in seguito è diventata il Comando dell’American Headquarters. C’è voluto del tempo prima che mio padre riuscisse a mandarli via. Siamo stati molto fortunati perché mio padre aveva denaro e relazioni importanti che in quel frangente seppe mettere a frutto. Non tutti, a parità di mezzi, hanno avuto la stessa fortuna».
In Svizzera approdò anche Harry Gersony (il nonno della giornalista che qui scrive), insieme alla sua famiglia, dopo una fuga a dir poco rocambolesca. Figlio di una ricca famiglia sefardita che commerciava in granaglie, vissuta tra la Lettonia e la Romania, il giovane Harry, apolide, studiò a Istanbul e venne in Italia per continuare l’attività famigliare. Fece fortuna, sposò Helena Fraenkel, una giovane askenazita austro-polacca, nacquero Guido e Daisy registrati come cittadini russi, poi apolidi e infine italiani dopo la guerra. Con l’emanazione delle Leggi razziali del 1938, circa 5.000 ebrei stranieri furono costretti a lasciare il Paese. In quelle circostanze, Harry fu prelevato e deportato nel campo di internamento di Ferramonti, nel comune di Tarsia in provincia di Cosenza, destinato ad ebrei, apolidi, stranieri nemici e slavi. Il campo era stato aperto dal regime fascista tra il giugno e il settembre 1940, all’indomani dell’entrata in guerra dell’Italia. Harry era un bell’uomo alto e imponente con due occhi azzurrissimi dal taglio orientale, e avrebbe potuto facilmente farsi passare per un soldato tedesco. E così fece. Parlava nove lingue, tra cui un perfetto Hochdeutsch: a quei tempi, gli ebrei poliglotti non erano certo una rarità. Riuscì a rubare la divisa di un soldato tedesco dopo aver studiato le abitudini dei militari del campo e l’indomani si arrampicò su un camion delle SS che faceva la spola con l’Italia del Nord. Il giovanotto aveva del fegato. Per tutto il tragitto riuscì a simulare la sua vera identità e nessuno si accorse dell’imbroglio. «Era il 1943, mio padre ci raggiunse e tutti insieme siamo tornati nella nostra villa di Desenzano del Garda. Ma dopo l’8 settembre – racconta la figlia, Daisy, oggi 86 anni – ci avvisarono che stavano venendo i nazisti a prelevarci. Così abbiamo raccolto quello che potevamo. Mia madre nascose i gioielli dentro la pelliccia, ci sarebbero potuti servire. A bordo di un calesse, con il nome falsificato in Geroni, siamo andati nel mantovano, dove il Professor Migliorini ci ha nascosti nella soffitta di una cascina dell’Oltrepò Pavese. Non potevamo uscire, ma un giorno mio fratello Guido prese la bicicletta di nascosto per scorrazzare, in una illusoria ebrezza di libertà, nella campagna circostante. Il fatto ci costò caro. Guido non aveva l’aria di un contadino, così hanno cominciato a indagare e siamo dovuti scappare anche da lì. Mio padre Harry si era messo d’accordo con dei contrabbandieri, i passeur, per scappare in Svizzera. Bisognava oltrepassare un filo spinato, correre attraverso una no man’s land, e poi ancora dopo un altro filo spinato, fino al confine svizzero. Non fu facile. Tentammo due volte e fallimmo, ma la terza siamo finalmente riusciti a passare. Ricordo mio padre che mi teneva per mano urlando a me e a mio fratello “correte, correte”… La prima cosa che notai, oltre il confine, furono le luci. In Italia c’era l’oscuramento, quello scintillio di luci improvviso era stupefacente. Ci accolsero e ci rifocillarono. Mio padre aveva un contatto in Svizzera, un avvocato che era stato allertato di un nostro possibile arrivo. Mi hanno dato una banana, e io ricordo la felicità. Ci hanno portati in un campo per rifugiati dove ci hanno messi in quarantena per circa tre settimane. Ricordo le condizioni di vita precarie, stanze prive di riscaldamento, il cibo scarso. In seguito siamo andati a Les Avants-Montreux, sopra il Lemano, nel Canton di Vaud, un campo di internamento ricavato da un ex albergo, sotto stretta sorveglianza militare. Ospitava fino a 600 profughi di varie nazionalità. C’erano ebrei, militari, politici e antifascisti e poi Dino Segre, il celebre scrittore noto con lo pseudonimo di Pitigrilli… Ho raccontato quell’esperienza in un quaderno destinato ai miei figli e ai miei nipoti. Finita la guerra siamo tornati a Desenzano. La nostra villa, prima occupata dai nazisti, in seguito è diventata il Comando dell’American Headquarters. C’è voluto del tempo prima che mio padre riuscisse a mandarli via. Siamo stati molto fortunati perché mio padre aveva denaro e relazioni importanti che in quel frangente seppe mettere a frutto. Non tutti, a parità di mezzi, hanno avuto la stessa fortuna».
Quante salvezze possibili?
Fortunose, casuali, rocambolesche, inverosimili eppure reali… Quante salvezze possibili ci sono, quanti modi per farcela, in condizioni così estreme? Perché ci si salva? E che cosa resta nella psiche dei “salvati”, dopo, a guerra finita? O ancora, cosa accade quando scatta il “tutti a casa” ma di quella casa non è rimasto in piedi niente? Ci si salva perché si agisce, perché non si resta passivi o grazie a una fatalità propizia, perché il destino ci mette davanti dei solerti soccorritori? In quale modo si attivano energie di resistenza tali da smuovere risorse e ingegno e portarci “oltre il ponte”? Nel caso dei sopravvissuti ai lager, come ad esempio Primo Levi, Bruno Bettelheim e molti altri, non sempre i salvati ce l’hanno fatta a salvarsi davvero: c’è chi non resiste al senso di colpa, chi si spegne a distanza di un decennio, chi non riesce a cancellare il marchio a fuoco del ricordo, quello dei propri cari. Ma c’è anche chi fa della propria salvezza una missione e un inno alla vita, come nel caso di storie come quella, poco conosciuta, dei Bambini di Teheran e della loro incredibile odissea.
 In realtà, sulla vicenda esiste un bel documentario girato nel 2009 da registi israeliani e reperibile online con testimonianze inedite dei sopravvissuti (The Children of Teheran, di Yehuda Kaveh, David Tour, Dalia Guttman). La storia ha dell’inverosimile: dopo aver siglato nel mese di agosto del 1939 il Patto Ribbentrop-Molotov, Hitler e Stalin si spartirono la Polonia. Centinaia di migliaia di ebrei polacchi, tra i quali molti bambini e adolescenti, furono costretti ad attraversare il confine orientale polacco dopo una campagna di arresti ed espulsioni. Molti di loro erano orfani, altri erano stati fatti scappare dalla Polonia di nascosto dai genitori o affidati, prima dell’espatrio forzato, a orfanotrofi o istituzioni religiose. Oltre un milione di polacchi cristiani subì lo stesso destino. Intere famiglie furono distrutte. Quale delle due occupazioni, se quella nazista o se quella sovietica, abbia causato più disperazione è difficile dirlo. Testimoni ricordano settimane di viaggio in condizioni disumane, caricati su carri bestiame e mezzi di fortuna. Meta finale? La Siberia, le gelide lande desolate della tundra e le immense foreste, come ad Arkhangelsk, nel nord, dove gli ebrei si ritrovavano a tagliare alberi per fare legna destinata al commercio. La vita era dura da quelle parti, al limite della sopravvivenza, con famiglie costrette a condividere una stanza, una cucina e un gabinetto situato all’aperto. Quando la Germania nazista attaccò l’Unione Sovietica il 22 giugno 1941, i profughi utilizzati nei campi, nelle foreste e nelle miniere, furono dichiarati “liberi” di andare e spostarsi. Iniziarono così a sparpagliarsi verso le Repubbliche dell’Asia Centrale, Uzbekistan, Tagjikistan, Kirgisistan, Kazakistan, Turkmenistan. Denutriti, malati, affamati e vestiti di stracci, vissero in stanzoni senza letti e senza acqua con notti trascorse a dormire per terra e code infinite per mangiare un misero pezzo di pane. Il 25 agosto 1941, gli inglesi e i sovietici invasero l’Iran, e lì furono trasferiti 33mila soldati polacchi nonché gli 11mila rifugiati, ivi compresi i 3mila bambini che vagabondavano per le lande dell’Asia Centrale, di cui almeno un migliaio erano orfani ebrei. Partirono in treno da Samarcanda per Krasnovodosk e poi, attraverso il mar Caspio, raggiunsero Pahlevi, un porto iraniano sulla costa orientale del Caspio. Da qui fino a Teheran, destinati a un campo rifugiati allestito nell’agosto 1942 e finanziato dal governo polacco in esilio; cibo e medicine erano fornite dalla comunità ebraica iraniana, dalla Croce Rossa americana, da organizzazioni ebraiche e sioniste. Gli iraniani furono tra i primi ad apprendere dai racconti dei piccoli profughi di ciò che Hitler stava facendo in Europa. I “Bambini” di Teheran raccontarono, parlarono, e nella Persia lontana si seppe dei lager. Nel 1942, la Jewish Agency aprì la sua prima sede a Teheran per organizzare il trasferimento dei rifugiati minorenni ebrei in Palestina, via mare (Karachi e Aden), e via terra (attraverso l’Iraq, scortati dai militari britannici). Giunti in quello che sarebbe diventato lo Stato di Israele, furono smistati in base alla famiglia di provenienza: i figli di rabbini furono destinati allo studio della Torà, molti altri ai kibbutz. Finiva così un’odissea iniziata quasi quattro anni prima e lunga tredicimila chilometri, una marcia della salvezza percorsa quasi tutta a piedi. (www.youtube.com/watch?v=fXRVcvlG1CE9).
In realtà, sulla vicenda esiste un bel documentario girato nel 2009 da registi israeliani e reperibile online con testimonianze inedite dei sopravvissuti (The Children of Teheran, di Yehuda Kaveh, David Tour, Dalia Guttman). La storia ha dell’inverosimile: dopo aver siglato nel mese di agosto del 1939 il Patto Ribbentrop-Molotov, Hitler e Stalin si spartirono la Polonia. Centinaia di migliaia di ebrei polacchi, tra i quali molti bambini e adolescenti, furono costretti ad attraversare il confine orientale polacco dopo una campagna di arresti ed espulsioni. Molti di loro erano orfani, altri erano stati fatti scappare dalla Polonia di nascosto dai genitori o affidati, prima dell’espatrio forzato, a orfanotrofi o istituzioni religiose. Oltre un milione di polacchi cristiani subì lo stesso destino. Intere famiglie furono distrutte. Quale delle due occupazioni, se quella nazista o se quella sovietica, abbia causato più disperazione è difficile dirlo. Testimoni ricordano settimane di viaggio in condizioni disumane, caricati su carri bestiame e mezzi di fortuna. Meta finale? La Siberia, le gelide lande desolate della tundra e le immense foreste, come ad Arkhangelsk, nel nord, dove gli ebrei si ritrovavano a tagliare alberi per fare legna destinata al commercio. La vita era dura da quelle parti, al limite della sopravvivenza, con famiglie costrette a condividere una stanza, una cucina e un gabinetto situato all’aperto. Quando la Germania nazista attaccò l’Unione Sovietica il 22 giugno 1941, i profughi utilizzati nei campi, nelle foreste e nelle miniere, furono dichiarati “liberi” di andare e spostarsi. Iniziarono così a sparpagliarsi verso le Repubbliche dell’Asia Centrale, Uzbekistan, Tagjikistan, Kirgisistan, Kazakistan, Turkmenistan. Denutriti, malati, affamati e vestiti di stracci, vissero in stanzoni senza letti e senza acqua con notti trascorse a dormire per terra e code infinite per mangiare un misero pezzo di pane. Il 25 agosto 1941, gli inglesi e i sovietici invasero l’Iran, e lì furono trasferiti 33mila soldati polacchi nonché gli 11mila rifugiati, ivi compresi i 3mila bambini che vagabondavano per le lande dell’Asia Centrale, di cui almeno un migliaio erano orfani ebrei. Partirono in treno da Samarcanda per Krasnovodosk e poi, attraverso il mar Caspio, raggiunsero Pahlevi, un porto iraniano sulla costa orientale del Caspio. Da qui fino a Teheran, destinati a un campo rifugiati allestito nell’agosto 1942 e finanziato dal governo polacco in esilio; cibo e medicine erano fornite dalla comunità ebraica iraniana, dalla Croce Rossa americana, da organizzazioni ebraiche e sioniste. Gli iraniani furono tra i primi ad apprendere dai racconti dei piccoli profughi di ciò che Hitler stava facendo in Europa. I “Bambini” di Teheran raccontarono, parlarono, e nella Persia lontana si seppe dei lager. Nel 1942, la Jewish Agency aprì la sua prima sede a Teheran per organizzare il trasferimento dei rifugiati minorenni ebrei in Palestina, via mare (Karachi e Aden), e via terra (attraverso l’Iraq, scortati dai militari britannici). Giunti in quello che sarebbe diventato lo Stato di Israele, furono smistati in base alla famiglia di provenienza: i figli di rabbini furono destinati allo studio della Torà, molti altri ai kibbutz. Finiva così un’odissea iniziata quasi quattro anni prima e lunga tredicimila chilometri, una marcia della salvezza percorsa quasi tutta a piedi. (www.youtube.com/watch?v=fXRVcvlG1CE9).
Protetti dalla gente comune
Rosetta Sermoneta Ajò nacque a Roma, il 19 aprile del 1936. La sua è una delle tante storie raccolte da Liliana Picciotto nel libro Salvarsi, e narra la solidarietà di alcuni italiani nei confronti degli ebrei perseguitati. «Verso le sette di mattina del 16 ottobre 1943 le SS bussarono alla nostra porta in via degli Scipioni 35 – racconta Rosetta a Liliana Picciotto in un’intervista rilasciata a Gerusalemme nel 2007 -. Mio padre, ancora in pigiama, aprì tranquillamente. Erano i tedeschi, entrarono senza tanti complimenti, davanti ai nostri occhi attoniti tagliarono il filo del telefono e bucarono le gomme della mia bicicletta. In casa eravamo io, i miei genitori e mio nonno. Ci consegnarono un biglietto dove ci ordinavano di essere pronti entro venti minuti, di portare indumenti pesanti e viveri per almeno otto giorni». Frastornata, la famiglia eseguì gli ordini all’istante e scese per strada scortata da due tedeschi. Vicino al portone c’era molta gente in coda davanti al panettiere e al fruttivendolo che iniziò a chiedere cosa stava succedendo. «Non sapevamo cosa rispondere – ricorda Rosetta – ma era chiaro che eravamo disperati». Piano piano, una folla di persone sconosciute cominciò a seguire la famiglia scortata dai tedeschi fino a formare un corteo che man mano si ingrossava sempre di più. «All’altezza del benzinaio, la gente accerchiò noi e il soldato tedesco. In pochi attimi, una ragazza mi prese per mano e mi trascinò via […]. Anche a mia mamma, al papà e al nonno stava accadendo la stessa cosa […]. Il tedesco, forse impaurito, faceva finta di nulla». Alla fine, aiutati dalla gente comune, Rosetta e la sua famiglia riuscirono a svoltare l’angolo e a correre verso un palazzo e finirono in cantina. Seguirono altri nascondigli, prima presso un barbiere amico che abitava al Testaccio, poi nella Chiesa di Santa Maria Liberatrice e infine in diversi conventi, tra i quali quello delle suore francescane nel quartiere di Roma Prati: «Una suora in particolare, suor Francesca, salvò la mia famiglia e altri ebrei, nascondendoci all’interno del campanile della chiesa di San Gioacchino». Finita la guerra, Rosetta e la sua famiglia ne avevano abbastanza di leggi antiebraiche, di fughe e di arresti, così si trasferirono in Israele per iniziare una nuova vita.
Alice o la musica della vita
Storie simili, ma anche molto diverse tra loro, vengono raccontate dai testimoni con quel linguaggio intimo proprio di una narrazione sofferta, capace di innescare un processo di identificazione in chi le legge o le ascolta. Come la storia di Alice Herz-Sommer, conosciuta anche come Alice Sommer, una pianista ceca naturalizzata britannica. Nata a Praga nel 1903 in una famiglia di commercianti, crebbe in un ambiente colto, ricco di stimoli e raffinato. Da bambina incontrò personaggi come Gustav Mahler e Franz Kafka.
 Sensibile e ricettiva, la piccola Alice si appassionò presto al pianoforte. In seguito, con l’occupazione tedesca della Cecoslovacchia nel marzo 1938, la maggior parte della sua famiglia emigrò in Palestina mentre lei rimase a Praga per prendersi cura della madre malata, mandata nel campo di Theresienstadt nel 1942. L’anno successivo, anche Alice fu a sua volta deportata nello stesso campo della madre insieme a suo figlio e a suo marito, poi trasferito ad Auschwitz e morto a Dachau nel 1944. Fu la musica a salvarle la vita. I gerarchi del lager, per motivi di propaganda, si vantavano nell’esibire orchestre composte da prigionieri pieni di talento e musicisti di professione. A Theresienstadt Alice suonò, con disperato virtuosismo e a memoria, centinaia di concerti, senza disporre di nessuno spartito e su un logoro pianoforte. Sopravvissuta ai campi, tornò a Praga nel 1945 e in seguito emigrò in Israele dove insegnò musica a Gerusalemme. Molti anni dopo, nel 1986, si trasferì a Londra con il figlio. Le cronache raccontano che fino all’età di 97 anni ha praticato nuoto e fino a 107 anni ha suonato pianoforte ogni giorno, come si può constatare nei video su youtube. Alice è scomparsa a 110 anni per cause naturali.
Sensibile e ricettiva, la piccola Alice si appassionò presto al pianoforte. In seguito, con l’occupazione tedesca della Cecoslovacchia nel marzo 1938, la maggior parte della sua famiglia emigrò in Palestina mentre lei rimase a Praga per prendersi cura della madre malata, mandata nel campo di Theresienstadt nel 1942. L’anno successivo, anche Alice fu a sua volta deportata nello stesso campo della madre insieme a suo figlio e a suo marito, poi trasferito ad Auschwitz e morto a Dachau nel 1944. Fu la musica a salvarle la vita. I gerarchi del lager, per motivi di propaganda, si vantavano nell’esibire orchestre composte da prigionieri pieni di talento e musicisti di professione. A Theresienstadt Alice suonò, con disperato virtuosismo e a memoria, centinaia di concerti, senza disporre di nessuno spartito e su un logoro pianoforte. Sopravvissuta ai campi, tornò a Praga nel 1945 e in seguito emigrò in Israele dove insegnò musica a Gerusalemme. Molti anni dopo, nel 1986, si trasferì a Londra con il figlio. Le cronache raccontano che fino all’età di 97 anni ha praticato nuoto e fino a 107 anni ha suonato pianoforte ogni giorno, come si può constatare nei video su youtube. Alice è scomparsa a 110 anni per cause naturali.
All’epoca del decesso, nel 2014, era la persona più vecchia sopravvissuta alla Shoah (www.youtube.com/watch?v=8oxO3M6rAPw).
E che dire della vicenda di Vera Friedländer? I nazisti a Berlino la consideravano una “mezza ebrea”, una Halbjuden, una Mischling. Sopravvissuta all’Olocausto, oggi è una scrittrice. Sua madre apparteneva a una grande famiglia ebraica, suo padre era cristiano. Di Vera Friedländer, classe 1928, nome vero Veronika Schmidt nata Rudau, solo tre su ventisette membri della famiglia sopravvissero alla Shoah. Un coraggioso preside permise a Vera di frequentare una scuola commerciale nonostante fosse vietata agli ebrei. Lei non disse mai a nessuno, neppure ai suoi amici più cari, di essere una “mezza ebrea” nascondendo la sua vera identità. Nel 1944, i mariti ariani di donne ebree potevano scegliere se divorziare oppure lasciare che le loro mogli ebree finissero deportate o mandate in un campo di concentramento. La maggior parte di loro scelse di seguire le proprie consorti nei campi, come fece il padre di Vera. Quella dei matrimoni misti e dei Halbjuden (mezzi ebrei) durante il nazismo è una storia ancora tutta da scrivere: in questo contesto, vale la pena ricordare La protesta di Rosenstrasse, una protesta non violenta nella Rosenstraße (via Delle Rose) di Berlino nel febbraio e marzo del 1943, effettuata dalle mogli non ebree e dai parenti di uomini ebrei che erano stati arrestati per la deportazione. La protesta sortì come effetto di ottenere la liberazione degli uomini. Fu un esempio significativo di opposizione agli eventi, ma è anche la conferma dell’ambiguità delle Leggi razziali promulgate da Hitler. Ma torniamo a Vera Friedländer. La ragazza sedicenne finì ai lavori forzati per una ditta produttrice di scarpe, la Salamander, che in seguito ha cercato di negare, senza successo, di avere avuto lavoratori forzati, schiavi, alle sue dipendenze. Un lavoro estenuante, quello di Vera, centinaia di scarpe provenienti dai campi di concentramento da rigenerare e ripristinare senza nessun attrezzo, a mani nude, con le dita che sanguinavano e i polpastrelli gonfi ridotti a una massa informe. I detenuti, indeboliti e malnutriti, erano sottoposti a loro volta a un lavoro disumano, molti morirono per esaurimento. Tutti gli altri vivevano con la costante paura di non farcela a sopravvivere. Anche la minima negligenza di Vera, la “mezza ebrea”, avrebbe potuto portarla in un campo di concentramento. Dopo la guerra, la giovane ha ricostruito la sua esistenza con successo e oggi, a 89 anni, è ancora qui a raccontarcela. (www.youtube.com/watch?v=Dfth3iHi30Y&t=359s).
soccorritori e aiuto
Che cosa accomuna quindi, alla fine, tutte queste storie e destini? Ci si salva per una questione di fortuna, di caso, di sesto senso, di ingegno, di resilienza, di una particolare resistenza fisica e psicologica, di capacità di far leva sulle conoscenze giuste, di trovarsi nel posto gusto al momento giusto? O forse che il “salvarsi” sia attribuibile soprattutto alla perspicacia di alcuni che hanno visto lungo e si sono organizzati in tempo? Molteplici le risposte che Liliana Picciotto fornisce nel suo libro, nel quale un grande spazio è riservato anche ai soccorritori, tema anch’esso importante che meriterebbe un discorso a parte. Difficile invece trovare un denominatore comune, poiché ogni storia è unica e somiglia solo a se stessa: ci sono state le fughe collettive di piccoli gruppi che si sono organizzati; quelle di chi ha ricevuto aiuto dal mondo cattolico (sono tanti) o dalle comunità evangeliche; ci sono le storie di salvezza legate alla capacità del singolo di simulazione, come quella di Federico Sacerdote, classe 1922, che grazie a un medico antifascista riuscì a farsi ricoverare in ospedale come finto malato di sifilide nonostante le perquisizioni da parte del questore…; ci sono storie di coraggio come chi, salvandosi, non esitò a buttarsi giù dalla finestra. E poi ancora e ancora…
Liliana Picciotto: il segreto dei salvati? Resilienza e forza interiore
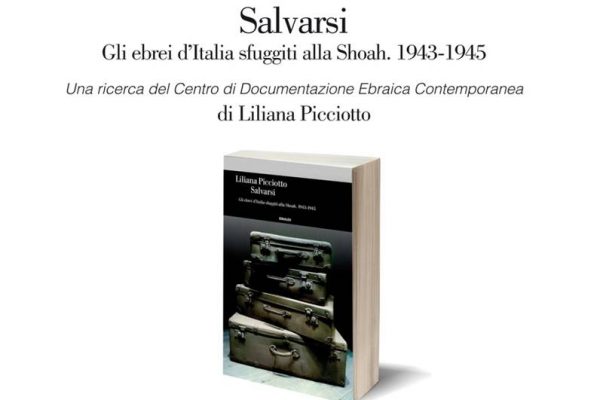 Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia furono più dell’81 per cento. Nel libro Salvarsi – Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945, di Liliana Picciotto (Einaudi Storia; pp. 570; € 38,00), vengono presentati i risultati del progetto Memoria della salvezza del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), generosamente sostenuto dalla Viterbi Family Foundation, condotto con i ricercatori Chiara Ferrarotti, Luciana Laudi e Gloria Pescarolo; un progetto volto a riflettere su come gli ebrei abbiano potuto salvarsi malgrado gli arresti, le deportazioni. Al contrario di quanto già descritto da Liliana Picciotto ne Il libro della memoria e in altri studi, si parla qui del “rovescio della medaglia”. «Ho scelto di narrare le storie più paradigmatiche, voci che parlavano per tutti. Non è stato facile fare una scelta. Salvarsi resta comunque un progetto aperto e in futuro ci sarà la possibilità di raccogliere altre storie». Come spiega che tra i sopravvissuti ci siano molti centenari?
Gli ebrei sfuggiti alla Shoah in Italia furono più dell’81 per cento. Nel libro Salvarsi – Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945, di Liliana Picciotto (Einaudi Storia; pp. 570; € 38,00), vengono presentati i risultati del progetto Memoria della salvezza del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), generosamente sostenuto dalla Viterbi Family Foundation, condotto con i ricercatori Chiara Ferrarotti, Luciana Laudi e Gloria Pescarolo; un progetto volto a riflettere su come gli ebrei abbiano potuto salvarsi malgrado gli arresti, le deportazioni. Al contrario di quanto già descritto da Liliana Picciotto ne Il libro della memoria e in altri studi, si parla qui del “rovescio della medaglia”. «Ho scelto di narrare le storie più paradigmatiche, voci che parlavano per tutti. Non è stato facile fare una scelta. Salvarsi resta comunque un progetto aperto e in futuro ci sarà la possibilità di raccogliere altre storie». Come spiega che tra i sopravvissuti ci siano molti centenari?
«Per chi ha vissuto l’inferno della Shoah qualunque altra esperienza diventa probabilmente superabile. Penso si tratti di una forma di resilienza sociale. Niente può fare più male di questo Male. Forse un corpo fisico sottoposto a grandi stress, la fame, il futuro incerto, possono contribuire a rendere un individuo più forte. Chi è sopravvissuto alla Shoah tende a minimizzare problemi che per noi sembrano insormontabili. Ma tutti hanno trasmesso una ricchezza straordinaria di esperienza. Sono rimasta colpita dall’equilibrio mentale e interiore di queste persone, dalla loro lucidità di pensiero e dalla capacità di elaborazione.
Quasi tutti hanno parlato per la prima volta, raramente la loro è diventata una storia di famiglia. Soprattutto fra gli ex deportati che con il silenzio hanno voluto probabilmente preservare i propri figli e nipoti dal Male. Adesso, arrivati a una certa età, si sono aperti e hanno iniziato a raccontare, consapevoli che il tempo corre e che c’è una necessità di trasmissione che non deve rimanere inevasa. E questo apre ad altre parole…».



