di Ugo Volli
Qualche volta il vizio – di cui mi confesso colpevole – di alternare la lettura di parecchi libri assieme ha il vantaggio di suggerire accostamenti significativi. Negli ultimi giorni ho letto in parallelo L’Europa senza ebrei di Giulio Meotti e La grande Vienna ebraica di Riccardo Calimani, entrambi appena usciti, rispettivamente per Lindau e Bollati Boringhieri.
 Il primo, documentatissimo come sempre, è una cronaca fitta e drammatica degli episodi di antisemitismo e di vera e propria violenza antiebraica che hanno funestato il nostro continente negli ultimi decenni, spesso senza reazioni concrete da parte della autorità, soprattutto quando l’origine dell’antisemitismo non si poteva archiviare genericamente nelle categorie dell’“odio” e del “razzismo” attribuiti in automatico alla destra politica, ma – come accade di fatto nella grande maggioranza dei casi – si tratta dell’”antisionismo” (ma in realtà antisemitismo) praticato da immigrati musulmani e loro discendenti, appoggiati magari dalla sinistra politica più o meno estrema.
Il primo, documentatissimo come sempre, è una cronaca fitta e drammatica degli episodi di antisemitismo e di vera e propria violenza antiebraica che hanno funestato il nostro continente negli ultimi decenni, spesso senza reazioni concrete da parte della autorità, soprattutto quando l’origine dell’antisemitismo non si poteva archiviare genericamente nelle categorie dell’“odio” e del “razzismo” attribuiti in automatico alla destra politica, ma – come accade di fatto nella grande maggioranza dei casi – si tratta dell’”antisionismo” (ma in realtà antisemitismo) praticato da immigrati musulmani e loro discendenti, appoggiati magari dalla sinistra politica più o meno estrema.
Il secondo libro racconta gli ultimi decenni della cultura di origine ebraica nella capitale austriaca, dove essa era egemone per qualità e forza produttiva, ben al di là del peso demografico notevole della popolazione ebraica. Basti pensare a nomi come Freud e Hofmannsthal e Mahler e Schnitzler e Herzl e Wittgenstein e tanti altri.
Un impressionante parallelismo fra i due libri emerge non solo dal titolo di quello di Meotti, che cita esplicitamente La città senza ebrei, un romanzo di Hugo Bettauer uscito nel 1922, in cui si prevedevano molto esattamente, ma per difetto, le prime fasi del genocidio nazista. Molte altre cose nell’inchiesta di Meotti richiamano la situazione di cent’anni fa: il riemergere di un antisemitismo che sembrava ormai sepolto nel cimitero degli orrori della storia; la complicità di partiti rispettabili e pieni di ebrei, come i socialdemocratici austriaci; l’”odio di sé” (l’espressione fu coniata in quegli anni da Theodor Lessing) di molti ebrei che per arrivismo, per la speranza del quieto vivere, per conformismo ideologico, per presuntuoso “senso di giustizia”, facevano proprie le opinioni di chi odiava il loro popolo (a questo proposito sono particolarmente impressionanti le pagine che documentano le posizioni antisemite di un “mostro sacro” nato ebreo come Karl Kraus); e infine la simmetrica opposizione al sionismo da parte dei militanti ebrei progressisti, (che vedevano il futuro nell’assimilazione e nel superamento del particolarismo ebraico in nome di alti ideali politici) e di frazioni del mondo religioso più conservatore (che non accettavano l’idea di riportare il popolo ebraico in patria coi soli mezzi della politica).
In effetti il trionfo viennese della cultura ebraica assimilata fu immediatamente precedente alla sua distruzione: dei 350 mila ebrei che abitavano Vienna al tempo della prima guerra mondiale oggi ne restano, o piuttosto ne sono tornati, meno dell’un per cento. Lo stesso declino, secondo Giulio Meotti (e molti fra i testimoni e gli analisti che egli ha intervistato) attende l’ebraismo europeo: dappertutto esaltato nei suoi lutti con le manifestazioni ufficiali della memoria, ma assediato dall’antisemitismo, messo a rischio dall’odio sanguinoso degli islamisti, spesso incapace di mantener vive le sue radici culturali e spirituali autentiche e anche semplicemente di mantenere la sua vita tradizionale per le minacce legislative crescenti alle regoli alimentari e perfino alla circoncisione, ma soprattutto per la perdita dei costumi e della cultura dei padri: ridotto quindi quasi dovunque alla propria museificazione.
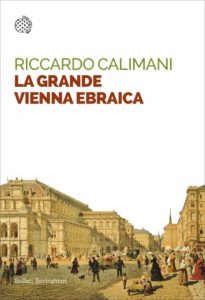
L’incapacità di reagire a questo destino è probabilmente l’aspetto più preoccupante della situazione.
La presenza ebraica in Europa risale a più di venti secoli ed è stata sempre attiva e creativa, autonoma e legata alle proprie tradizioni, anche in mezzo alle più orribili persecuzioni o alle crisi interne più difficili. Ora questa capacità di reazione e di invenzione sembra perduta, o meglio trasferita in Israele, e l’Europa, anche quella progressista, appare decisa o rassegnata a liberarsi degli ebrei vivi, ricordando, ma a modo suo, con la sua morale universalista e antinazionalista, quelli uccisi durante la Shoah e trattando lo Stato di Israele come un anacronismo imbarazzante perché contraddice il suo universalismo. Stretto in questa dinamica, impoverito dall’emigrazione e dall’assimilazione, in parte compiacente con l’ideologia che lo nega esaltandone il ruolo di vittima, l’ebraismo europeo ha perso ormai buona parte delle sue energie e rischia, se non di scomparire del tutto, di avere un ruolo solo residuale e di testimonianza. Questa è la diagnosi di Meotti. È difficile trovare argomenti per contraddirne il pessimismo, se non uno, che peraltro Meotti certamente condivide. A differenza del mondo ebraico dell’Europa centrale, che fu distrutto senza alternative, quel che è accaduto qualche decennio dopo all’ebraismo europeo non è una distruzione, ma un trasferimento o meglio un ritorno a casa.
È l’Europa che rischia di realizzare il progetto nazista e di restare “Judenrein”, senza ebrei, anche perché non riesce a riconoscere Israele come un fratello da cui avrebbe moltissimo da imparare e con cui potrebbe condividere una popolazione attaccata a entrambe le sponde del Mediterraneo. Ma gli ebrei hanno ricostruito fra il Giordano e il mare anche forme politiche, culturali, economiche, scientifiche che riprendono, oltre alla tradizione ebraica, anche il meglio dell’esperienza europea. Non resteranno quindi senza una loro immagine ebraica dell’Europa.



