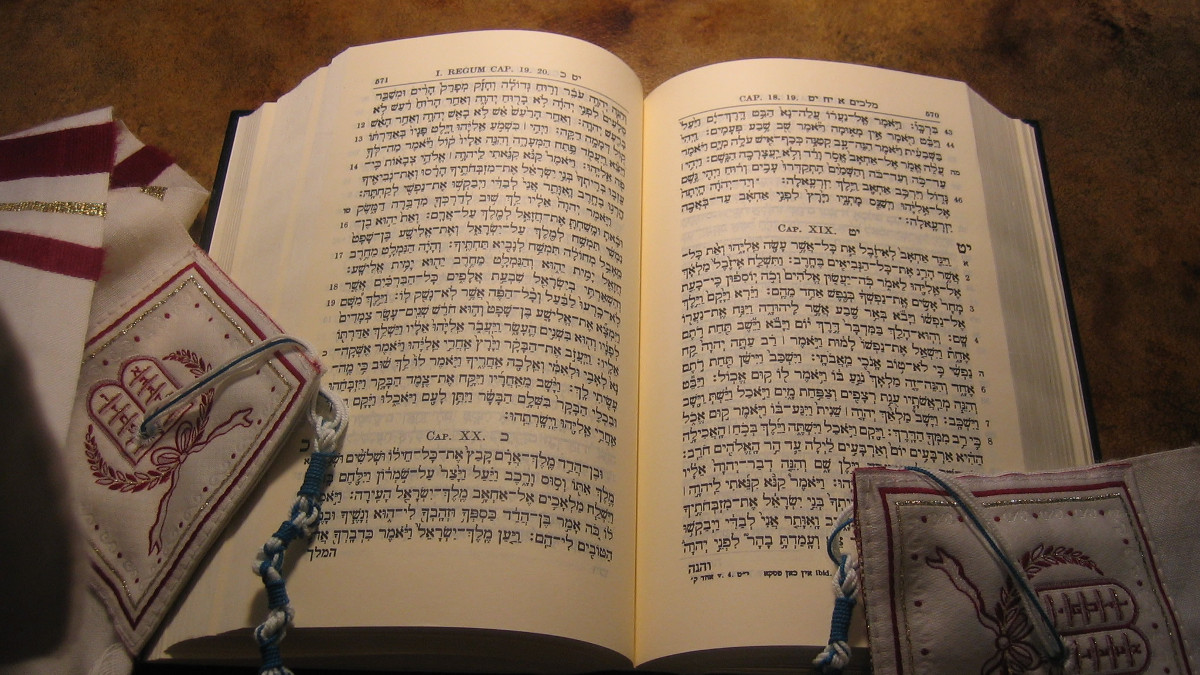Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
Mentre stavo scrivendo questo saggio, un titolo di giornale ha attirato la mia attenzione. Diceva: “Le persone più ricche del Regno Unito hanno sfidato la recessione a doppia caduta diventando ancora più ricche nell’ultimo anno.”
Questo nonostante il fatto che la maggior parte delle persone sia diventata più povera, o almeno abbia visto il proprio reddito reale rimanere fermo, dalla crisi finanziaria del 2008. Come dice il proverbio: “Niente è più certo: i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri.” È a questo fenomeno che si rivolge la legislazione sociale della Parashat Behar.
Il capitolo 25 del Levitico presenta una serie di leggi il cui scopo è correggere la tendenza verso una disuguaglianza radicale e crescente, risultante dal libero gioco dell’economia di mercato. Ecco dunque l’anno sabbatico (Shemittà), in cui i debiti venivano cancellati, gli schiavi ebrei liberati, la terra lasciata a riposo e i suoi frutti, non raccolti, appartenevano a tutti. C’era l’anno del Giubileo (Yovel), in cui, con alcune eccezioni, le terre ancestrali ritornavano ai loro proprietari originari. C’era il comandamento di aiutare i bisognosi (“Se qualcuno dei tuoi fratelli israeliti diventa povero e non riesce a sostenersi presso di te, aiutalo come faresti con un forestiero o un ospite, perché possa continuare a vivere accanto a te”, Levitico 25:35). E vi era l’obbligo di trattare gli schiavi non in modo servile, ma come “lavoratori salariati o ospiti temporanei” (Levitico 25:40).
Come osservò Heinrich Heine (poeta germanico 1797-1856): «Mosè non voleva abolire la proprietà privata; desiderava, al contrario, che ognuno possedesse qualcosa, affinché nessuno, a causa della povertà, diventasse uno schiavo con una mentalità servile. La libertà fu sempre il pensiero supremo di questo grande emancipatore, e ancora respira e arde in tutte le sue leggi che riguardano la miseria.»
Nonostante l’estrema antichità di queste leggi, esse hanno ripetutamente ispirato coloro che si confrontano con i temi della libertà, dell’equità e della giustizia. Il versetto sull’anno del Giubileo (“Proclamate la libertà in tutto il paese a tutti i suoi abitanti.” Levitico 25:10) è inciso sulla Campana della Libertà a Filadelfia. Il movimento internazionale che iniziò alla fine degli anni ’90, coinvolgendo più di 40 nazioni e facendo campagna per la cancellazione del debito del Terzo Mondo, fu chiamato Jubilee 2000 e fu direttamente ispirato dalla nostra Parashà.
L’approccio della Torà alla politica economica è insolito. È evidente che non si possono trarre deduzioni dirette da leggi date più di tremila anni fa, in un’epoca agricola e a una società consapevolmente sotto la sovranità di Dio, per applicarle alle circostanze del ventunesimo secolo, con la sua economia globale e le sue corporazioni internazionali. Tra i testi antichi e l’applicazione contemporanea vi è tutto il processo attento della tradizione e dell’interpretazione della Legge Orale (Torà shebe’al peh).
Tuttavia, sembrano emergere alcuni parametri importanti. Il lavoro – guadagnarsi da vivere, procurarsi il pane quotidiano – ha dignità. Un Salmo (Tehillim 128:2) afferma: “Quando mangerai del frutto del lavoro delle tue mani, sarai felice e avrai del bene.”
Lo recitiamo ogni sabato sera all’inizio della settimana lavorativa. A differenza delle culture aristocratiche come quella della Grecia antica, l’ebraismo non ha mai disprezzato il lavoro o l’economia produttiva. Non favoriva la creazione di una classe oziosa. “Lo studio della Torah senza un’occupazione alla fine fallisce e porta al peccato.” (Avot 2:2)
Inoltre, salvo motivi contrari convincenti, si ha diritto ai frutti del proprio lavoro. L’ebraismo diffida del grande governo come minaccia alla libertà. Questo è il cuore dell’ammonimento del profeta Samuele contro la monarchia: un re, dice, “prenderà il meglio dei vostri campi, delle vostre vigne e dei vostri oliveti e li darà ai suoi servi… prenderà la decima dei vostri greggi, e voi stessi diventerete suoi schiavi.” (I Samuele 8)
L’ebraismo è la religione di un popolo nato nella schiavitù e assetato di redenzione; e il grande attacco della schiavitù alla dignità umana è che mi priva della proprietà della ricchezza che creo. Al centro della Bibbia ebraica vi è il Dio che cerca il culto libero di esseri umani liberi, e una delle difese più forti della libertà è la proprietà privata come base dell’indipendenza economica. La società ideale immaginata dai profeti è quella in cui ciascuno possa sedere “sotto la sua vite e sotto il suo fico” (Michea 4:4).
L’economia libera utilizza il carburante della competizione per alimentare il fuoco dell’invenzione. Molto prima di Adam Smith (filosofo economista scozzese 1723-1790), l’ebraismo aveva accettato l’idea che i maggiori progressi spesso derivino da spinte per nulla spirituali. “Ho visto” – dice l’autore del Qohelet – “che ogni fatica e ogni successo derivano dalla rivalità dell’uomo con il suo prossimo.” Oppure, come dicevano i saggi del Talmud: “Se non fosse per l’inclinazione al male, nessuno costruirebbe una casa, sposerebbe una moglie, avrebbe figli o intraprenderebbe un’attività.”
I rabbini favorivano persino il libero mercato nel loro stesso ambito, l’educazione ebraica. Dicevano che un insegnante affermato non poteva opporsi all’apertura di una scuola concorrente. La ragione era semplice: “La gelosia tra i sapienti aumenta la saggezza.” (Bava Batra 21a)
L’economia di mercato è il miglior sistema che conosciamo per alleviare la povertà attraverso la crescita economica. In una sola generazione – negli ultimi anni – ha sollevato dalla povertà 100 milioni di indiani e 400 milioni di cinesi, e i saggi consideravano la povertà come un assalto alla dignità umana. La povertà non è una condizione benedetta o voluta da Dio. È, dicevano i rabbini, “una specie di morte” e “peggiore di cinquanta piaghe”. Dicevano: “Nulla è più difficile da sopportare della povertà, perché colui che è schiacciato dalla povertà è come uno su cui si abbattono tutte le disgrazie del mondo e su cui si riversano tutte le maledizioni del Deuteronomio. Se tutte le altre disgrazie fossero messe da un lato e la povertà dall’altro, la povertà peserebbe di più.”
Tuttavia, l’economia di mercato è più brava a produrre ricchezza che a distribuirla equamente. La concentrazione della ricchezza in poche mani conferisce potere sproporzionato ad alcuni a scapito degli altri. Oggi nel Regno Unito non è raro che i dirigenti di punta guadagnino almeno 400 volte di più dei propri dipendenti. Questo non ha prodotto crescita economica o stabilità finanziaria, ma l’opposto. Mentre scrivo queste parole, uno dei consiglieri di Margaret Thatcher, Ferdinand Mount, ha appena pubblicato una critica alla deregolamentazione finanziaria da lei introdotta: The New Few. Ugualmente impressionante è il recente libro dell’economista sudcoreano Ha-Joon Chang, 23 cose che non ti dicono sul capitalismo. Non si tratta di una critica all’economia di mercato, che egli ritiene ancora il miglior sistema esistente. Ma, nelle sue parole, “ha bisogno di una regolamentazione e di una guida attente.”
Questo è ciò che rappresenta la legislazione contenuta nella Parashà di Behar. Essa ci dice che un sistema economico deve esistere all’interno di un quadro morale. Non deve necessariamente mirare all’eguaglianza economica, ma deve rispettare la dignità umana. Nessuno dovrebbe essere imprigionato in modo permanente dalle catene del debito. Nessuno dovrebbe essere privato di una quota del bene comune, che in epoca biblica significava una porzione di terra. Nessuno dovrebbe essere schiavo del proprio datore di lavoro. Ognuno ha diritto – un giorno su sette, un anno su sette – a un riposo dalle incessanti pressioni del lavoro. Nulla di tutto ciò implica smantellare l’economia di mercato, ma può comportare una redistribuzione periodica.
Al cuore di queste leggi c’è una visione profondamente umana della società. “Nessun uomo è un’isola.” Siamo responsabili gli uni degli altri e coinvolti nel destino altrui. Coloro che sono benedetti da Dio con più di quanto abbiano bisogno dovrebbero condividere parte di quell’abbondanza con chi ha meno di quanto gli occorra. Questo, nell’ebraismo, non è un atto di carità ma di giustizia – è questo il significato della parola tzedakah. Abbiamo bisogno di un po’ di questo spirito nelle economie avanzate di oggi, se vogliamo evitare miseria umana e disordini sociali.
Nessuno lo disse meglio di Isaia, nel primo capitolo del libro che porta il suo nome:
«Cercate la giustizia, incoraggiate gli oppressi,
difendete la causa dell’orfano,
perorate la causa della vedova…»
(Isaia 1:17)
L’umanità non è stata creata per servire i mercati. I mercati sono stati creati per servire l’immagine di Dio che è l’essere umano.
Redazione Rabbi Jonathan Sacks zzl