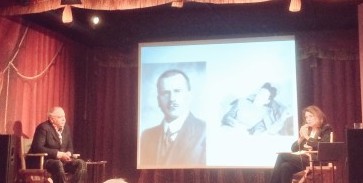di Paolo Castellano
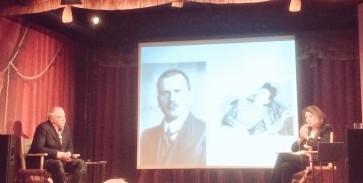
Giovedì 6 dicembre presso la sala Café Rouge del teatro Franco Parenti di Milano si è svolta la presentazione del volume Meret Oppenheim. Afferrare la vita per la coda del critico d’arte Martina Corgnati. La serata è stata animata da un vivace dialogo immaginario tra l’autrice nel ruolo della Oppenheim e lo psichiatra Giovanni Castaldi, nel ruolo di se stesso. L’incontro-spettacolo è stato organizzato dall’associazione AMATA (amici del museo di Tel Aviv) e da Johan&Levi Editore.
La seduta psicanalitica ha analizzato la particolare esistenza di una delle artiste più importanti del Surrealismo, un movimento culturale nato negli anni ‘20 a Parigi che ha influenzato le arti visive, la letteratura, il cinema e che attinse molti dei suoi elementi dalle teorie freudiane.
«Mia zia per me fu un punto di riferimento e di ispirazione ma a 18 anni decisi di lasciare la mia famiglia e la scuola fuggendo prima a Basilea e poi a Parigi per formarmi artisticamente. Nel 1936 creai “La tazza in pelliccia” che fu un simbolo del Surrealismo. La scultura venne acquistata da Alfred H. Barr che la consegnò al MoMA dov’è esposta tutt’oggi. Quest’opera mi rese molto famosa, avevo 22 anni, ma mi mise anche in crisi – ha poi aggiunto – da bambina ero sempre in collegio, ero una ragazzina fragile e soffrivo di solitudine».
In questa surreale analisi psichiatrica si è parlato di tutto: la carriera, gli amori, i dolori e le amicizie di Meret Oppenheim. Inoltre sullo sfondo sono state proiettate delle immagini commentate con l’ausilio dello psichiatra come Erotique Voilée (1933) di Man Ray in cui Meret è ritratta nuda con una mano sporca appoggiata sulla fronte.
Si è parlato anche dei rapporti che la Oppenheim ebbe con grandi artisti del calibro di Man Ray, André Breton, Max Ernst, Alberto Giacometti, Jean Arp e Marcel Duchamp.
Ma quali furono i suoi rapporti con l’ebraismo? «Io non sono ebrea. Ho solo un cognome ebraico perché mio bisnonno decise di convertirsi al protestantesimo e dunque questo dato anagrafico era l’unico legame che ho sempre avuto con l’ebraismo. Non me ne importò molto finché non è arrivato il nazismo e la guerra, che mi hanno fatto sentire sempre più ebrea. Allora crebbe l’interesse per le mie radici. Sono infatti andata in Israele nel 1974 e ho scritto diverse cose sull’ebraismo negli anni ‘80. Per un periodo, un ex-nazista mi scrisse in continuazione raccontandomi che non riusciva a dormire a causa dei crimini compiuti nei confronti degli ebrei. Ricevevo queste lettere perché avevo assunto quest’abito. Durante la guerra del Libano fui una dei pochi artisti in difesa di Israele. L’ebraismo è importante perché rappresenta uno stretto legame tra identità ebraica ed identità umana».
La rappresentazione si è infine conclusa con una riflessione sulla morte da parte della voce dell’artista: «Noi non moriamo mai veramente. Le nostre idee infatti nascono dal fondo della terra, risalgono nella mente e poi queste idee si fanno parola e vagano nel cosmo raggiungendo altre menti».