di Ugo Volli
[Scintille. Letture e riletture] Moshe ben Maimon, conosciuto nelle lingue occidentali con il patronimico Maimonide e nella tradizione ebraica con l’acronimo Rambam, nato a Cordova nel 1135 e morto al Cairo nel 1204, è certamente il più grande filosofo dell’intera storia ebraica ma anche uno dei più autorevoli codificatori della tradizione, il primo ad aver raccolto tutte le regole di vita dell’ebraismo in un’opera sistematica (Mishné Torà, “ripetizione della Torà” è il titolo). Insomma è certamente il singolo autore più importante della cultura ebraica dai tempi del Talmud.
La sua ricezione è amplissima, sul suo contributo e in parte contro alcune sue posizioni hanno scritto tutti i principali maestri dell’ebraismo dopo di lui. Se ci si avventura nell’impresa di studiarlo un po’, anche nelle traduzioni italiane che non mancano, non si può non essere colpiti dalla lucidità del ragionamento, dall’autorevolezza dell’espressione, dalla precisione del pensiero, dalla passione per mettere ordine e chiarezza anche negli argomenti più intricati. Autore prolifico, estremamente preciso nelle sue formulazioni ma dall’impronta culturale complessa, che alla tradizione biblica e talmudica aggiunge strumenti intellettuali tratti dalla filosofia greca, è stato interpretato in modi molto diversi.
La lettura più diffusa, quella che per esempio è stata adottata da Rav Giuseppe Laras, il rabbino italiano recente più attaccato a questo maestro, ne fa un razionalista aristotelico che lavora per mostrare come la dottrina ebraica si conformi alla ragione, facendo ricorso solo molto raramente alla fede come fondamento del pensiero. Ma c’è stato anche chi (per primo Abraham Abulafia) ha cercato di vederlo soprattutto come un cabbalista. E chi (Leo Strauss) l’ha presentato come un aristotelico puro, scettico sulla creazione, che nasconde la sua posizione con gli strumenti della scrittura esoterica.
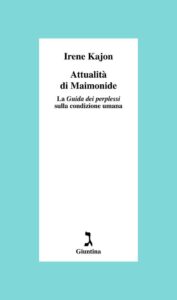 Nel bel libro appena uscito da Giuntina che Irene Kajon, importante storica della filosofia ebraica, ha dedicato soprattutto al suo capolavoro filosofico Moré Nevukhim cioè “La guida dei perplessi” (Attualità di Maimonide, pp. 372, euro 19.00), prevale una linea interpretativa diversa. Al centro del pensiero del Rambam, secondo Kajon, sta la “condizione umana”, cioè il posto dell’uomo nell’universo, che va compreso partendo dall’esempio più alto di umanità, quello dei profeti e in particolare di Mosè. Vi è qui una definizione dell’umano a partire dal rapporto con la Divinità, che noi non possiamo comprendere nell’essenza, ma solo nei comportamenti, dunque nell’etica. Il progetto teorico di Maimonide è dunque per Kajon un “razionalismo etico” che sottrae l’uomo al semplice meccanismo naturale degli interessi e delle pulsioni, per proiettarlo sul piano politico-morale, in una maniera che viene accostata a Kant ma soprattutto alla radice platonica. Kajon indica una serie di letture moderne di Maimonide che interpreta in questa direzione, da Samson Raphael Hirsch a Hermann Cohen a Emmanuel Lévinas ad alcuni rabbini italiani fra Otto e Novecento. Questa sezione sulla ricezione della Guida è molto interessante. Ma tutto il libro è insieme dotto e appassionante, anche se sull’interpretazione platonizzante di Rambam si potrebbe molto discutere.
Nel bel libro appena uscito da Giuntina che Irene Kajon, importante storica della filosofia ebraica, ha dedicato soprattutto al suo capolavoro filosofico Moré Nevukhim cioè “La guida dei perplessi” (Attualità di Maimonide, pp. 372, euro 19.00), prevale una linea interpretativa diversa. Al centro del pensiero del Rambam, secondo Kajon, sta la “condizione umana”, cioè il posto dell’uomo nell’universo, che va compreso partendo dall’esempio più alto di umanità, quello dei profeti e in particolare di Mosè. Vi è qui una definizione dell’umano a partire dal rapporto con la Divinità, che noi non possiamo comprendere nell’essenza, ma solo nei comportamenti, dunque nell’etica. Il progetto teorico di Maimonide è dunque per Kajon un “razionalismo etico” che sottrae l’uomo al semplice meccanismo naturale degli interessi e delle pulsioni, per proiettarlo sul piano politico-morale, in una maniera che viene accostata a Kant ma soprattutto alla radice platonica. Kajon indica una serie di letture moderne di Maimonide che interpreta in questa direzione, da Samson Raphael Hirsch a Hermann Cohen a Emmanuel Lévinas ad alcuni rabbini italiani fra Otto e Novecento. Questa sezione sulla ricezione della Guida è molto interessante. Ma tutto il libro è insieme dotto e appassionante, anche se sull’interpretazione platonizzante di Rambam si potrebbe molto discutere.



