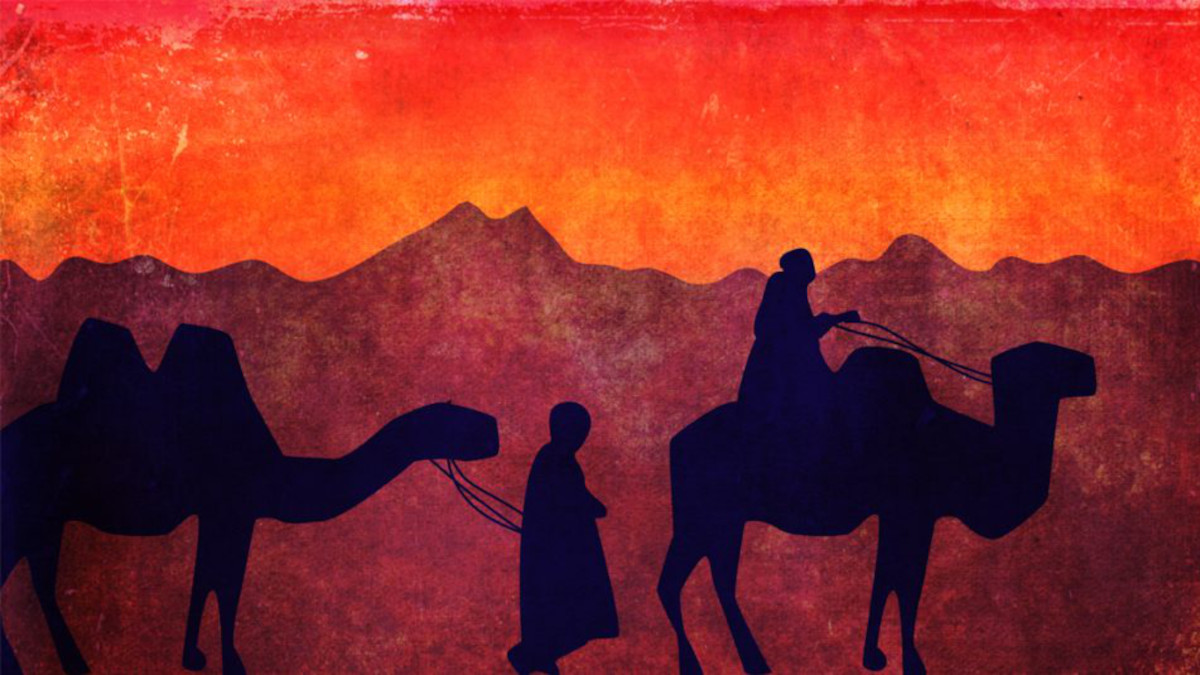Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
La storia di Abramo può essere letta in due modi. Una lettura sottolinea la discontinuità: Abramo ruppe con tutto ciò che venne prima. L’altra mette in evidenza la continuità: suo padre aveva già intrapreso il lungo cammino verso la terra che sarebbe poi diventata santa, ma si era fermato a metà. Abramo completò il viaggio che suo padre aveva iniziato.
La chiamata ad Abramo, con cui inizia Lech Lecha, sembra arrivare dal nulla: “Lascia la tua terra, la tua patria e la casa di tuo padre, e va’ verso la terra che ti mostrerò.”
Nulla ci ha preparato a questa partenza radicale. Non abbiamo una descrizione di Abramo come nel caso di Noè (“Noè era un uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei; Noè camminava con Dio”). Né ci vengono offerti scorci sulla sua infanzia, come accade per Mosè. È come se la chiamata di Abramo fosse una rottura improvvisa con tutto ciò che l’ha preceduta. Non sembra esserci un preludio, né un contesto o uno sfondo.
A questo si aggiunge un versetto curioso nel discorso finale pronunciato da Giosuè, il successore di Mosè: “Così dice il Signore, Dio d’Israele: ‘Anticamente i vostri padri abitavano oltre il fiume (Eufrate): Terach, padre di Abramo e di Nachor; ed essi servivano altri dèi.’” (Giosuè 24:2)
L’implicazione sembra essere che il padre di Abramo fosse un idolatra. Da qui nasce la famosa tradizione midrashica secondo cui, da bambino, Abramo avrebbe rotto gli idoli di suo padre. Quando Terach gli chiese chi avesse causato quel danno, egli rispose: “Il più grande degli idoli ha preso un bastone e ha fatto a pezzi gli altri.” “Perché mi inganni?” chiese Terach, “Gli idoli hanno forse intelligenza?” “Che le tue orecchie sentano ciò che la tua bocca dice”, rispose il bambino. (Bereshit Rabbah 38:8)
Secondo questa lettura, Abramo fu un iconoclasta, un distruttore di immagini, uno che si ribellò alla fede di suo padre. Maimonide, il filosofo, presentò la cosa in modo un pò diverso.
In origine, gli esseri umani credevano in un unico Dio. In seguito cominciarono a offrire sacrifici al sole, ai pianeti, alle stelle e ad altre forze della natura, considerandoli creazioni o servitori dell’unico Dio. Più tardi ancora, arrivarono ad adorarli come divinità a sé stanti.
Fu Abramo, usando soltanto la logica, a comprendere l’incoerenza del politeismo:
dopo essere stato svezzato, mentre era ancora un bambino, la sua mente cominciò a riflettere. Giorno e notte si chiedeva come fosse possibile che la sfera celeste guidasse costantemente il mondo senza che qualcuno la orientasse e la facesse muovere. Poiché non può muoversi da sé.
Abramo non aveva maestro né mentore, poiché viveva a Ur dei Caldei, tra stolti idolatri. Suo padre, sua madre e l’intera popolazione adoravano idoli, e lui adorava con loro. Continuò a meditare e a riflettere finché non giunse alla via della verità, comprendendo ciò che era giusto attraverso i propri sforzi. Allora comprese che esiste un solo Dio che guida i corpi celesti, che ha creato ogni cosa e fuori di Lui non c’è altro dio. (Mishneh Torah, Leggi sull’Idolatria 1:2)
Ciò che accomuna Maimonide e il Midrash è la discontinuità: Abramo rappresenta una rottura radicale con tutto ciò che lo ha preceduto. Tuttavia, sorprendentemente, il capitolo precedente ci offre una prospettiva del tutto diversa: “Queste sono le generazioni di Terach. Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò Lot… Terach prese Abram suo figlio, Lot figlio di Aran, suo nipote, e Sarai sua nuora, moglie di Abram, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Ma, giunti a Charan, si stabilirono là. I giorni di Terach furono duecentocinque anni; e Terach morì a Charan.” (Genesi 11:27–32)
L’implicazione qui sembra essere che, lungi dal rompere con suo padre, Abramo stesse continuando un viaggio che Terach aveva già iniziato. Come conciliare questi due passaggi?
Il modo più semplice, seguito dalla maggior parte dei commentatori, è dire che non sono in sequenza cronologica. La chiamata ad Abramo (in Genesi 12) avvenne per prima. Abramo udì la voce divina e la comunicò a suo padre. La famiglia partì insieme, ma Terach si fermò a Charan. Il passo che registra la morte di Terach è collocato prima della chiamata di Abramo, anche se avvenne più tardi, per evitare che Abramo potesse essere accusato di aver disonorato suo padre lasciandolo in vecchiaia (Rashi, Midrash).
Eppure c’è un’altra possibilità evidente: l’intuizione spirituale di Abramo non nacque dal nulla. Terach aveva già compiuto il primo, timido passo verso il monoteismo. I figli completano ciò che i genitori iniziano.
È significativo che sia la Bibbia sia la tradizione rabbinica comprendano la paternità divina in questo modo. Esse contrappongono la descrizione di Noè (“Noè camminava con Dio”) a quella di Abramo (“Il Dio davanti al quale ho camminato”, Genesi 24:40). Dio stesso dice ad Abramo: “Cammina davanti a Me e sii integro” (Genesi 17:1). Dio indica la via, poi sfida i Suoi figli a camminare più avanti.
In uno dei passi più celebri del Talmud babilonese (Bava Metzia 59b), si racconta come i Saggi abbiano votato contro Rabbi Eliezer, benché la sua opinione fosse sostenuta da una voce celeste. Segue poi l’incontro tra Rabbi Natan e il profeta Elia.
Rabbi Natan chiede: quale fu la reazione di Dio in quel momento, quando la legge fu decisa dalla maggioranza invece che seguendo la voce celeste? Elia rispose: “Dio sorrise e disse: I miei figli mi hanno sconfitto! I miei figli mi hanno sconfitto!”
Essere genitori, nell’ebraismo, significa creare uno spazio entro cui il figlio possa crescere. E in modo sorprendente, questo vale persino quando il genitore è Dio stesso (Avinu, “nostro Padre”).
Come scrisse Rabbi Joseph Soloveitchik: “Il Creatore del mondo ha ridotto la propria immagine e la grandezza della creazione per lasciare qualcosa che l’uomo, opera delle Sue mani, potesse compiere, così da incoronarlo con il titolo di creatore e artefice.” (Halachic Man, p. 107)
Questa idea trova espressione anche nella halachah, la legge ebraica. Nonostante la Torà insista sull’onore e il rispetto dovuti ai genitori, Maimonide stabilisce: “Benché i figli siano obbligati a grandi sforzi per onorare i genitori, un padre non deve imporre loro un giogo troppo pesante, né essere eccessivamente esigente riguardo al proprio onore, affinché non li induca a peccare. Deve perdonarli e chiudere un occhio, poiché un padre ha il diritto di rinunciare all’onore che gli è dovuto.” (Hilchot Mamrim 6:8)
La storia di Abramo può dunque essere letta in due modi, a seconda di come si concilia la fine del capitolo 11 con l’inizio del capitolo 12.
Una lettura sottolinea la discontinuità: Abramo ruppe con tutto ciò che venne prima.
L’altra mette in evidenza la continuità: Terach, suo padre, aveva già iniziato a lottare contro l’idolatria. Aveva intrapreso il lungo cammino verso la terra che sarebbe poi diventata santa, ma si era fermato a metà. Abramo completò il viaggio che suo padre aveva iniziato.
Forse anche l’infanzia ha la stessa ambiguità. Ci sono momenti, soprattutto nell’adolescenza, in cui ci diciamo che stiamo rompendo con i nostri genitori, tracciando un percorso completamente nuovo. Solo in seguito, molti anni dopo, ci rendiamo conto di quanto dobbiamo loro — di come, persino nei momenti in cui ci sembrava di iniziare un cammino tutto nostro, stavamo in realtà vivendo gli ideali e le aspirazioni che avevamo imparato da loro.
E tutto cominciò con Dio stesso, che ha lasciato — e continua a lasciare — spazio a noi, i Suoi figli, perché possiamo camminare davanti a Lui.
Scritto da Rabbi Sacks nel 2012