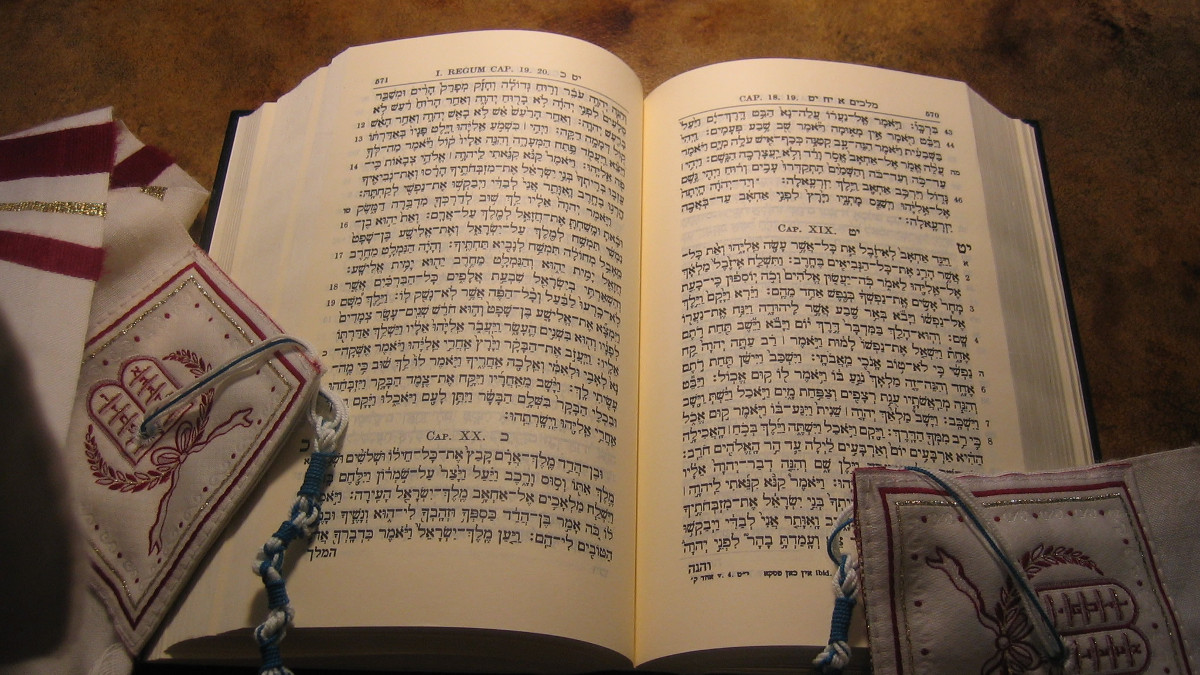Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
In memoria di Ghidon Sergio Fiano zl
Dio non è un tiranno, ma un insegnante. Egli cerca non solo la nostra obbedienza, ma anche la nostra comprensione. Tutte le nazioni hanno leggi, e le leggi vanno rispettate. Ma poche nazioni, se non Israele, fanno della comprensione del perché la legge sia come è, il compito più alto. Questo è ciò che la Torà intende con la parola shema.
Sarebbe ragionevole supporre che una lingua che contiene il verbo “comandare” debba contenere anche il verbo “obbedire”. Uno implica l’altro, proprio come il concetto di domanda implica la possibilità di una risposta. Tuttavia, ci sbaglieremmo. Ci sono 613 comandamenti nella Torà, ma non esiste alcuna parola nell’ebraico biblico che significhi “obbedire”. Quando l’ebraico fu rivitalizzato come lingua di uso quotidiano nel XIX secolo, dovette essere presa in prestito dall’aramaico la parola letsayet. Fino ad allora non esisteva alcuna parola ebraica per “obbedire”.
Questo è un fatto straordinario e non tutti ne erano consapevoli. Ha portato alcuni cristiani (e laici) a fraintendere la natura del giudaismo: pochissimi pensatori cristiani hanno realmente compreso il concetto di Mitzvà e l’idea che Dio potesse scegliere di rivelarsi sotto forma di leggi. Ha anche portato alcuni ebrei a concepire le mitzvot in un modo più appropriato all’Islam (la parola Islam significa “sottomettersi” alla legge di Dio) che al giudaismo. Quale parola usa allora la Torà come risposta appropriata a una mitzvah? Shema.
La radice sh-m-a è una parola chiave nel libro del Deuteronomio, dove ricorre 92 volte, solitamente nel senso di ciò che Dio vuole da noi in risposta ai comandamenti. Ma il verbo sh-m-a ha molti significati. Ecco alcuni dei significati che assume in Genesi:
1. “Sentire”, come in: “Abramo udì che il suo parente [Lot] era stato catturato” (Genesi 14:14).
2. “Ascoltare, prestare attenzione, considerare”, come in: “Perché hai ascoltato tua moglie e hai mangiato il frutto dell’albero” e “Allora Rachele disse: Dio mi ha giustificata; ha ascoltato la mia richiesta e mi ha dato un figlio” (Genesi 3:17; 30:7).
3. “Comprendere”, come in: “Venite, scendiamo e confondiamo la loro lingua affinché non si comprendano l’un l’altro” (Genesi 11:7). È così che la tradizione ha inteso la frase più tardi Naaseh ve-nishma (Esodo 24:7), “prima faremo, poi capiremo”.
4. “Essere disposti a obbedire”, come le parole dell’angelo ad Abramo dopo il sacrificio di Isacco: “Per mezzo della tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette, perché eri disposto a obbedirmi” (Genesi 22:18), quando Abramo stava per obbedire al comando di Dio, e all’ultimo momento un angelo gli ordinò di fermarsi.
5. “Rispondere con l’azione, fare ciò che qualcun altro vuole”, come in: “Fa’ tutto ciò che ti dice Sara” – sh’ma bekolah (Genesi 21:12).
È in quest’ultimo senso che il verbo sh-m-a si avvicina di più al significato di “obbedire”. Il fatto stesso che esso contenga tutti questi significati suggerisce che nella Torà non esiste il concetto di obbedienza cieca.
In generale, un comandante ordina e un soldato obbedisce. Un padrone comanda e lo schiavo obbedisce. Non è coinvolto alcun processo di pensiero attivo. La connessione tra la parola del comandante e l’azione dell’obbediente è una relazione di stimolo e risposta. Ai fini pratici, il soldato o lo schiavo non ha una mente propria. Come descrive Tennyson (poeta inglese 1809-1892) riguardo ai soldati prima della carica della Brigata Leggera: “Non è nostro ragionare sul perché; nostro è solo fare o morire.”
Non è così che la Torà concepisce il rapporto tra Dio e noi. Dio, che ci ha creati a Sua immagine, concedendoci libertà e capacità di pensare, vuole che comprendiamo i Suoi comandi. Il Ralbag (Gersonide, filosofo francese 1288-1344) sostiene che proprio questo distingue la Torà: Ecco, la nostra Torà è unica tra tutte le altre dottrine e religioni che altri popoli hanno avuto, poiché contiene solo ciò che origina dall’equità e dalla ragione. Pertanto questa Legge Divina attrae le persone grazie alla sua essenza, affinché si comportino conformemente a essa. Le leggi e le religioni di altri popoli non sono così: non si conformano all’equità e alla saggezza, ma sono estranee alla natura dell’uomo, e le persone le osservano per costrizione, per timore della punizione, non per la loro essenza.
Sulla stessa linea, lo studioso moderno David Weiss Halivni (rabbino, teologo statunitense 1927-2022) parla della “predilezione ebraica per la legge giustificata” e la confronta con altre culture del mondo antico: – La legge antica in generale è apodittica, senza giustificazione e senza persuasione. Il suo stile è categorico, esigente e autoritario… La legge del Vicino Oriente antico in particolare è priva di qualsiasi desiderio di convincere o conquistare i cuori. Impone, prescrive e ordina, aspettandosi di essere rispettata solo in virtù di essere un decreto ufficiale. Non richiede consenso (attraverso giustificazione) da chi è soggetto a essa-.
La Torà utilizza almeno tre strumenti per mostrare che la legge ebraica non è arbitraria, non è un mero decreto.
Primo, evidente soprattutto in Devarim, è il dare ragioni per i comandi. Spesso, anche se non sempre, la ragione ha a che fare con l’esperienza degli Israeliti in Egitto. Essi conoscono cosa significa essere oppressi, essere stranieri, essere esclusi. “Voglio che creiate una società diversa,” dice Dio attraverso Mosè, “dove la schiavitù sia limitata, dove ogni persona abbia un giorno di libertà alla settimana, dove i poveri non patiscano la fame e i deboli non vengano privati della giustizia.”
Secondo, particolarmente evidente nel libro di Bamidbar, è l’accostamento di narrazione e legge, come per dire che la legge si comprende meglio sullo sfondo della storia e dell’esperienza formativa degli Israeliti. La legge della vacca rossa – per la purificazione dal contatto con i morti – compare subito prima della morte di Miriam e Aharon, come per dire che lutto e dolore interferiscono nel nostro rapporto con Dio, ma ciò non dura per sempre.
La legge degli zizith compare dopo la storia degli esploratori perché entrambe riguardano modi di vedere: la differenza tra vedere con paura e vedere con fede.
Terzo, il collegamento tra legge e metafisica. Esiste un forte legame tra Genesi 1, la storia della creazione, e le leggi di kedushà (santità). Entrambe appartengono alla torat kohanim, la voce sacerdotale, e riguardano ordine e mantenimento dei confini. Le leggi contro il mescolamento di carne e latte, lana e lino, ecc., riguardano il rispetto della struttura profonda della natura, come descritta nel primo capitolo della Torà.
In tutto Devarim, mentre Mosè raggiunge l’apice della sua leadership, diventa un educatore, spiegando alla nuova generazione – che conquisterà e abiterà la terra – che le leggi date da Dio non sono solo decreti divini. Hanno senso in termini umani. Costituiscono l’architettura di una società libera e giusta. Rispettano la dignità umana. Onorano l’integrità della natura. Consentono alla terra di riposare e rigenerarsi. Proteggono Israele dalle leggi altrimenti inevitabili del declino e della caduta delle nazioni.
Solo riconoscendo Dio come sovrano si può evitare il dominio oppressivo dei re e la corruzione del potere. Mosè ripete più volte al popolo che se seguiranno le leggi di Dio prospereranno; se falliranno, subiranno sconfitta ed esilio. Tutto questo può essere compreso in termini soprannaturali, ma anche in termini naturali.
Per questo Mosè, in tutto Devarim, usa il verbo sh-m-a. Vuole che gli Israeliti obbediscano a Dio, ma non ciecamente o solo per paura. Dio non è un autocrate. Gli Israeliti devono comprenderlo tramite la loro esperienza diretta. Avevano visto come Dio, creatore del cielo e della terra, avesse scelto questo popolo come Suo, lo avesse liberato dalla schiavitù, nutrito, sostenuto e protetto nel deserto, e lo avesse condotto alla vittoria sui nemici. Dio non aveva dato la Torà a Israele per Se stesso, ma per loro. Come afferma Weiss Halivni, la Torà “invita il ricevente della legge a comprendere l’effetto benefico della legge, conferendogli dignità e facendolo sentire partner della legge.”
Questo è il significato delle grandi parole di Mosè nella parashà di questa settimana: “Taci, Israele, e ascolta! Ora siete il popolo del Signore vostro Dio. Ascoltate il Signore vostro Dio e seguite i Suoi comandamenti e decreti che oggi vi do.” (Deuteronomio 27:9-10)
Osservare i comandamenti implica un atto di ascolto, non solo sottomissione o obbedienza cieca – ascolto in tutti i suoi sensi: prestare attenzione, meditare, riflettere sulla natura di Dio attraverso la creazione, la rivelazione e la redenzione. Significa cercare di comprendere i nostri limiti e le nostre imperfezioni come esseri umani. Significa ricordare cosa significhi essere stati schiavi in Egitto. Comporta umiltà, memoria e gratitudine. Ma non implica abdizione dell’intelletto o silenzio della mente critica.
Dio non è un tiranno, ma un insegnante. Egli cerca non solo la nostra obbedienza, ma anche la nostra comprensione. Tutte le nazioni hanno leggi, e le leggi vanno rispettate. Ma poche nazioni, se non Israele, fanno della comprensione del perché la legge sia come è, il compito più alto. Questo è ciò che la Torà intende con la parola shema.
Scritto da Rabbi Sacks nel 2012