di Nathan Greppi
Quando si procurò la dose di cianuro, Tullio Terni pensò che l’avrebbe usata per sfuggire ai nazisti. Invece, paradossalmente, dopo la Seconda Guerra Mondiale il medico ebreo, che a causa delle Leggi Razziali fu costretto a lasciare l’insegnamento universitario e l’Accademia dei Lincei, venne accusato ingiustamente di essere stato un fascista. La disperazione in cui sprofondò lo spinse a togliersi la vita con quella stessa dose di cianuro.
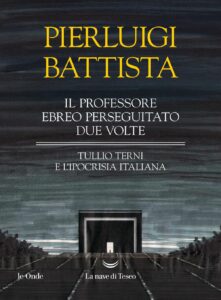 La storia di Terni è stata recentemente riportata alla luce dal giornalista Pierluigi Battista, che a questa tragica vicenda ha dedicato il suo ultimo libro, dal titolo Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana (La Nave di Teseo).
La storia di Terni è stata recentemente riportata alla luce dal giornalista Pierluigi Battista, che a questa tragica vicenda ha dedicato il suo ultimo libro, dal titolo Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana (La Nave di Teseo).
A ridosso della pubblicazione del volume, Battista ha gentilmente concesso un’intervista a Mosaico/Bet Magazine.
Come è nato il suo interesse per la figura di Tullio Terni?
È nata per lo stupore che mi accompagna da anni nei confronti di una vicenda che è totalmente sconosciuta, malgrado la sua gravità. Un professore ebreo che, appunto, venne cacciato dall’università e dalle accademie per via delle Leggi Razziali, e che poi venne addirittura epurato da una commissione epuratrice antifascista, e per questo si uccise con una fiala di cianuro che si era procurato per non finire nelle grinfie delle SS.
Su quali fonti si è documentato per scrivere il libro?
Esistono una tesi di laurea di Federica Dutto e un saggio di Paolo Simoncelli apparso sulla rivista Nuova storia contemporanea. Nel corso degli anni, ho trovato tanti riferimenti minimi in diversi libri, per cui mi ero incuriosito. In Italia, per molto tempo ne ha parlato solo Rita Levi Montalcini nell’87, nel suo libro Elogio dell’imperfezione. E poi, io sono riuscito a trovare la nipote di Tullio Terni, che si chiama Lisa Baligioni, che mi ha fornito ulteriore documentazione. Tutte le volte che ho chiesto a persone anche sensibili alla storia italiana se sapevano di Tullio Terni, mi hanno detto di no. Per questo, ho avuto l’impulso di scriverlo e di farlo non sotto forma di saggio critico, ma di racconto.
Come è potuto succedere che un ebreo caduto in disgrazia a causa del fascismo, sia stato successivamente accusato di essere fascista?
È successo questo: nel ’38, quando sono arrivate le Leggi Razziali, le autorità fasciste si presero gioco degli ebrei italiani dicendo che c’erano alcune strade per poter quantomeno minimizzare gli effetti della discriminazione, ad esempio presentando degli attestati patriottici o dimostrando di non avere più del 25% di sangue ebraico. Per questo ci furono molti ebrei, tra cui Tullio Terni, che cercarono attestati e documenti nella speranza che li salvassero dai provvedimenti peggiori. Dopo la caduta del fascismo, questa cosa venne giudicata dalla commissione epuratrice come un atto vile, anche se in questa commissione c’erano giudici che in precedenza avevano giurato fedeltà al fascismo.
Nel suo precedente libro “La nuova caccia all’ebreo” (Liberilibri), lei ha messo in luce come gli ebrei vengano nuovamente presi di mira dopo il 7 ottobre. Che analogie vede tra l’Italia di oggi e quella in cui ha vissuto Terni?
Non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, ci sono alcune scene che richiamano il ’38. I divieti nei negozi, con le scritte “qui non entrano i sionisti” che poi vuol dire gli ebrei israeliani, il boicottaggio, il fatto che i giornalisti ebrei non possano parlare all’università perché vengono zittiti, che gli studenti ebrei non possano portare la kippah all’università, sono tutte analogie fortissime. Tutto questo nell’assoluta indifferenza della cultura democratica, che prende spunto da quello che sta accadendo a Gaza quasi giustificando l’antisemitismo come se fosse una critica nei confronti del governo Netanyahu.
Rileggendo la storia di Terni, quale lezione si può imparare?
Questa storia è stata completamente cancellata. Io l’ho trovata esemplare del fatto che l’Italia non ha mai fatto i conti con le Leggi Razziali, attribuendole solo ad una minoranza di gerarchi del regime fascista e nascondendo le infinite complicità. Penso a tanti intellettuali che poi diventeranno campioni dell’antifascismo solo quando questo vincerà, e che hanno fatto di Tullio Terni un capro espiatorio. Erano tanti anni che volevo scriverne, ma ho capito che era questo il momento dopo il 7 ottobre, quando l’Italia si è dimostrata totalmente insensibile ai temi della nuova discriminazione antiebraica in Occidente.



