di Fiona Diwan
Come votano oggi i Millennial, la Generazione X, Y, Z? E gli immigrati? Che cosa incide sugli spostamenti dei blocchi elettorali? Lo spiegano Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino
Chi ricorda più l’adagio di antica memoria “dimmi come voti e ti dirò chi sei”? Nessuno. Fluido, mobile, sgusciante e infedele, il modo in cui gli italiani vanno oggi alle urne non è decisamente più quello di una volta. Estintosi con l’avvicendarsi delle Prime, Seconde, Terze Repubbliche…, con l’astensionismo, con la volatilità elettorale, con la radicalizzazione politica, con lo scollamento tra partiti e corpo elettorale. Che cosa ne è stato allora del sentimento politico degli italiani in questi ultimi quarant’anni? Ai tempi della Prima Repubblica ciascun elettore restava fedele per decenni allo stesso partito, non si trattava di una scelta ma di esprimere una propria personale identità ideologica, ci si sentiva più o meno intensamente democristiani, repubblicani, liberali, comunisti. Il voto restava immutato da una consultazione all’altra, ci si identificava in un partito quasi quanto in una fede religiosa. Accanto al declino delle ideologie e dei partiti tradizionali, con la fine della Prima Repubblica e lo scandalo di Mani pulite, l’intensità di queste appartenenze si è andata erodendo. A poco a poco il paradigma si è invertito: se prima erano gli elettori a seguire i partiti, col tempo sono stati i nuovi partiti a inseguire i potenziali elettori e i loro voti. Un potere politico che è andato verticalizzandosi, basato sul personaggio/leader e sulla sua capacità di trascinare l’opinione pubblica e non più fondato sull’oligarchia del gruppo dirigente di partito. Una fine del voto di identità che ha irrimediabilmente accentuato la tentazione dell’astensione, cosa considerata inammissibile sino agli anni Sessanta (e ancora adesso per la generazione dei boomer).
Come votano allora oggi i Millennial, la Generazione X, Y, Z? Che cosa incide sugli spostamenti dei blocchi elettorali? Ben lo spiegano Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino, sociologi e studiosi del comportamento politico, srotolando la recente storia d’Italia sulla scorta delle oscillazioni del corpo votante, analizzando magistralmente le scelte elettorali del nostro Paese con un approccio scientifico che è anche un fermo immagine prezioso su chi siamo e su che cosa stiamo diventando.
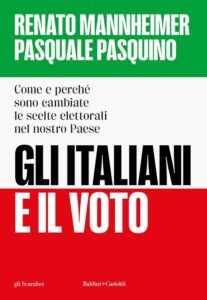
Il recente fenomeno della mobilità e volatilità elettorale sono stati spesso all’origine di risultati elettorali inaspettati. Alla luce dei grandi stravolgimenti degli ultimi decenni – caduta del colonialismo, crollo dell’URSS, esplosione della potenza cinese, grandi migrazioni verso l’Europa -, i nuovi attori della politica di casa nostra hanno via via preso posizioni diverse e oscillanti. Su quale base allora si sceglie un partito o un altro? Come viene percepita oggi la dimensione sinistra-destra? Obsoleta o ancora valida? Voto di protesta, voto di identità o voto per consuetudine? Quale fisionomia ha assunto il mercato elettorale odierno? Esistono ancora i partiti trasversali? Esiste ancora un centro (il cosiddetto Terzo Polo)? Ha ancora senso chiedersi come votano oggi le donne, gli uomini, i giovani, gli operai, il ceto medio o piuttosto non è meglio parlare di elettori appartenenti a identità più sfumate e fluide, meno definite? E gli immigrati? A questo e a molto altro risponde questo agile libretto pieno di sorprese, di analisi basate su ampi sondaggi e di una arguta interpretazione dei risultati che ne emergono.
Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino, Gli italiani e il voto – Come e perché sono cambiate le scelte elettorali nel nostro Paese,
Baldini+Castoldi, pp. 121, 16,00 euro



