di Ugo Volli
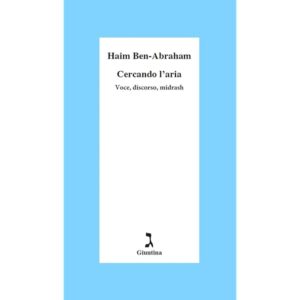 [Scintille. Letture e riletture] Midrash, sostantivo derivante dal verbo darash che significa ricercare e sollecitare, è la parola che nella tradizione ebraica copre l’area di senso che in italiano va da “commento” a “interpretazione”, da “ricerca” a “indagine esegetica”. Dei quattro livelli ermeneutici riconosciuti dalla tradizione medievale (il cosiddetto pardes), derash è anche specificamente il terzo livello, quello che “sollecita” il testo (un interprete creativo come Marc Alain Ouaknine ha detto addirittura che “lo accarezza”) per trovare nuovi sensi con accostamenti, somiglianze, identificazioni con altri passi. Dato che la produzione teorica ebraica a partire dal Talmud ha assunto soprattutto la forma del commento, in qualche misura essa è tutta midrashica. In particolare si parla di midrash alakhà cioè commento giuridico, quando i rabbini discutono, precisano e adattano alle varie situazioni le norme di comportamento che derivano dalla Torà. E si chiamano midrash hagadà, commentari narrativi, tutti quei casi in cui il testo elabora storie dei personaggi biblici e talmudici, ma anche teorie fisiche, meteorologiche, mediche ecc., la geografia, la storia, l’etimologia, l’interpretazione dei sogni, l’etnologia, l’agricoltura, insomma tutta la vasta e complessa enciclopedia delle conoscenze dei rabbini antichi.
[Scintille. Letture e riletture] Midrash, sostantivo derivante dal verbo darash che significa ricercare e sollecitare, è la parola che nella tradizione ebraica copre l’area di senso che in italiano va da “commento” a “interpretazione”, da “ricerca” a “indagine esegetica”. Dei quattro livelli ermeneutici riconosciuti dalla tradizione medievale (il cosiddetto pardes), derash è anche specificamente il terzo livello, quello che “sollecita” il testo (un interprete creativo come Marc Alain Ouaknine ha detto addirittura che “lo accarezza”) per trovare nuovi sensi con accostamenti, somiglianze, identificazioni con altri passi. Dato che la produzione teorica ebraica a partire dal Talmud ha assunto soprattutto la forma del commento, in qualche misura essa è tutta midrashica. In particolare si parla di midrash alakhà cioè commento giuridico, quando i rabbini discutono, precisano e adattano alle varie situazioni le norme di comportamento che derivano dalla Torà. E si chiamano midrash hagadà, commentari narrativi, tutti quei casi in cui il testo elabora storie dei personaggi biblici e talmudici, ma anche teorie fisiche, meteorologiche, mediche ecc., la geografia, la storia, l’etimologia, l’interpretazione dei sogni, l’etnologia, l’agricoltura, insomma tutta la vasta e complessa enciclopedia delle conoscenze dei rabbini antichi.
Questi midrash furono raccolti spesso in compilazioni autonome, soprattutto quando raccontano vicende bibliche, ma sono anche largamente contenuti nel Talmud e nella letteratura parallela o successiva. Essi mirano a riempire i vuoti della narrazione della Torà, che è spesso molto laconica, ma anche a dare una giustificazione morale alle storie spesso difficili che vi compaiono e trarne comunque insegnamenti e regole di comportamento, insomma funzionano come parabole. A partire da autori come Buber, Levinas, Leon Askenazi e altri ancora, fra cui in Italia Limentani e Baharier, si è iniziato a tematizzare in questi commenti uno specifico “pensiero ebraico”, distinto dalla filosofia ebraica di Maimonide e dei suoi successori. Al di là dei contenuti particolari di ogni singolo midrash, il “pensiero ebraico” viene presentato come una visione del mondo diversa e alternativa a quella del “pensiero greco” che ha plasmato la filosofia europea.
Questo è anche il punto di vista di Haim Ben-Abraham, un giovane studioso italiano, di cui la casa editrice Giuntina ha pubblicato nel 2023 La via delle api (recensito a suo tempo in questa rubrica) e ora Cercando l’aria: due libri molto affascinanti e profondi, collegati fra loro. Il primo portava come sottotitolo “Lettura, scrittura, midrash”, quest’ultimo “Voce, discorso, midrash”. A partire dall’oralità, la trattazione si sviluppa anche qui su alcuni testi midrashici apparentemente assai diversi fra loro (sulle lettere ebraiche, sulla creazione di Eva, sul dialogo fra Caino e Abele, sulle prime Tavole della Legge, sulla distruzione degli egiziani nel Mar Rosso). Essi sono interpretati con diversi livelli concentrici di commento, in modo da considerare i punti di vista dei diversi maestri che vi compaiono, e da metterne in rilievo le intuizioni fondamentali, il modo di vedere il mondo, l’umanità, il tempo, i rapporti col divino caratteristici del pensiero ebraico. Un libro complesso, colto, pieno di idee, che merita di essere letto e riletto, soprattutto discusso e analizzato punto a punto, assai più di quanto si possa fare in questo spazio.
Foto in alto: un’opera di Stefano Levi Della Torre



