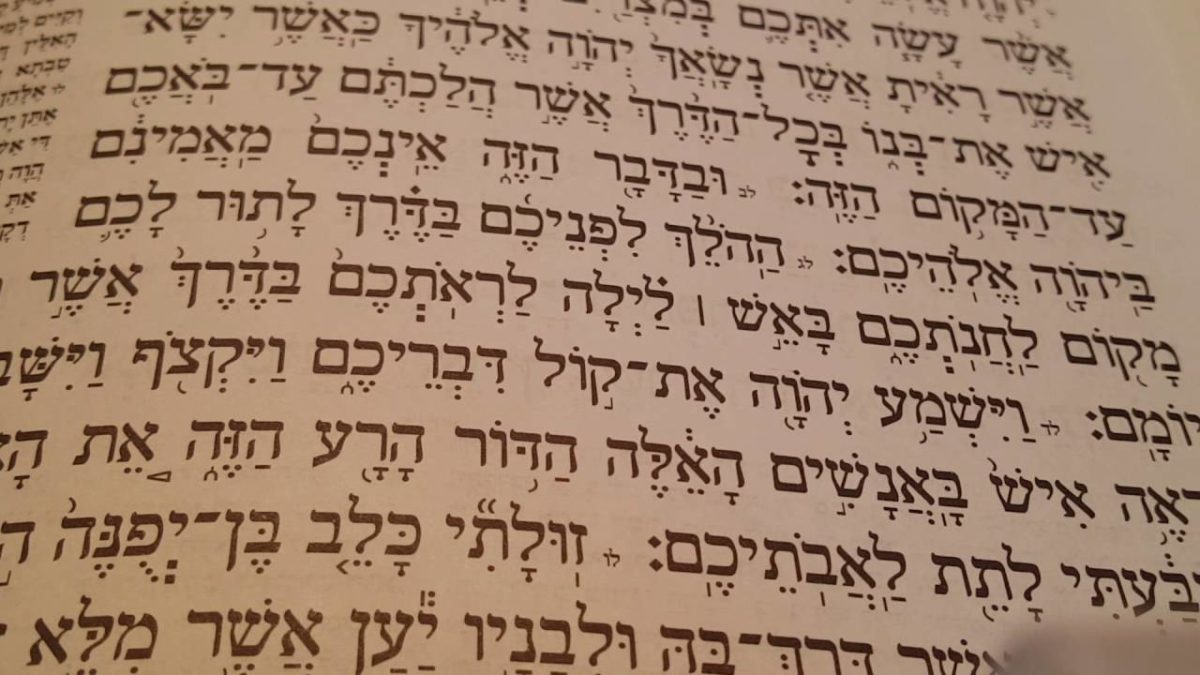Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
Odio e libertà non possono coesistere. Un popolo libero non odia i suoi ex nemici; se lo fa, non è ancora pronto alla libertà. Per creare una società non persecutoria da persone che sono state perseguitate, bisogna spezzare le catene del passato; togliere alla memoria il suo pungolo; sublimare il dolore in energia costruttiva e nella determinazione di edificare un futuro diverso.
“L’oscurità non può scacciare l’oscurità: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la violenza, e la durezza moltiplica la durezza…” Martin Luther King
Immagino che una delle ragioni per cui le persone si aggrappano così ostinatamente ai loro odi sia perché intuiscono che, una volta che l’odio sarà scomparso, saranno costrette a fare i conti con il dolore.” James Arthur Baldwin
C’è un verso in Ki Tetzè che è di enorme portata nelle sue implicazioni. È facile non notarlo, perché compare in mezzo a una serie di leggi varie riguardanti l’eredità, i figli ribelli, i buoi sovraccarichi, le violazioni matrimoniali e gli schiavi fuggitivi. Senza alcuna enfasi particolare o introduzione, Mosè pronuncia un comando così controintuitivo che dobbiamo leggerlo due volte per assicurarci di averlo sentito correttamente: “Non odiare un Edomita, perché è tuo fratello. Non odiare un Egiziano, perché sei stato straniero nella sua terra.” (Devarim 23:8)
Cosa significa questo nel suo contesto biblico? Gli Egiziani ai tempi di Mosè avevano ridotto in schiavitù gli Israeliti, “avevano reso amara la loro vita”, li avevano sottoposti a un regime spietato di duro lavoro e costretti a mangiare il pane dell’afflizione. Avevano intrapreso un programma di genocidio, con il Faraone che comandava al suo popolo di gettare “ogni figlio maschio [israelita] nato, nel fiume” (Shemot 1:22).
Ora, quarant’anni dopo, Mosè parla come se nulla di tutto ciò fosse accaduto, come se gli Israeliti dovessero agli Egiziani un debito di gratitudine per la loro ospitalità. Eppure lui e il popolo erano lì solo perché stavano fuggendo dalla persecuzione egiziana. Né Mosè voleva che il popolo lo dimenticasse. Al contrario, disse loro di raccontare ogni anno la storia dell’Esodo, come ancora facciamo a Pesach, rievocandola con erbe amare e pane azzimo, affinché la memoria fosse trasmessa a tutte le generazioni future. Se vuoi preservare la libertà, lascia intendere, non dimenticare mai cosa significa perderla.
Eppure qui, sulle rive del Giordano, parlando alla nuova generazione, dice al popolo: “Non odiare un Egiziano”. Cosa sta accadendo in questo verso? Per essere liberi, bisogna lasciar andare l’odio. Questo sta dicendo Mosè. Se avessero continuato a odiare i loro antichi nemici, Mosè avrebbe portato fuori gli Israeliti dall’Egitto, ma non avrebbe portato via l’Egitto dagli Israeliti. Mentalmente sarebbero stati ancora lì, schiavi del passato. Sarebbero rimasti incatenati, non da ferro ma dalla mente – e le catene della mente sono le più vincolanti di tutte.
Non puoi creare una società libera basandoti sull’odio. Risentimento, rabbia, umiliazione, senso di ingiustizia, desiderio di restaurare l’onore infliggendo ferite ai vecchi persecutori – queste sono condizioni di una profonda mancanza di libertà. Devi vivere con il passato, implica Mosè, ma non nel passato. Chi è prigioniero della collera verso i propri persecutori è prigioniero ancora. Chi lascia che i nemici definiscano chi egli è, non ha ancora raggiunto la libertà.
I libri di Mosè fanno continuamente riferimento all’Esodo e all’imperativo della memoria: “Ricorda che sei stato schiavo in Egitto”. Ma mai questo viene invocato come ragione per odio, rappresaglia o vendetta. Compare sempre come parte della logica della società giusta e compassionevole che gli Israeliti sono comandati di creare: l’ordine alternativo, l’antitesi dell’Egitto. Il messaggio implicito è: limita la schiavitù, almeno per quanto riguarda il tuo popolo. Non sottoporlo a lavori forzati. Dagli riposo e libertà ogni settimo giorno. Liberalo ogni settimo anno. Riconoscilo come simile a te, non ontologicamente inferiore. Nessuno nasce per essere schiavo.
Dai generosamente ai poveri. Lasciali mangiare degli avanzi del raccolto. Lascia un angolo del campo. Condividi le tue benedizioni con gli altri. Non privare le persone del loro sostentamento. L’intera struttura della legge biblica è radicata nell’esperienza della schiavitù in Egitto, come a dire: tu sai nel cuore cosa significa essere vittima di persecuzione, quindi non perseguitare gli altri.
L’etica biblica si basa su ripetuti atti di inversione di ruolo, usando la memoria come forza morale. Nei libri di Shemot e Devarim ci viene comandato di usare la memoria non per preservare l’odio, ma per vincerlo ricordando cosa significa esserne vittima. “Ricorda” – non per vivere nel passato, ma per prevenire una ripetizione del passato.
Solo così possiamo comprendere un dettaglio altrimenti inspiegabile nella stessa storia dell’Esodo. Nel primo incontro di Mosè con Dio al Roveto Ardente, gli viene affidata la missione di portare il popolo alla libertà. Dio aggiunge un particolare strano: “Farò sì che gli Egiziani siano benevoli verso questo popolo, così che quando partirete non andrete via a mani vuote. Ogni donna chiederà alla sua vicina e a qualsiasi donna che abita in casa sua oggetti d’argento e d’oro e vesti, che porrete sui vostri figli e sulle vostre figlie.” (Shemot 3:21-22)
Il punto viene ripetuto altre due volte (Shemot 11:2; 12:35). Eppure va completamente contro il senso della narrativa biblica. Dalla Genesi (14:23) al libro di Ester (9:10, 15, 16) prendere bottino, spoglie, prede dai nemici, è visto con disapprovazione. Nel caso degli idolatri è strettamente proibito: i loro beni sono cherem, tabù, da distruggere e non da possedere (Devarim 7:25; 13:16).
Quando, ai tempi di Yehoshua, Achan prese il bottino dalle rovine di Gerico, l’intera nazione fu punita. Inoltre, cosa accadde a quell’oro? Gli Israeliti finirono per usarlo per fare il vitello d’oro. Perché allora era importante – comandato – che in quell’unica occasione gli Israeliti chiedessero doni agli Egiziani? La Torà stessa fornisce la risposta in una legge successiva di Devarim sulla liberazione degli schiavi: “Se un tuo fratello ebreo, uomo o donna, si vende a te e ti serve sei anni, nel settimo anno lo lascerai andare libero. Quando lo liberi, non lo manderai via a mani vuote. Lo rifornirai generosamente dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio. Gli darai secondo la benedizione che il Signore tuo Dio ti ha concesso. Ricorda che sei stato schiavo in Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha riscattato. Per questo ti do oggi questo comando.”(Devarim 15:12-15)
La schiavitù ha bisogno di una “chiusura narrativa”. Per acquisire la libertà, uno schiavo deve poter lasciare alle spalle i sentimenti di antagonismo verso il suo padrone. Non deve partire gravato da rancore o rabbia, umiliazione o offesa. Se lo facesse, sarebbe stato liberato ma non redento. Fisicamente libero, mentalmente rimarrebbe schiavo. L’insistenza sul dono di congedo rappresenta l’intuizione psicologica della Bibbia sul trauma persistente della servitù. Ci deve essere un atto di generosità da parte del padrone affinché lo schiavo possa andarsene senza risentimento. La schiavitù lascia una cicatrice nell’anima che deve essere guarita.
Quando Dio disse a Mosè di dire agli Israeliti di prendere doni di congedo dagli Egiziani, era come se dicesse: sì, gli Egiziani vi hanno reso schiavi, ma questo sta per diventare il passato. Proprio perché voglio che ricordiate il passato, è essenziale che lo facciate senza odio né desiderio di vendetta. Ciò che dovete ricordare è il dolore di essere stati schiavi, non la rabbia verso i vostri padroni. Deve esserci un atto di chiusura simbolica. Questo non può essere giustizia nel senso più pieno della parola: tale giustizia è un’illusione, e il desiderio di essa insaziabile e autodistruttivo. Non c’è modo di restituire la vita ai morti, né di recuperare gli anni perduti della libertà negata. Ma neppure un popolo può negare il passato, cancellandolo dalla memoria. Se prova a farlo, alla fine ritornerà – il “ritorno del rimosso” di Freud – e chiederà un prezzo terribile sotto forma di vendetta altruistica e apparentemente nobile. Perciò l’ex padrone deve dare all’ex schiavo un dono, riconoscendolo come essere umano libero che ha contribuito, seppur senza scelta, al suo benessere. Non è un pareggio di conti. È piuttosto una forma minima di restituzione, di ciò che oggi chiamiamo “giustizia riparativa”.
Odio e libertà non possono coesistere. Un popolo libero non odia i suoi ex nemici; se lo fa, non è ancora pronto alla libertà. Per creare una società non persecutoria da persone che sono state perseguitate, bisogna spezzare le catene del passato; togliere alla memoria il suo pungolo; sublimare il dolore in energia costruttiva e nella determinazione di edificare un futuro diverso.
La libertà implica l’abbandono dell’odio, perché l’odio è l’abdicazione della libertà. È la proiezione dei nostri conflitti su una forza esterna che possiamo così incolpare, ma solo al costo di negare la responsabilità. Questo era il messaggio di Mosè a coloro che stavano per entrare nella Terra Promessa: una società libera può essere costruita solo da persone che accettano la responsabilità della libertà, soggetti che rifiutano di vedersi come oggetti, persone che si definiscono attraverso l’amore di Dio, non attraverso l’odio dell’altro.
“Non odiare un Egiziano, perché sei stato straniero nella sua terra”, disse Mosè, intendendo: per essere liberi, dovete lasciar andare l’odio.
Scritto da Rabbi Sacks nel 2012