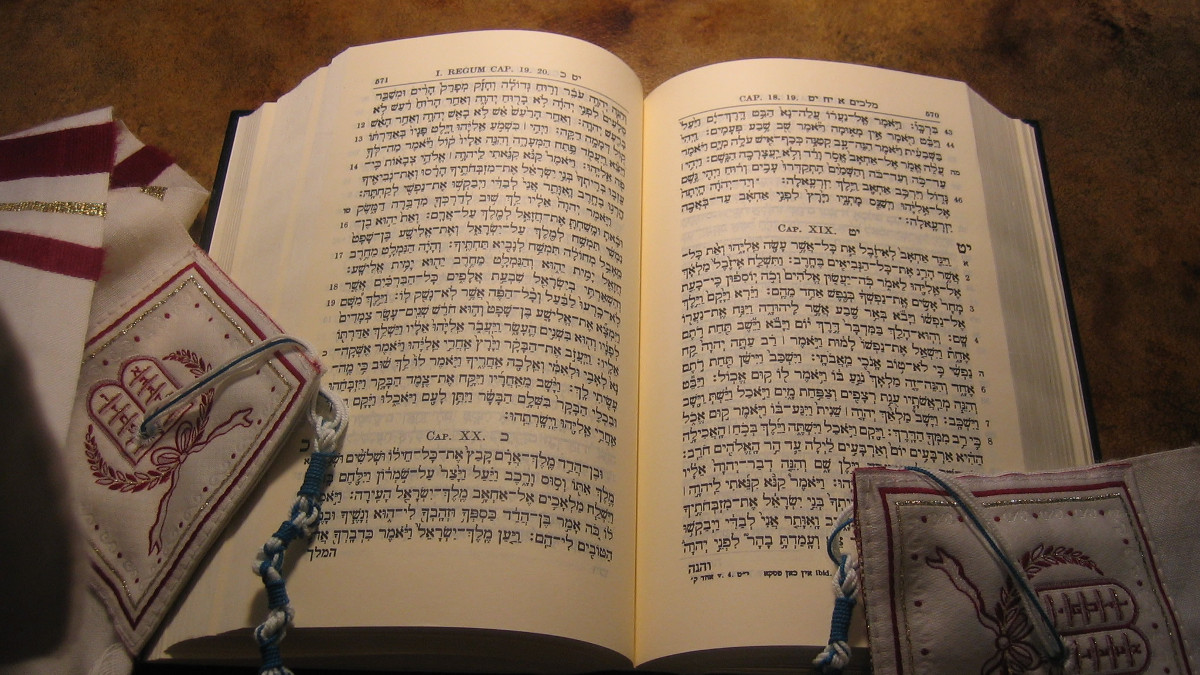Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
Avendo esposto i principi generali del patto, Mosè passa ora ai dettagli, che si estendono per molti capitoli e diverse parashot. La lunga rassegna delle leggi che governeranno Israele nella sua terra inizia e termina con Mosè che pone davanti al popolo una scelta epocale. Ecco come la formula nella parashà di questa settimana: «Vedi, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione: la benedizione se obbedirete ai comandi del Signore vostro Dio che oggi vi do; la maledizione se non obbedirete ai comandi del Signore vostro Dio e devierete dalla via che oggi vi prescrivo, andando dietro ad altri dèi che non avete conosciuto». (Deuteronomio 11:26-28)
E così la presenta alla fine: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male… Io chiamo oggi in testimoni contro di voi il cielo e la terra: ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza». (Deuteronomio 30:15, 19)
Maimonide prende questi due passi come prova del nostro credo nel libero arbitrio (Hilchot Teshuvah 5:3), e in effetti lo sono. Ma sono anche di più: costituiscono un’affermazione politica. Il nesso tra la libertà individuale (di cui parla Maimonide) e la scelta collettiva (di cui parla Mosè) è questo: se l’essere umano è libero, allora ha bisogno di una società libera in cui esercitare quella libertà. Il libro di Devarim rappresenta il primo tentativo nella storia di creare una società libera.
La visione di Mosè è profondamente politica, ma in modo unico. Non è politica intesa come ricerca del potere, difesa di interessi, preservazione di classi o caste. Non è politica come espressione di gloria nazionale o di fama. Nelle parole di Mosè non c’è desiderio di onore, di espansione, di impero. Non vi è traccia di nazionalismo nel senso convenzionale. Mosè non dice al popolo che esso è grande. Dice invece che è stato ribelle, che ha peccato, e che la mancanza di fede durante l’episodio delle spie è costata quarant’anni di ritardo prima di entrare nella terra. Mosè non avrebbe vinto un’elezione: non era quel tipo di leader.
Al contrario, egli richiama il popolo all’umiltà e alla responsabilità. In sostanza dice: noi siamo la nazione scelta da Dio per un grande esperimento. Possiamo creare una società che non sia l’Egitto, non sia un impero, non sia divisa in governanti e governati? Possiamo rimanere fedeli alla Mano più che umana che ha guidato il nostro destino da quando mi sono presentato davanti al Faraone per chiedere la nostra libertà? Perché se crediamo veramente in Dio – non in Dio come astrazione filosofica, ma in Dio la cui scrittura è impressa nella nostra storia, in Dio al quale abbiamo giurato fedeltà al Sinai, in Dio che è il nostro unico sovrano – allora possiamo compiere grandi cose.
Non grandi in senso convenzionale, ma grandi in senso morale. Perché se tutta la forza, la ricchezza e la potenza appartengono a Dio, allora nessuna di queste cose può legittimamente separarci l’uno dall’altro. Siamo tutti ugualmente preziosi ai Suoi occhi. Egli ci ha incaricato di sfamare i poveri, di includere orfani e vedove, il levita senza terra e lo straniero non israelita nelle nostre feste e nei nostri giorni di riposo. Ci ha comandato di costruire una società giusta che onori la dignità e la libertà umana.
Mosè insiste su tre cose.
Primo: siamo liberi. La scelta è nostra. Benedizione o maledizione? Bene o male? Fedeltà o infedeltà? «Decidete voi», dice Mosè. Mai la libertà era stata definita in modo così netto, non solo per l’individuo, ma per l’intera nazione. Non ci è difficile capire che come individui siamo posti davanti a scelte morali: lo furono Adamo ed Eva, lo fu Caino. La scelta è iscritta nella condizione umana.
Ma sentirlo dire a un’intera nazione – questo è nuovo. Non c’è difesa, dice Mosè, nell’affermare impotenza: «Non potevamo farci nulla. Eravamo in minoranza. Siamo stati sconfitti. È colpa dei nostri capi o dei nostri nemici». No, dice Mosè: il vostro destino è nelle vostre mani. La sovranità di Dio non elimina la responsabilità umana. Al contrario, la mette al centro. Se sarete fedeli a Dio, dice Mosè, prevarrete sugli imperi. Se non lo sarete, nient’altro – né la forza militare né le alleanze politiche – vi aiuterà.
Se tradirete il vostro destino unico, se adorerete gli dèi delle nazioni circostanti, allora diventerete come loro e subirete la sorte di tutte le piccole nazioni nell’era delle superpotenze. Non date la colpa ad altri, al caso o alla sfortuna per la vostra sconfitta. La scelta è vostra; la responsabilità è solo vostra.
Secondo: siamo collettivamente responsabili. La frase rabbinica «Tutti gli Israeliti sono garanti l’uno dell’altro» trova già la sua radice nella Torà. Anche questo è radicale. Non c’è nell’ebraismo una «teoria del grande uomo» della storia, nulla di simile a ciò che Carlyle (scrittore scozzese 1775-1881) chiamava «eroi e culto degli eroi». Il destino di Israele dipende dalla risposta di Israele, di tutto Israele, «dai capi delle vostre tribù, i vostri anziani e i vostri ufficiali» fino ai vostri «tagliatori di legna e portatori d’acqua». Qui nasce la famosa formula americana – assente dal vocabolario politico britannico – «We, the people». Diversamente da tutte le altre nazioni del mondo antico, e da molte ancora oggi, il popolo del patto non credeva che il suo destino dipendesse da re, imperatori, corti reali o élite di governo. Dipendeva da ciascuno di noi come agenti morali, congiuntamente responsabili per il bene comune. Questo è ciò che Michael Walzer (filosofo statunitense 1935-…) intende quando – nel suo libro In God’s Shadow: Politics in the Hebrew Bible – definisce Israele biblico una «quasi-democrazia».
Terzo: è una politica centrata su Dio. Non esisteva un termine per questo nel mondo antico, così Giuseppe Flavio dovette inventarne uno: «teocrazia». Ma questa parola è stata spesso abusata, interpretata come «governo dei profeti, sacerdoti». Non è questo Israele. Viene piuttosto in mente l’espressione americana «one nation under God» (una nazione sotto Dio). Se c’è una parola che rende giustizia alla visione di Deuteronomio, non è teocrazia ma nomocrazia: «il governo delle leggi, non degli uomini».
Israele biblico è il primo esempio storico di tentativo di creare una società libera. Non libera nel senso moderno di «libertà di coscienza» – concetto nato nel XVII secolo in Europa dopo un secolo di guerre religiose tra cattolici e protestanti. Quella libertà era la risposta alla domanda: come possono persone con credi religiosi diversi convivere pacificamente? Israele biblico rispondeva a un’altra domanda: come possono libertà e responsabilità essere condivise equamente da tutti? Come possono essere posti limiti al potere dei governanti che tendono a trasformare il popolo in massa di servi – non necessariamente schiavi letterali, ma forza lavoro per costruire monumenti o guerre imperiali?
Il grande storico dell’Ottocento Lord Acton vide giustamente che la libertà in questo senso nacque in Israele biblico: «Il governo degli Israeliti era una federazione, mantenuta non da un’autorità politica ma dall’unità di stirpe e di fede, e fondata non sulla forza fisica ma su un patto volontario… Il trono era eretto su un patto, e al re era negato il diritto di legiferare tra un popolo che non riconosceva alcun legislatore se non Dio… Gli uomini ispirati che sorsero in successione per profetizzare contro usurpatori e tiranni proclamarono costantemente che le leggi, divine, erano superiori ai governanti peccatori… Così l’esempio della nazione ebraica tracciò le linee parallele sulle quali si è conquistata ogni libertà».
È un’idea bellissima, potente, impegnativa. Se Dio è il nostro unico sovrano, allora ogni potere umano è delegato, limitato, soggetto a vincoli morali. Gli ebrei furono i primi a credere che un’intera nazione potesse governarsi in libertà e dignità eguale. Questo non ha a che fare con le forme politiche (monarchia, oligarchia, democrazia – gli ebrei le hanno provate tutte), ma con la responsabilità morale collettiva.
Gli ebrei non realizzarono mai del tutto questa visione, ma non cessarono mai di esserne ispirati. Le parole di Mosè continuano a sfidarci ancora oggi. Dio ci ha dato la libertà. Usiamola per costruire una società giusta, generosa, misericordiosa. Dio non lo fa al posto nostro, ma ci ha insegnato come si fa. Come disse Mosè: la scelta è nostra.
Scritto da Rabbi Jonathan Sacks, 2012