di Fiona Diwan
La tunica colorata di Giuseppe, segno inequivocabile della predilezione che il padre Giacobbe ha per lui e che innescherà la tragedia della gelosia dei fratelli. Giuseppe il sognatore, la cui grazia e bellezza fa invaghire tutte le donne. Giuseppe l’interprete dei sogni, le cui peripezie ne accrescono la grandezza, a chi ogni sgambetto del destino regala una possibilità di rinascita. L’eroe-vittima che dal pozzo profondo dove giace riesce a risalire e a ribaltare la propria sorte diventando ministro plenipotenziario d’Egitto: un eroe-vittima che non si ribella al suo destino ma che cerca di contrastarlo con virtù e saggezza, molto diverso dall’archetipo incarnato dal padre Giacobbe, l’eroe-cercatore caratterizzato da astuzia e iniziativa.
Archetipo letterario e paradigma etico, la vicenda di Giuseppe è un ventaglio di temi l’uno più appassionante dell’altro: ripropone il tema del destino del fratello minore che sottrae l’eredità ai fratelli maggiori (come Giacobbe con Esaù, Isacco con Ismaele). I temi – cari alla letteratura antica -, del valore dell’umiltà superiore all’onore, la capacità di astenersi dalle passioni, la rinuncia alla vendetta, la vanagloria giovanile ridimensionata dalle disavventure della vita che ne fanno un uomo nuovo e saggio. Un modello anche per altre storie del Tanach: è il comune denominatore dell’esilio, ad esempio, con le vicende di Daniele e Ester, quest’ultima che soccorre il proprio popolo in difficoltà come farà appunto Giuseppe, portando così a compimento un disegno divino.
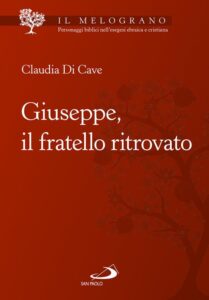 Con perizia e erudizione, Claudia Di Cave scandaglia tutte le fonti possibili: dai rotoli di Qumran a Filone di Alessandria, dalle fonti letterarie e non bibliche (ad esempio uno dei primi romanzi scritti in greco antico è dedicato proprio alla storia di Giuseppe), agli intrecci tra storie bibliche e filosofia stoica, tipici dell’ambiente giudaico ellenizzato di Alessandria, con le sue riflessioni su virtù e vizi, che influenzarono i primi cristiani delle origini. Fino ai midrashim, sia aggadhici sia halachici, ivi comprese le interpretazioni sulla base delle analogie linguistiche e della tecnica al tiqra ela fondata sulla possibilità di modificare sillabe e vocali e sul cambiamento dell’ordine delle lettere, una tecnica che fa esplodere il significato e apre la porta a un’intertestualità ricchissima. E poi le fonti cristiane e dei padri della chiesa, da Agostino di Ippona a Ambrogio vescovo di Milano a Cesario di Arles che, “cristianizzando” Giuseppe, vedranno in lui una prefigurazione della figura di Gesù e uno speculum castitatis, ovvero colui che ha la capacità di esercitare un controllo morale su di sé. Prassi ermeneutiche a confronto quindi, laddove l’autrice ci consente di osservare da vicino come si è costruita la “teologia della sostituzione”.
Con perizia e erudizione, Claudia Di Cave scandaglia tutte le fonti possibili: dai rotoli di Qumran a Filone di Alessandria, dalle fonti letterarie e non bibliche (ad esempio uno dei primi romanzi scritti in greco antico è dedicato proprio alla storia di Giuseppe), agli intrecci tra storie bibliche e filosofia stoica, tipici dell’ambiente giudaico ellenizzato di Alessandria, con le sue riflessioni su virtù e vizi, che influenzarono i primi cristiani delle origini. Fino ai midrashim, sia aggadhici sia halachici, ivi comprese le interpretazioni sulla base delle analogie linguistiche e della tecnica al tiqra ela fondata sulla possibilità di modificare sillabe e vocali e sul cambiamento dell’ordine delle lettere, una tecnica che fa esplodere il significato e apre la porta a un’intertestualità ricchissima. E poi le fonti cristiane e dei padri della chiesa, da Agostino di Ippona a Ambrogio vescovo di Milano a Cesario di Arles che, “cristianizzando” Giuseppe, vedranno in lui una prefigurazione della figura di Gesù e uno speculum castitatis, ovvero colui che ha la capacità di esercitare un controllo morale su di sé. Prassi ermeneutiche a confronto quindi, laddove l’autrice ci consente di osservare da vicino come si è costruita la “teologia della sostituzione”.
Inoltre, infine, attraverso la figura di Giuseppe e alla puntigliosa analisi etimologica e filologica, Claudia Di Cave riesce a far sì che Atene e Gerusalemme si guardino negli occhi: la formazione classica dell’autrice (docente di greco e latino), la sua conoscenza delle fonti primarie e dell’approccio esegetico ebraico le permettono di far viaggiare in parallelo mondo ebraico e mondo greco, in un interessante gioco di rimandi tra i due universi fondativi della cultura occidentale. Un testo approfondito, esaustivo e prezioso, pieno di spunti di riflessione su uno dei personaggi più sfaccettati della tradizione ebraica.
Claudia Di Cave, Giuseppe, il fratello ritrovato, San Paolo, pp. 204, 18,00 euro.


