di Nathan Greppi
Tra eredità contese, matrimoni combinati, travestimenti e comicità, un’avvincente commedia romantica, ricca di colpi di scena, ci trasporta nel cuore della Mantova rinascimentale. La commedia del fidanzamento vanta un primato: è il primo testo teatrale della storia scritto in lingua ebraica
Quando parliamo della letteratura in lingua ebraica, pensiamo soprattutto a quella contemporanea, successiva alla nascita d’Israele. Tuttavia, già secoli fa in Italia si potevano trovare opere letterarie e teatrali in ebraico, che in alcuni casi sono state semi-dimenticate dal pubblico.
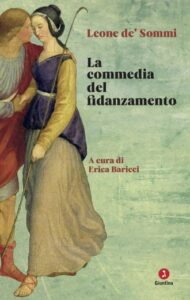 Un testo che in origine era stato realizzato in ebraico da un autore italiano e che è stato recentemente riportato in auge è La commedia del fidanzamento, opera teatrale scritta intorno al 1560 dal poeta e drammaturgo ebreo mantovano Leone De’ Sommi (1525 – 1590), che dopo quasi mezzo millennio è stata recentemente tradotta per la prima volta integralmente in italiano, in un’edizione curata per la casa editrice Giuntina dalla linguista e traduttrice Erica Baricci, docente di lingua e cultura ebraica presso varie istituzioni accademiche nel milanese e nel comasco.
Un testo che in origine era stato realizzato in ebraico da un autore italiano e che è stato recentemente riportato in auge è La commedia del fidanzamento, opera teatrale scritta intorno al 1560 dal poeta e drammaturgo ebreo mantovano Leone De’ Sommi (1525 – 1590), che dopo quasi mezzo millennio è stata recentemente tradotta per la prima volta integralmente in italiano, in un’edizione curata per la casa editrice Giuntina dalla linguista e traduttrice Erica Baricci, docente di lingua e cultura ebraica presso varie istituzioni accademiche nel milanese e nel comasco.
Introdotta da una prefazione di Paolo Luca Bernardini, docente ordinario di storia moderna presso l’Università dell’Insubria, la commedia possiede sia il tipico sviluppo delle commedie dell’antichità classica sia le caratteristiche proprie della commedia erudita del Rinascimento.
Al centro della narrazione vi è un amore sconfinato tra due giovani fidanzati, Yedidiah e Beruriah, che sono sul punto di sposarsi quando il padre di lui muore all’improvviso, senza lasciargli alcuna eredità. A quel punto, i genitori della sposa si oppongono all’idea che lei si sposi con un ragazzo rimasto senza niente, e cercano di annullare il fidanzamento. Sullo sfondo, seguono tutta una serie di intrighi ed equivoci, mentre il saggio rabbino Amittay cerca di riportare pace e armonia tra i due innamorati.
Quest’opera ricopre un ruolo decisamente particolare nella storia del teatro e della letteratura ebraica, così come in quella del teatro italiano. Questo perché La commedia del fidanzamento è il primo testo teatrale della storia scritto in lingua ebraica, perlomeno tra quelli di cui si hanno notizie certe.
Prima della traduzione in lingua italiana, nel 1965 ne era già stata pubblicata un’edizione critica nella lingua originale, curata dallo studioso israeliano Hayyim Schirmann, esperto di letteratura ebraica medievale. Mentre negli anni ’80, ne era uscita una traduzione in inglese, che però era stata fortemente rielaborata in quanto pensata per essere nuovamente messa in scena, più che per motivi di studio accademico.
L’autore, Leone De’ Sommi, era un ebreo che intorno alla metà del ‘500 era stato il corago, ovverosia il regista teatrale, presso la corte dei Gonzaga, i quali in quel periodo erano i duchi di Mantova. Oltre ad aver realizzato numerose commedie in italiano, ne scrisse anche una in ebraico che successivamente è stata tramandata ai posteri, a dimostrazione che era una figura assai all’avanguardia per la sua epoca, studiata sia dagli italianisti che dagli ebraisti. E dal modo in cui tratta il tema del matrimonio, si capisce che De’ Sommi era un profondo conoscitore della Halakhah e delle leggi ebraiche.
La commedia del fidanzamento non è solo un’opera per studiosi e accademici, ma è anche e soprattutto una commedia romantica assai avvincente e ricca di colpi di scena, che riesce a trasportare il lettore nel cuore della Mantova rinascimentale. E proprio per questo, si spera che prima o poi questa prima edizione in italiano venga portata sul palcoscenico, facendo rivivere certe atmosfere dopo quasi 500 anni.
La commedia del fidanzamento, traduzione e a cura di Erica Baricci, prefazione di Paolo L. Bernardini, Giuntina, pp. 256,
euro 18,00.



