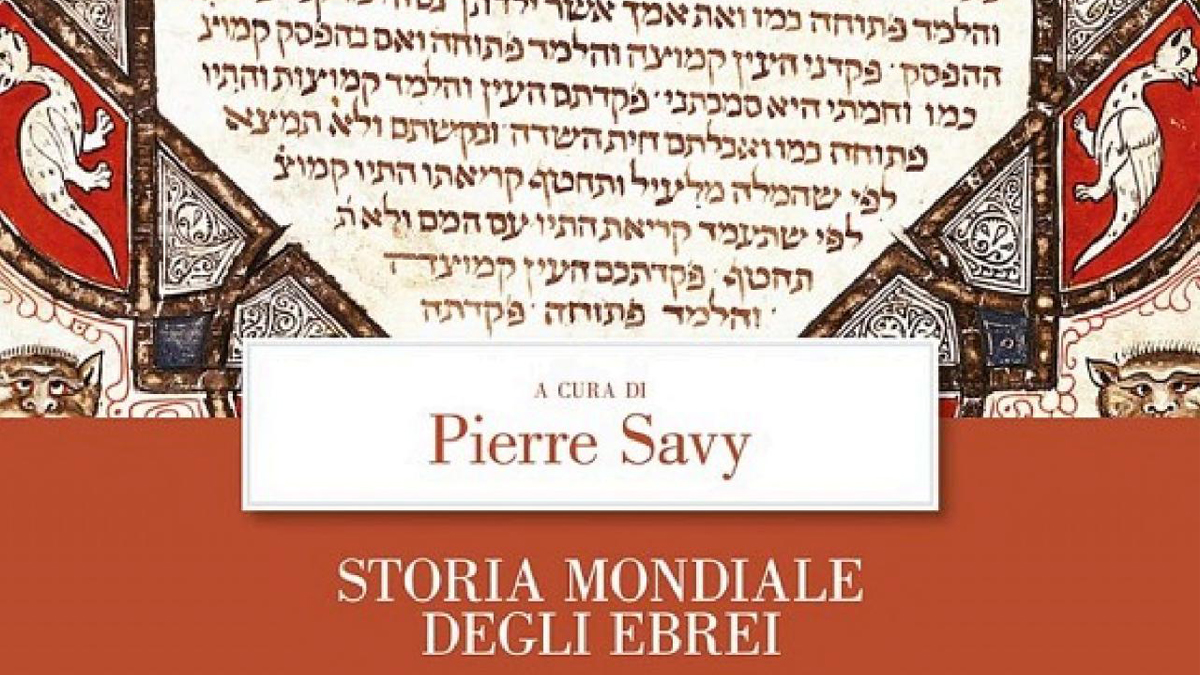di Ugo Volli
[Scintille. Letture e riletture]
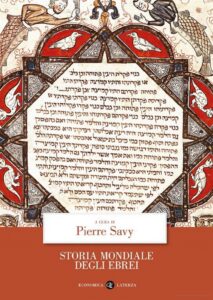 Il rapporto del popolo ebraico con la sua memoria storica è del tutto particolare. Non vi sono, che io sappia, altri popoli che celebrano ogni anno con commozione eventi militari o politici accaduti millenni fa e che li considerano come fatti ancora pertinenti, esempi da cui trarre orientamenti attuali. Gli ebrei lo fanno: l’uscita dell’Egitto, l’assedio babilonese di Gerusalemme, la sconfitta di un tentativo di genocidio alla corte persiana, la rivolta contro gli occupanti ellenistici e romani e altri episodi storici ancora sono occasioni di lutto e digiuno o di festa e esultanza, secondo i casi. Questa presenza continua della memoria storica orienta buona parte della liturgia ed è una ragione centrale della straordinaria capacità di resistenza e di durata del popolo ebraico. Si manifesta così una profondità temporale della storia ebraica grande come la sua rilevanza percepita. La Torà stessa e poi il complesso delle Scritture ebraiche hanno in buona parte forma storica, ricostruendo la vicenda del popolo ebraico fino alla ricostruzione del Tempio sotto l’impero persiano – naturalmente secondo metodi e obiettivi spesso assai diversi dalla storiografia contemporanea. Nessuna meraviglia dunque che le narrazioni storiche siano continuate in varia forma fino a oggi e anzi siano diventate particolarmente abbondanti negli ultimi decenni. Le molteplici vicende della lunga diaspora, l’affermazione del sionismo, la Shoah e la rinascita dello Stato di Israele hanno suggerito ricerche e riflessioni su questo argomento, tante da riempire biblioteche. Naturalmente tutta questa produzione, soprattutto per quanto riguarda le storie non locali o settoriali ma generali, ha valore e interesse assai diverso.
Il rapporto del popolo ebraico con la sua memoria storica è del tutto particolare. Non vi sono, che io sappia, altri popoli che celebrano ogni anno con commozione eventi militari o politici accaduti millenni fa e che li considerano come fatti ancora pertinenti, esempi da cui trarre orientamenti attuali. Gli ebrei lo fanno: l’uscita dell’Egitto, l’assedio babilonese di Gerusalemme, la sconfitta di un tentativo di genocidio alla corte persiana, la rivolta contro gli occupanti ellenistici e romani e altri episodi storici ancora sono occasioni di lutto e digiuno o di festa e esultanza, secondo i casi. Questa presenza continua della memoria storica orienta buona parte della liturgia ed è una ragione centrale della straordinaria capacità di resistenza e di durata del popolo ebraico. Si manifesta così una profondità temporale della storia ebraica grande come la sua rilevanza percepita. La Torà stessa e poi il complesso delle Scritture ebraiche hanno in buona parte forma storica, ricostruendo la vicenda del popolo ebraico fino alla ricostruzione del Tempio sotto l’impero persiano – naturalmente secondo metodi e obiettivi spesso assai diversi dalla storiografia contemporanea. Nessuna meraviglia dunque che le narrazioni storiche siano continuate in varia forma fino a oggi e anzi siano diventate particolarmente abbondanti negli ultimi decenni. Le molteplici vicende della lunga diaspora, l’affermazione del sionismo, la Shoah e la rinascita dello Stato di Israele hanno suggerito ricerche e riflessioni su questo argomento, tante da riempire biblioteche. Naturalmente tutta questa produzione, soprattutto per quanto riguarda le storie non locali o settoriali ma generali, ha valore e interesse assai diverso.
Alcuni di questi lavori si propongono scopi di edificazione o di onesta divulgazione, altri puntano ad essere il più possibile completi e ben documentati, altri ancora cercano un punto di vista o una modalità narrativa originale e meritano di essere segnalati. Fra questi ultimi è uscito in italiano meno di due anni fa un volume a cura di Pierre Savy che l’editore Laterza ha voluto intitolare Storia mondiale degli Ebrei, ma la cui novità risulta meglio dal titolo originale Histoire des Juifs- un voyage en 80 dates de l’antiquité a nos jours. Si tratta infatti di ottanta brevi saggi di autori diversi e di diverso valore, incentrati ciascuno su un anno e su un evento. Il rischio di questa impostazione è evidente: le date sono tutte uguali, i saggi della stessa lunghezza, che si tratti della “conversione della famiglia reale di Adiabene” o dell’assedio babilonese di Gerusalemme, della redazione del Talmud o delle poesie di Debora Corcos Ascarelli, del primo congresso sionista a Basilea o della conferenza di Czernovich sulla lingua Yiddish, lo spazio è lo stesso. Inoltre i fenomeni complessi e di lunga durata rischiano di sfuggire a questa griglia o di essere riassunti in una data un po’ casuale. Il testo è infine un po’ troppo francocentrico nel periodo moderno, e l’adattamento italiano a cura di Anna Foa non ha saputo porre rimedio a questo limite, aggiungendo solo qualche episodio italiano tutto sommato minore. E però in questa dispersione c’è un vantaggio: numerosi episodi secondari che di solito sono ignorati incuriosiscono e arricchiscono di dettagli il grande quadro della storia ebraica.