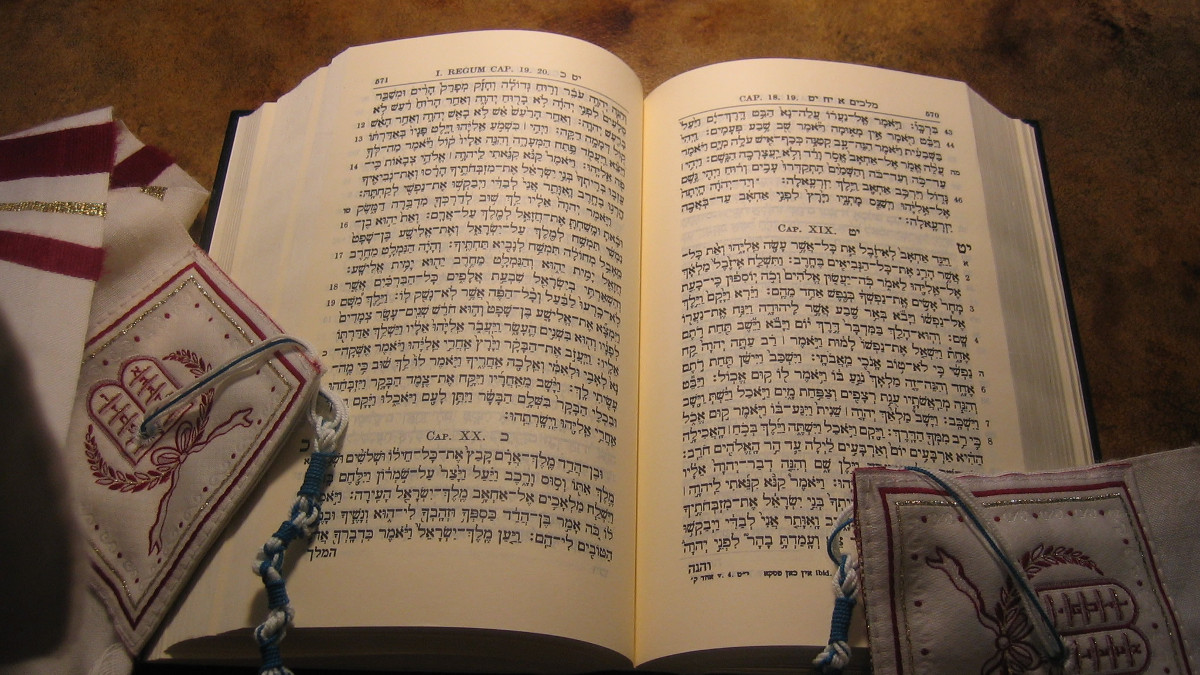Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò
L’amore senza giustizia porta alla rivalità e, alla fine, all’odio. La giustizia senza amore è priva delle forze umanizzanti della compassione e della misericordia. Abbiamo bisogno di entrambe. Questa visione etica unica – l’amore di Dio per gli uomini e degli uomini per Dio, tradotto in un’etica di amore verso il prossimo e lo straniero – è il fondamento della civiltà occidentale e la sua gloria duratura.
Qualcosa che nella Torà è implicito fin dall’inizio, diventa esplicito nel libro di Devarim: Dio è il Dio dell’amore. Più di quanto noi amiamo Lui, Egli ama noi. Ecco, per esempio, l’inizio della parashà di questa settimana: “Se darete ascolto a queste leggi e le osserverete con cura, allora il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il Suo patto d’amore [et ha-brit ve-et ha-chessed], come giurò ai vostri padri. Egli vi amerà, vi benedirà e vi moltiplicherà.” (Devarim 7:12-13)
Ancora nella parashà leggiamo: “Al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che contiene. Eppure il Signore si è affezionato ai vostri padri e li ha amati, e ha scelto voi, loro discendenti, sopra tutti i popoli, come avviene oggi.” (Devarim 10:14-15)
E dalla parashà della settimana scorsa: “Poiché Egli ha amato i tuoi padri e ha scelto i loro discendenti dopo di loro, ti ha fatto uscire dall’Egitto con la Sua Presenza e con la Sua grande forza.” (Devarim 4:37)
Il libro di Devarim è intriso del linguaggio dell’amore. La radice a-h-v compare in Shemot due volte, in Vayikra due volte (entrambe in Vayikra 19), in Bamidbar mai, ma in Sefer Devarim ben 23 volte. Devarim è un libro sulla beatitudine sociale e sul potere trasformativo dell’amore.
Nulla potrebbe essere più fuorviante e ingiusto del contrasto cristiano tra il Cristianesimo come religione dell’amore e del perdono e l’Ebraismo come religione della legge e della retribuzione. Come ho fatto notare in un precedente commento in “Covenant & Conversation” per Vayigash, il perdono nasce – come osserva David Konstan (1940-2024 classicista e accademico americano) in Before Forgiveness – nell’Ebraismo. Il perdono interpersonale inizia quando Yosef perdona i suoi fratelli per averlo venduto come schiavo. Il perdono divino comincia con l’istituzione di Yom Kippur come giorno supremo dell’esposizione, a seguito del peccato del Vitello d’Oro.
Allo stesso modo per l’amore: quando il Nuovo Testamento parla di amore, lo fa citando direttamente il Levitico (“Amerai il tuo prossimo come te stesso”) e il Deuteronomio (“Amerai il Signore tuo Dio gcon tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze”). Come afferma il filosofo Simon May (1944-…) nel suo splendido libro Love: A History: “La diffusa convinzione che la Bibbia ebraica riguardi solo la vendetta e ‘occhio per occhio’, mentre i Vangeli avrebbero inventato l’amore come valore incondizionato e universale, deve essere considerata come uno dei più straordinari fraintendimenti di tutta la storia occidentale. Infatti, la Bibbia ebraica è la fonte non solo dei due comandamenti dell’amore, ma di una più ampia visione morale ispirata dallo stupore per la potenza dell’amore.”
Il suo giudizio è inequivocabile: “Se l’amore nel mondo occidentale ha un testo fondativo, quel testo è l’ebraico.” Oltre a questo: in Ethical Life: The Past and Present of Ethical Cultures, il filosofo Harry Redner distingue quattro visioni fondamentali della vita etica nella storia delle civiltà. Una la chiama etica civica, l’etica dell’antica Grecia e Roma. La seconda è l’etica del dovere, che identifica con il Confucianesimo, il Krishnaismo e lo Stoicismo tardo. La terza è l’etica dell’onore, unione particolare di decoro cortese e militare che si trova tra Persiani, Arabi e Turchi, come anche nel Cristianesimo medievale (il “cavaliere cavalleresco”) e nell’Islam. La quarta, che chiama semplicemente moralità, la fa risalire al Levitico e al Deuteronomio. La definisce semplicemente come “l’etica dell’amore” e rappresenta ciò che ha reso moralmente unica la civiltà occidentale: “L’amore del prossimo’ biblico è una forma di amore molto speciale, uno sviluppo unico della religione giudaica e senza paragoni al di fuori di essa. È un amore supremamente altruistico, poiché amare il prossimo come se stessi significa sempre mettersi nei suoi panni e agire in suo favore così come naturalmente e istintivamente si agirebbe in proprio favore.”
Certamente, anche il Buddhismo dà spazio all’idea di amore, ma con un’impronta diversa, più impersonale e priva di relazione con Dio.
Ciò che è radicale in questa idea è che, innanzitutto, la Torà afferma – contro quasi tutto il mondo antico – che gli elementi che costituiscono la realtà non sono né ostili né indifferenti all’umanità. Siamo qui perché Qualcuno ha voluto che fossimo qui, Qualcuno che si prende cura di noi, veglia su di noi e cerca il nostro bene.
In secondo luogo, l’amore con cui Dio ha creato l’universo non è solo divino. Deve servire da modello per noi come esseri umani. Ci è comandato di amare il prossimo e lo straniero, di compiere atti di bontà e compassione e di costruire una società basata sull’amore. Così dice la nostra parashà: “Poiché il Signore, vostro Dio, è Dio degli dèi e Signore dei signori, il Dio grande, potente e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali. Egli fa giustizia all’orfano e alla vedova, ama lo straniero, dandogli pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nella terra d’Egitto.” (Devarim 10:18-19)
In breve: Dio ha creato il mondo nell’amore e nel perdono e ci chiede di amare e perdonare gli altri. Credo che questa sia la più profonda idea morale della storia umana.
Sorge però una domanda ovvia: perché l’amore, che ha un ruolo così grande nel libro di Devarim, è così meno evidente nei libri precedenti di Shemot, Vayikra (eccetto il capitolo 19) e Bamidbar? Il modo migliore di rispondere è porre un’altra domanda: perché il perdono non compare affatto – almeno in superficie – nel libro di Bereshit? Dio non perdona Adam ed Eva, né Caino (anche se mitiga le loro pene). Il perdono non compare nei racconti del Diluvio, della Torre di Babele o della distruzione di Sodoma e delle città della pianura (la supplica di Avraham è che le città siano risparmiate se contengono cinquanta o dieci giusti; non è una richiesta di perdono). Il perdono divino fa la sua prima comparsa nel libro di Shemot dopo l’intercessione di Mosè a seguito del Vitello d’Oro, e viene poi istituzionalizzato sotto forma di Yom Kippur (Vayikra 16), ma non prima. Perché? La risposta semplice e radicale è: Dio non perdona gli esseri umani finché gli esseri umani non imparano a perdonarsi tra loro. Bereshit si conclude con Yosef che perdona i suoi fratelli. Solo dopo Dio perdona gli uomini.
Passando all’amore: Bereshit ne contiene molti riferimenti. Avraham ama Yitzchak. Yitzchak ama Esav. Rivqà ama Yaakov. Yaakov ama Rachel. Ama anche Yosef. C’è abbondanza di amore interpersonale. Ma quasi tutti gli amori di Bereshit si rivelano divisivi. Portano tensione tra Yaakov ed Esav, tra Rachel e Leah, e tra Yosef e i suoi fratelli. Implicita in Bereshit vi è un’osservazione profonda, sfuggita alla maggior parte dei moralisti e dei teologi: l’amore di per sé – amore vero, personale e appassionato, come quello che permea gran parte della letteratura profetica e lo Shir HaShirim, il più grande canto d’amore del Tanach – non è sufficiente come base per una società. Può dividere tanto quanto unire.
Per questo non appare come motivo centrale fino alla visione integrata socio-morale-politica di Devarim, che unisce amore e giustizia. Tzedek – giustizia – risulta essere un’altra parola chiave di Devarim, ricorrendo 18 volte. In Shemot appare solo quattro volte, mai in Bamidbar, e in Vayikra solo nel capitolo 19, l’unico che contiene anche la parola “amore”. In altre parole, nell’Ebraismo amore e giustizia vanno di pari passo. Ancora Simon May nota: “[…] ciò che dobbiamo notare qui, poiché è fondamentale per la storia dell’amore occidentale, è la notevole e radicale giustizia che sta alla base del comandamento dell’amore in Levitico. Non una giustizia fredda in cui si distribuiscono meccanicamente le pene dovute, ma la giustizia che porta l’altro, come individuo con bisogni e interessi, in una relazione di rispetto. Tutti i nostri prossimi devono essere riconosciuti come uguali a noi davanti alla legge dell’amore. Giustizia e amore diventano quindi inseparabili.”
L’amore senza giustizia porta alla rivalità e, alla fine, all’odio. La giustizia senza amore è priva delle forze umanizzanti della compassione e della misericordia. Abbiamo bisogno di entrambe. Questa visione etica unica – l’amore di Dio per gli uomini e degli uomini per Dio, tradotto in un’etica di amore verso il prossimo e lo straniero – è il fondamento della civiltà occidentale e la sua gloria duratura. Nasce qui, nel libro di Devarim, il libro della legge-come-amore e dell’amore-come-legge.
Scritto da Rabbi Jonathan Sacks, 2012